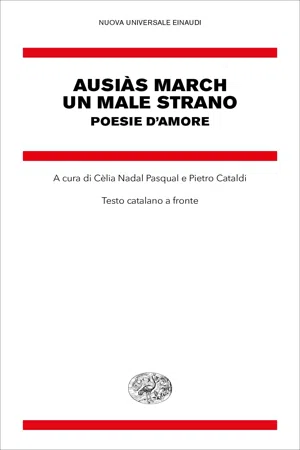
Un male strano
Poesie d'amore
Ausias March, Pietro Cataldi, Cèlia Nadal Pasqual, Pietro Cataldi, Cèlia Nadal Pasqual
- 232 Seiten
- Italian
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Un male strano
Poesie d'amore
Ausias March, Pietro Cataldi, Cèlia Nadal Pasqual, Pietro Cataldi, Cèlia Nadal Pasqual
Über dieses Buch
Ausiàs March (1400-1459) è uno dei grandi poeti lirici del suo tempo. Rispetto a Petrarca la sua concezione dell'amore è piú assoluta, piú laica, in definitiva piú moderna. Dal punto di vista della profondità di pensiero, March è un vero poeta filosofo con un'apertura di conoscenze che la cultura umanistica dei suoi tempi aveva arricchito enormemente rispetto al secolo precedente. Se March era cosí importante e famoso, come mai oggi è cosí poco conosciuto? La risposta è semplice: scriveva in catalano, una lingua che viene emarginata quando Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia hanno unificato la Spagna sotto un unico regno e scelto il castigliano come idioma ufficiale (1469). Solo tra Otto e Novecento il catalano risorge, tuttavia perseguitato durante il quarantennio franchista. La lunga minorizzazione linguistica ha emarginato March dal Parnaso della poesia europea riducendolo a oggetto di studio per specialisti. La scelta qui proposta dall'ingente corpus delle poesie di March (circa mille versi su oltre diecimila) vuole essere un modo per riportare il poeta a un pubblico piú largo. Con questo obiettivo, i curatori hanno approntato una traduzione che cerca di rispettare il piú possibile lo statuto poetico di questi testi anche usando qualche libertà, e un commento filologicamente rigoroso, che chiarisce la struttura di ogni poesia e ne suggerisce il senso piú profondo.La poesia di March si nutre di diversi apporti, dalla tradizione antica alle innovazioni europee: la lirica latina, francese e italiana; la Scolastica, i Padri della Chiesa, la Bibbia, la filosofia naturale e la trattatistica medica. Quando si parla dell'assimilazione di questi e di altri elementi, e di come l'autore ne abbia ricavato i propri tratti originali, bisogna sottolineare il modo in cui ha impresso al modello uno stile ragionativo e perfino argomentativo che ricorda le grandi canzoni d'amore di Dante; e che visto con lo sguardo dei moderni appartiene alla tradizione che sarà dei lirici che pensano: un asse della lirica alta ragionativa e qualche volta visionaria in cui stanno Blake e Coleridge, Browning, Hölderlin e Leopardi, e piú di recente Eliot e Montale; una lirica che argomenta sull'esperienza; una poesia-pensiero strutturata in nessi logici e consequenziali.
dall'introduzione di Cèlia Nadal Pasqual e Pietro Cataldi
Häufig gestellte Fragen
Commento
AXÍ COM CELL
PREN-ME’N AXÍ
Inhaltsverzeichnis
- Copertina
- Frontespizio
- Introduzione. di Cèlia Nadal Pasqual e Pietro Cataldi
- Cenni biografici
- Nota sulla ricezione e sulle traduzioni del canzoniere
- Nota alla presente traduzione
- Nota metrica
- Nota al testo
- Breve bibliografia ragionata
- Ringraziamenti
- Un male strano
- Come colui
- Mi accade come
- Piacere e amore
- Amore si duole
- Troppo dolore
- Il giorno ha paura
- Come il toro
- Senza il desio
- I desideri, tutti
- Per quanto mostri
- Compiano vele e venti
- A strano male
- Il mio volere
- Non guardo avanti
- Quando a Dio piace
- Se mi chiedi
- Per cammino di morte
- Chi darà mai
- Non dubitare
- Axí com cell
- Pren-me’n axí
- Alt e amor
- Amor se dol
- Sobresdolor
- Lo jorn ha por
- Sí com lo taur
- Sens lo desig
- Tots los desigs
- Si bé mostrau
- Veles e vents
- A mal estrany
- Ma voluntat
- No guart avant
- Quant plau a Déu
- Si·m demanau
- Per lo camí de mort
- Qual serà·quell
- No cal dubtar
- Commento
- Il libro
- L’autore
- Copyright