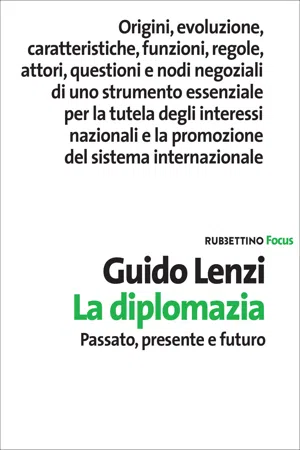![]()
Foto di gruppo con Feluca
Caratteristiche, funzioni e strutture
La diplomazia è l’arte dei rispetti,
dei sospetti e dei dispetti.
Motto popolare
LA POLITICA ESTERA SENZA LA DIPLOMAZIA – è stato detto – è vuota; la diplomazia senza politica estera è cieca. Il loro rapporto non è fra eguali, la politica estera è il «cosa», la diplomazia è il «come»: gli scopi sono definiti dalla politica estera, ma il loro raggiungimento è affidato alle cure della diplomazia. Ambedue devono pertanto andare di pari passo, nessuna delle due può imporsi all’altra. Talvolta il rapporto s’inverte, ogni qualvolta i politici consentono ai diplomatici di fungere da battistrada, ma i rispettivi comportamenti devono rimanere complementari, rivolti come sono entrambi ad assicurare la coerenza interna e la visibilità esterna dell’identità e degl’interessi nazionali. Tanto più che ai loro compiti s’è oggi aggiunto quello, più impegnativo, che Kant identificava nel «trasferire l’umanità dallo stato di natura a una comunità etica». Di sviluppare, cioè, un sistema che stimoli la collaborazione invece dell’antagonismo.
Il compito principale del diplomatico è di assicurare al proprio Stato lo stretto contatto con gli avvenimenti internazionali, attuali e potenziali, riducendone il tasso d’imprevedibilità. Fornendo al proprio governo le informazioni e proposte più opportune, selezionandone la rilevanza, differenziando gli aspetti essenziali da quelli accessori, collegando il provvisorio al permanente. Una professione, quella diplomatica, il cui esercizio non esige più, come in passato, un’estrazione aristocratica, ma pur sempre un’indole cosmopolita, adatta ad affrontare l’eterogeneità delle situazioni e degli interlocutori. Vero è però che, un po’ ovunque, gli stessi ministeri degli Esteri, da perni per l’elaborazione di idee, la produzione d’iniziative e il coordinamento interministeriale, sono diventati piuttosto strumenti di distribuzione di istruzioni confezionate dai capi di governo. Peraltro, «nessuna azione – diceva Nicolson – dovrebbe essere decisa dal ministro degli Esteri senza che sia stato chiesto il parere degli Ambasciatori sul posto»; salvo naturalmente a dissentirne. A evitare – dice Ferdinando Salleo, già segretario generale della Farnesina – che le iniziative di questi ultimi appaiano come meri «lampi nel buio».
Tre secoli fa, Condillac riconosceva che «un ambasciatore è una persona inviata in una corte, prima di tutto per rappresentarvi con fasto, poi per trattarvi eventualmente degli affari, infine per riferire ciò che osserva, sempre che i ministri che l’hanno inviato vogliano esserne resi edotti». Per Napoleone, più sbrigativamente, la diplomazia altro non era che una «polizia internazionale in abito da gala». Al giorno d’oggi, più propriamente, la missione del diplomatico è di comprendere e valutare la dinamica delle situazioni internazionali alle quali è esposto. In un uso strategico del dialogo fra Stati. Nel perseguimento – dice sempre Nicolson – di una «condotta ordinata delle relazioni internazionali […]. La peggior specie di ambasciatore – aggiunge – è costituita dai missionari, dai fanatici e dai giuristi; la migliore, dagli scettici dotati di un’indole ragionevole».
Definizioni
Ciò detto, nell’immaginario collettivo, la funzione diplomatica, che della sovranità nazionale è elemento essenziale, rimane poco apprezzata, misconosciuta. Lo stesso termine è ambiguo, prestandosi a connotazioni disparate. Concordanti ne sono le radici etimologiche: utilizzato dal Settecento in poi, deriverebbe dal greco diploo, il documento che, piegato, contiene le istruzioni ricevute. La designazione di ambasciatore risalirebbe invece dal celtico «ambactos» («colui che va intorno»), dal gallico «and-bahts» («servitore»), e/o dal medioevale «ambactia» («servizio»). «L’ambasciatore reca l’ambasciata, l’ambascia è invece di colui che ne attende l’esito», aggiungeva argutamente Ducci. Secondo la mitologia greca, i primi messaggeri furono gli angeloi, posti fra cielo e terra. Il loro nume tutelare, nell’Olimpo, era Hermes, che a Roma, affiancato a Sisifo, diventerà Mercurio, dio dei commerci e delle comunicazioni, dai piedi alati. Nell’empireo cristiano, si trasformerà nell’arcangelo Gabriele, che san Tommaso invocherà. Il patrono della diplomazia è stato identificato in Tommaso Moro, l’antagonista di Enrico VIII.
La definizione più sommaria la descrive come «scienza degli affari esteri degli Stati» o, in senso più circoscritto, «scienza o arte del negoziato». L’Enciclopedia Britannica, precisando trattarsi di «un genere che comprende molte specie», la definisce come
metodo stabilito per l’interlocuzione internazionale o l’arte di gestire i rapporti internazionali, soprattutto tramite negoziati; […aggiungendo che] riferita originariamente ai rapporti ufficiali fra Stati sovrani, nel Ventesimo secolo si è estesa ai vertici e altre conferenze internazionali e alle attività delle organizzazioni internazionali […]. Modo in cui entità nazionali confluiscono in una qualche comunità allo scopo di perseguire attivamente una finalità comune.
Il dizionario francese Robert dice trattarsi di «branca della politica che riguarda i rapporti fra Stati; rappresentazione all’estero degli interessi di un governo; amministrazione degli affari internazionali; direzione ed esecuzione dei negoziati fra Stati». Più esauriente la Treccani, che la caratterizza come «l’insieme dei procedimenti attraverso i quali uno Stato mantiene normali relazioni con altri soggetti di diritto internazionale, al fine di attenuare o risolvere eventuali contrasti di interesse e di favorire la reciproca collaborazione per il soddisfacimento di comuni bisogni».
Storicamente, Sir Robert Walpole ne parlava come «grande motore utilizzato dalla società civile allo scopo di mantenere la pace». Dall’America, Washington Irving la descriveva come «il mezzo per ottenere vantaggi che andrebbero altrimenti perseguiti militarmente». Ispirandosi al paradigma di Clausewitz, Ciù En-lai ne invertirà i fattori, affermando trattarsi invece della «continuazione della guerra con altri mezzi». Alle prese con i rapporti Est-Ovest, Kennan affermava che il suo scopo è di «stabilire comunicazioni con il massimo possibile di precisione, immaginazione, tatto e buon senso; seconda a nessun’altra professione nel suo esercizio di comprensione, in termini di capacità di analisi scientifica e pensiero creativo». Strumento flessibile, che si adatta a quel che contribuisce a creare. Ciò che, oltre all’indispensabile arte della parola, comporta essenzialmente l’intelligenza di situazioni dinamiche sulla lunga durata, per distillarne l’essenza, suggerendo, organizzando, facilitando l’incedere della politica estera.
Politica estera e diplomazia non sono, peraltro, né saranno mai, scienze esatte, consistendo piuttosto nell’esercizio di un mestiere, se non di un’arte. Richiedendo il più delle volte il ricorso al buon senso, nell’intento non soltanto di conseguire dei risultati specifici, quanto anche a stabilire le modalità più opportune per sistemarli nel più ampio appropriato contesto. Il che fa del diplomatico un «dilettante» nell’accezione rinascimentale del termine, in un misto – è stato detto – di ispirazione e sudorazione, fra aristocrazia e burocrazia. I francesi parlano di esprit de combinaison et de suite, distinguendo fra l’esprit florentin, opportunista, dissimulatore, e l’esprit de finesse, consistente nell’acume e nella precisione; nella congiunzione del savoir, del savoir-faire e del savoir-être, requisiti essenziali della necessaria capacità tanto di ascolto quanto di adattamento.
In un procedimento organico, non meccanico, che opera per sperimentazione e sedimentazione, apparentando il diplomatico non all’ingegnere né all’avvocato, bensì semmai al giardiniere o al medico. Per i quali ogni situazione patologica rappresenta una sfida, il punto di partenza per un rinnovato impegno. Una caratteristica che persino l’economista Friedrich von Hayek riconosceva, dicendo, nel suo discorso di accettazione del premio Nobel, che
dobbiamo utilizzare quel poco di conoscenze che abbiamo non per produrre dei risultati specifici, come l’artigiano plasma la sua opera, bensì piuttosto per coltivare una crescita fornendo l’ambiente appropriato, come il giardiniere fa per le proprie piante […]. In una civiltà, la nostra, che nessuno ha disegnato, ma che è cresciuta dall’impegno di milioni di individui.
Il nostro politologo Alessandro Campi ne fornisce, credo, la descrizione più concisa e completa:
Fra le tante invenzioni politiche del genio europeo, c’è anche la nobile arte della diplomazia fra Stati: fatta di pazienza, di parole scelte con cura e dette al momento giusto, di silenzi eloquenti, di fermezza non arrogante e di una disponibilità all’ascolto delle altrui ragioni, che non deve mai essere scambiata per cedimento o arrendevolezza.
I pregiudizi
L’opinione corrente raffigura i politici come camaleonti, i diplomatici invece come sfornati da uno stampo. Ma l’abito, si sa, falsa la natura di chi lo indossa. Sotto la feluca (ormai in disuso), i temperamenti individuali si differenziano, talvolta s’esasperano, esposti come sono alla pressione di condizioni di vita perennemente mutevoli. Sempre altrove, eterno Ulisse, talvolta naufrago, in precario equilibrio fra l’assistere e il partecipare agli eventi circostanti che deve comunque decifrare, il diplomatico finisce col riflettere l’immagine di sé in quel che fa. La sua unica griglia di valutazione è il proprio discernimento, l’unico suo alimento il grado di vivacità e curiosità intellettuale di cui dispone.
La diplomazia, lo abbiamo visto, è disciplina antica, la cui utilità è talmente ovvia da sfuggire ad ogni precisa definizione. Se ne vedono gli aspetti esteriori che, pur essenziali, vengono stereotipati, talvolta caricaturati, anche letterariamente1, da chi non vi scorge che le tracce di una signorilità aristocratica, condita da dotte citazioni e riferimenti a esperienze personali, nel distacco dal tumulto del mondo contemporaneo. Se ne trascurano quelli sostanziali, che avvengono di preferenza dietro le quinte del palcoscenico pubblico. Chi ne vede soltanto la forma, posta a tutela del decoro del paese di provenienza, trascura quelli strumentali, rivolti a persuadere, a coinvolgere, a formare una comunità internazionale.
Ai diplomatici molti imputano, quindi (o invidiano), la vita superficiale, brillante, dispendiosa, la frequentazione della high society. Trascurando che le relazioni pubbliche (dette «pi erre») sono ormai il motore di ogni vita associata; che la vita del diplomatico avviene in una molteplicità di circostanze, non soltanto nei banchetti e nei cocktail. Un impegno totalizzante che esige un temperamento particolare, necessario più dell’intelligenza per adattarsi alle situazioni eterogenee alle quali è ricorrentemente confrontato. Un compito diventato sempre più impegnativo, al contempo di raccordo e proiezione, destinato a strutturare e tessere una tela di relazioni, nel coinvolgimento degli attori più direttamente interessati. Una funzione esigente, solitaria, poco appariscente e pertanto spesso fraintesa.
Ducci sosteneva che «si entra in carriera per diventare nobili», membri cioè dell’aristocrazia del pensiero. Flaubert, nel suo Dictionnaire des idées reçues, affermava trattarsi di una «bella carriera, ma irta di difficoltà, piena di misteri che non si confà che agli spiriti nobili; mestiere dal vago significato, collocato peraltro al disopra del comune». Jules Cambon, uno dei maggiori esponenti del Quai d’Orsay fra le due guerre, precisò:
Non conosco un mestiere più diversificato: non ve ne è altro che abbia meno regole precise e più tradizioni, che richieda più perseveranza per riuscire nel suo intento, e nel quale il successo dipenda maggiormente dalle circostanze; nel quale una disciplina precisa sia altrettanto necessaria, e che esiga da colui che l’esercita un carattere più fermo e uno spirito più indipendente […]. Ogni nazione ha i suoi costumi, i suoi pregiudizi, il suo modo di sentire. Gli ambasciatori non ne prescindono vivendo all’estero, ma tentano di adattarsi, per quanto possibile, ai modi di vivere e di pensare che non sono i loro […]. Devono quindi essere uomini d’onore nel senso più rigoroso del termine, nel quale tanto il governo presso cui è accreditato quanto il suo stesso governo devono riporre piena fiducia in ciò che egli dice.
L’impegno del diplomatico rimane quello d’individuare gli interlocutori più rilevanti, di impegnarne l’attenzione, d’interpretarne e vagliarne le intenzioni, d’individuare i possibili rischi e le occasioni, d’impostare, infine, e svolgere eventuali negoziati. Harold Nicolson ricorda che prima della Grande guerra, prima di diventare di competenza dei professionisti della politica, tanto l’impostazione quanto la conduzione della politica estera era affidata ai diplomatici. Al giorno d’oggi, aggiungeva, se la politica estera va assoggettata al controllo democratico, la sua attuazione andrebbe lasciata alle cure degli esperti appositamente temprati.
Funzioni
Se il giudizio più sommario si limita a indicarne la funzione di esecuzione della politica estera, mutevoli ne sono le conformazioni, a seconda delle circostanze nelle quali si trova a operare. De Martens, nel 1822, ne ha fornito la descrizione più dettagliata, osservando che,
oltre a curare le relazioni esterne degli Stati, assicurare la sicurezza e l’armonia reciproca, prevenire e risolvere i conflitti, facilitare gli scambi commerciali, la diplomazia deve concorrere mediante procedure liberali a riunire in una comune società fratelli e amici. Ne consegue che ogni diplomazia deve evitare di essere turbolenta o troppo attiva; quella che, per principio e senza necessità impellente, divide è machiavellica e degna di riprovazione.
Nel 1558, nel suo rapporto di fine missione, Bernardo Novagero, ambasciatore di Venezia a Roma, scriveva:
Ho imparato, Serenissimo Principe, nelle Legazioni ne...