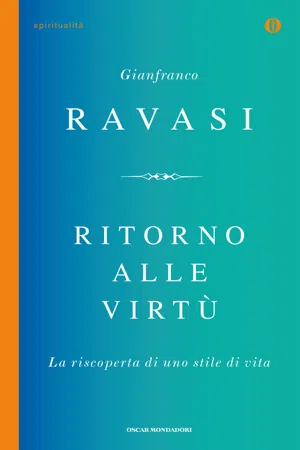«La fede è la più alta passione di ogni uomo. Ci sono forse in ogni generazione molti uomini che non arrivano fino ad essa, ma nessuno va oltre.» Così nella sua opera Timore e tremore (1843) il filosofo danese Søren Kierkegaard celebrava la grandezza della fede come vertice della «passione» dell’uomo, ossia del suo totale consacrarsi alla ricerca puntando verso la vetta suprema della verità. Proprio per questo suo aspetto drammatico – che in quell’opera il filosofo incarnava nell’esperienza terribile di Abramo in marcia verso il monte Moria accompagnato solo da un ordine divino incomprensibile e scandaloso («Prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va’ nel territorio di Moria e offrilo in olocausto…!», Gn 22,2) –, proprio per il coinvolgimento radicale che essa comporta, trattare in poche pagine della fede è sicuramente arduo. Essa ci introduce in quella triade suprema delle virtù denominate come teologali, appartenenti cioè all’orizzonte della trascendenza divina.
«Chi oserà dire: Io credo in Dio?»
È arduo anche perché sono molte le contraffazioni a cui essa va incontro, sotto la spinta dell’interesse, del gusto, della semplificazione umana. C’è chi la riduce a uno stinto stendardo popolare da portare in processioni folcloristiche, dolce consolazione fra i travagli della vita. Proprio come ironizzava lo scrittore Antonio Baldini in uno stornello del suo Michelaccio (1924): «Mentuccia d’orto / quaggiù dove non c’è nulla di certo / la religione è sempre un gran conforto». È per questa via che si scatenava il sarcasmo feroce e sbrigativo di Karl Marx, che nella sua Critica alla filosofia hegeliana del diritto pubblico (1843) coniava quella celebre definizione della religione come «oppio dei popoli», benefico sedativo inoculato dal potere per placare ogni velleità di riforma, ogni ansia di giustizia, ogni rivolta all’oppressione.
Al contrario c’è chi trasforma la fede in un vessillo che garrisce in mezzo alle tempeste, lo pianta al centro delle piazze, lo issa sui pennoni del palazzo della politica creando così teocrazie e regimi sacrali, imponendo la lettera della fede attraverso un fondamentalismo che ne prosciuga e uccide lo spirito, per ricorrere a una nota accusa paolina (2 Cor 3,6). Anzi, talora uccide corpo e spirito di chi pratica questa fede integralistica e accecante, dimenticando che «è più facile morire per una religione che viverla assolutamente», come osservava lo scrittore argentino Jorge Luis Borges nei suoi Labirinti (1964). Fra questi due estremi dello spettro cromatico della religione, il violetto freddo della superficialità e il rosso acceso del fanatismo, si sviluppa una gamma variegata di tonalità di fede che può lasciare imbarazzati e fin tentati al relativismo o al sincretismo, per cui si approda alla conclusione, spesso ripetuta, che lo scrittore elisabettiano inglese Robert Burton icasticamente sintetizzava nella sua Anatomia della malinconia (1621): «Una religione è tanto vera quanto un’altra».
In questo immenso orizzonte che si apre ogni volta che si intavola il discorso sulla fede, potremmo perciò essere tentati dalla dispersione: basti solo pensare alla sterminata bibliografia teologica che è stata elaborata dall’umanità, una vera «biblioteca di Babele», labirintica e capace di stordire, segno comunque di un insonne interrogarsi dello spirito e della mente umana attorno a questo tema capitale. Tale sensazione di impotenza è ben espressa da Goethe nella prima parte del suo capolavoro, il Faust: «Cara, chi oserà / dire: Io credo in Dio? / Puoi domandare a preti o a sapienti / e la risposta sembrerà prendere in giro / chi ha fatto la domanda» (vv. 3426-3430). Eppure il credere, le sue giustificazioni, i suoi percorsi continuano ad appassionare. È un argomento di cui non si parla in società, quasi fosse sconveniente o per lo meno imbarazzante, eppure non lo si può tacitare ed esso insorge nel momento del silenzio, nel tempo del dolore, nel giorno della festa, sempre inatteso e forse irrisolto.
Aveva, perciò, ragione lo scrittore inglese Gilbert K. Chesterton quando nel suo saggio Ortodossia (1908) faceva notare che non è vero che oggi l’uomo, abbandonata la fede in Dio, non creda più in nulla: crede ormai a tutto, e il proliferare di maghi, «maestri», indovini, esoterismi e altre ciarlatanerie spirituali, pronte a unire messaggio e massaggio, yoga e yogurt, ascesi e dieta, spiritualità e magia, ne è la prova attestata. Anche un «ateo di tutte le religioni», come era stato definito da Papini lo studioso della società e dell’economia Vilfredo Pareto nelle sue Trasformazioni della democrazia (Milano, Corbaccio, 1921), osservava realisticamente che «se oggi, i popoli civili più non credono che il sole, ogni sera, si tuffi nell’oceano, hanno però altre credenze che non più di questa si accostano alla realtà». A questo punto decidiamo di inoltrarci in quell’orizzonte così vasto. La nostra sarà solo una breve navigazione in un oceano dalle mille rotte.
«In Dio si scoprono sempre nuovi mari quanto più si naviga» affermava infatti uno scrittore mistico spagnolo contemporaneo di santa Teresa d’Ávila e san Giovanni della Croce, Fray Luis de León. Noi ci orienteremo verso il cuore della fede cristiana che è non solo il «grande codice» della civiltà occidentale (senza di essa, ad esempio, non esisterebbe la Divina Commedia) ma è l’anima della nostra spiritualità ed è indubbiamente alla radice del più alto e ampio sistema teologico e ideologico elaborato dall’umanità. La fede è la prima del trittico delle cosiddette «virtù teologali». Questo aggettivo ci rimanda ovviamente a Dio, in senso soggettivo (la fede è la virtù donata da Dio stesso, da lui infusa, alimentata, sostenuta, provata e vagliata) e in senso oggettivo (è la virtù che ha per oggetto Dio, il suo mistero, la sua parola e la sua opera). È, comunque, alla luce della rivelazione e della ragione che noi in essa ci inoltriamo, procedendo quindi secondo un ritmo binario che non è dialettico e antitetico, bensì armonico, di contrappunto, di duetto. E il rimando sarà sostanzialmente al messaggio cristiano come stella polare per la nostra riflessione. Anche un poeta non certo credente (almeno secondo i canoni classici) come Franco Fortini dichiarava sia pure «laicamente» in una lirica contenuta nella raccolta Poesia ed errore (1959): «Noi non crediamo più agli dèi lontani / né agli idoli e agli spettri che ci abitano. / La nostra fede è la croce della terra / dov’è crocifisso il figliuolo dell’uomo» (Varsavia 1939).
Fede e grazia
Ci muoveremo, dunque, per coppie tematiche. La prima, fondamentale, è quella che unisce fede e grazia. Sono due stelle che costituiscono il cuore della costellazione del credere. Ad accendersi per prima è la grazia, cháris nel greco di san Paolo, il nostro maggior punto di riferimento in questo itinerario. Il vocabolo, che è rimasto nei nostri «caro, carezza, carità» o nell’inglese «charm» e nel francese «charme», denota amore, fascino, splendore. È l’apparire di Dio nella notte dell’anima; egli non è un imperatore impassibile relegato nel cielo dorato della sua trascendenza. «Sta alla porta e bussa», come dice l’Apocalisse (3,20), squarcia la nostra solitudine, mettendosi lui per primo sulle strade della storia, intessendo un dialogo che è prima di tutto una rivelazione del suo essere e della sua vita, dei suoi pensieri e dei suoi progetti. Scrive Paolo: «Isaia arriva fino al punto di affermare: Io [il Signore] mi sono fatto trovare anche da quelli che non mi cercavano, mi sono rivelato anche a quelli che non mi interrogavano» (Rm 10,20 e Is 65,1). In principio c’è, allora, l’amore divino che interpella l’uomo. È questo il senso del grido finale del Diario di un curato di campagna (1936) di Georges Bernanos: «Tutto è grazia!».
Illuminato dalla grazia-cháris, l’uomo risponde con la sua libertà che può generare un rifiuto o un’adesione. E l’adesione è appunto la fede, la pístis in greco, simile a braccia aperte che accolgono la grazia-amore, ascolto di una rivelazione divina e risposta nella preghiera. È un afferrare la mano di Dio che ci viene offerta mentre siamo immersi nel nostro limite creaturale o stiamo sprofondando nelle fangose sabbie mobili del male e del peccato. Questo abbraccio ci trasforma e trasfigura perché Dio infonde in noi il suo stesso respiro di vita, il suo «spirito». Illuminanti sono ancora le parole di Paolo ai Romani: «Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per piombare nella paura ma avete ricevuto uno spirito di figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: Abba’! Padre!» (8,15). Altrettanto significativa per illustrare questa irruzione del divino in noi, con tutta la sua energia e la sua efficacia, è la parabola del seme deposto nel terreno narrata da Gesù (Mc 4,26-29). Il contadino è a letto e dorme in una lunga notte d’inverno, oppure è altrove affaccendato in una giornata primaverile o nell’estate incipiente. Eppure quel seme genera intanto, da solo, uno stelo e una spiga colma di chicchi di grano. La fede è riconoscere che esiste una presenza invisibile che opera nella storia, è saper condividere i tempi di crescita, è accogliere con gioia quel dono che fa vivere un’esistenza del tutto nuova.
Fede e fiducia
C’è, però, un’altra coppia tematica riguardante la prima virtù teologale, quella che vincola fede e fiducia. Se vogliamo adottare il tradizionale linguaggio teologico, possiamo parlare di fides quae («fede che» ha in sé un contenuto di verità) e fides qua («fede con la quale» si aderisce alla persona di Dio che a noi si svela e con noi entra in comunione). C’è, allora, da un lato la conoscenza del messaggio divino, della sua rivelazione, dei suoi contenuti. Il cuore di questa comunicazione è naturalmente la Bibbia, ma è anche per tutti i popoli la rivelazione cosmica, «i semi del Verbo» divino effusi in tutto l’essere come usavano dire i Padri della Chiesa. C’è, quindi, un «oggetto» del credere, un dato da penetrare, scavare e approfondire: è il Lógos divino, il «discorso», il «Verbo» che Dio ci comunica e che ha il suo apice in una persona, Gesù Cristo, che entra nella storia unendo in sé divino e umano, Lógos e sárx, come dice san Giovanni, ossia «Parola» eterna e «carne» storica. E la meta di questo incontro è nella Pasqua di Cristo ove la morte, emblema della nostra creaturalità, e la risurrezione, segno della vita perenne e gloriosa divina, s’incrociano inestricabilmente per la nostra redenzione e trasfigurazione. Per questo il primo Credo cristiano, citato da san Paolo, suona così: «Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture e apparve…» (1 Cor 15,3-5).
Ma la fede, proprio per questo contenuto vitale, postula una reazione «soggettiva», cioè un’adesione; oltre che «discorso» è un «percorso» di vita: è la fiducia, è l’abbandono al Rivelatore e Redentore, è un affidarsi a lui e alle sue braccia paterne. La fede ha, quindi, anche un aspetto di rischio, di consegna di sé, nella consapevolezza che l’orizzonte misterioso di Dio è ben più alto del nostro, come suggeriva già il Signore per bocca di Isaia: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie … i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri» (55,8-9). Tipico è l’atteggiamento di Abramo «nostro padre nella fede», non solo quando sale l’erta del monte Moria stringendo la mano di Isacco, come abbiamo già ricordato, ma anche quando aveva ricevuto, anni prima, quella vocazione che gli aveva scardinato la vita: «Esci dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò … Abramo partì, come gli aveva ordinato il Signore … Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì e partì senza sapere dove andava» (Gn 12,1.4 e Eb 11,8).
Fede e ragione
Questo intreccio tra fede e fiducia, tra verità e rischio genera un’altra coppia tematica, quella di fede e ragione, che costituisce anche il titolo di un’enciclica di papa Giovanni Paolo II, Fides et ratio (1998), dedicata proprio a questo contrappunto armonico, a questo volo nel cielo del mistero divino con le due ali della fede e della razionalità, per usare l’immagine con cui quel testo papale si apre. Sant’Agostino era, al riguardo, incisivo: «Chiunque crede pensa e pensando crede … La fede, se non è pensata, è nulla» (De praedestinatione sanctorum 2, 5). L’autentico credente è posto su un crinale tagliente e delicato. Facile, infatti, è scivolare verso una fede che sia solo abbandono fiduciale, quasi cieco, rifuggendo da ogni interrogativo, cancellando ogni fremito del pensiero, facendo scolorire e scadere la religione in un progressivo sentimentalismo devozionale. Pericoloso è, però, anche inoltrarsi solo sull’altro versante, quello di una razionalizzazione così assorbente da ridurre la religione a una serie di teoremi, a un sistema speculativo in cui tutto si ordina, a una geometria teologica che non lascia spazio al mistero e al trascendente. Suggestiva è, al riguardo, la definizione della fede che ci offre quella sontuosa omelia neotestamentaria che è la Lettera agli Ebrei: «La fede è fondamento [in greco hypóstasis] delle cose che si sperano e prova [in greco élenchos] di quelle che non si vedono» (11,1).
Da un lato c’è, quindi, l’affidarsi fiducioso alla rivelazione divina, alla speranza che ci viene fatta balenare: non per nulla si parla di «fondamento», di base su cui appoggiarsi, come suggerisce lo stesso verbo ebraico del «credere», divenuto il nostro amen, che indica un «fondarsi» sulla parola e sulla presenza dell’Altro divino, un cercare in lui stabilità e sicurezza in un rapporto interpersonale. D’altro lato, la fede è «prova», è argumentum, come traduceva la Volgata latina, a cui si univa Dante con questa parafrasi dell’asserto biblico citato: «Fede è sustanza di cose sperate, / ed argomento de le non parventi» (Paradiso XXIV, 64-65). «La fede se non è pensata, argomentata, è nulla», come si è visto, era la convinzione di sant’Agostino. E questo grande Padre della Chiesa e genio dell’umanità è forse – con san Tommaso d’Aquino – l’esempio più alto dell’equilibrio tra fede e ragione. La potenza straordinaria del suo pensiero, della sua intuizione, della sua ricerca si sposava continuamente con l’intensità della sua fede, tant’è vero che spesso i suoi testi sono segnati da una teologia orante: la sua analisi teologica è costruita letterariamente come se fosse rivolta a un «Tu», è una costante interpellanza, è un appello orante rivolto a Dio, oggetto di quella ricerca.
Fede e opere
Un’ultima coppia ideale vorremmo proporre: è quella fede-opere. Come è noto, essa ha tormentato la riflessione di Paolo e la stessa storia della cristianità: si pensi al dibattito teologico aperto dalla Riforma protestante e che ha avuto un punto fermo nella Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione emessa d’intesa tra la Chiesa cattolica e la Federazione luterana mondiale il 31 ottobre 1999. Ora, per l’Apostolo non sono le opere da noi compiute a ottenerci il dono trascendente della salvezza, che è un «molto di più», essendo una partecipazione alla stessa vita divina. A una certa concezione giudaica che esaltava la funzione salvifica delle opere della Legge, introducendo quasi un «salvarsi» da parte dell’uomo, Paolo oppone un «essere salvato» attraverso la fede che accoglie la grazia divina salvifica. Esemplare è la dichiarazione reiterata per tre volte in un unico versetto della Lettera ai Galati: «Riconosciamo che l’uomo non è giustificato dalle opere della Legge ma soltanto per la fede in Cristo Gesù. Abbiamo creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della Legge. Dalle opere della Legge non verrà mai giustificato nessuno» (2,16). Le opere non sono la causa ma il frutto della salvezza, come nella stessa Lettera si dichiara: «Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (5,22).
È, quindi, necessaria anche per san Paolo la presenza delle opere come segno dell’autenticità della fede. Sarà ciò che san Giacomo, più legato alla tradizione giudeo-cristiana, marcherà con forza nella sua Lettera, dando quasi l’impressione di correggere Paolo, in realtà sottolineando il rilievo dell’impegno esistenziale morale per non ridurre la fede a semplice adesione intellettuale o sentimentale o a mera esperienza intimistica. Merita di ascoltare le sue parole, che rivelano accenti sicuramente diversi rispetto a quelli paolini ma non in contrasto con essi: «Che giova, fratelli, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede potrà salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: Andate in pace a riscaldarvi e a saziarvi! senza dar loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede: se non ha le opere, è morta. Ma uno potrebbe dire: Tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, e io dalle mie opere ti mostrerò la mia fede … Ma non sai, o insipiente, che la fede senza le opere è fredda? … L’uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede» (Gc 2,14-24).
È ancora in questa linea che si comprende l’equilibrio che deve intercorrere fra un’altra coppia subordinata, quella composta da fede e religione. La prima è adesione personale, la seconda può essere intesa come prassi esterna, manifestazione rituale e sociale. Certo, si può comprendere il valore paradossale della preghiera formulata dal maggior teologo protestante del Novecento, Karl Barth: «Signore, liberami dalla religione e dammi la fede!». La religiosità può ridursi, infatti, a convenzione, comportamento esteriore, ritualismo, antropologia culturale, e su questo i profeti biblici sono stati inesorabili nel combattere ogni confusione tra religione e fede. Tuttavia, è indubbio che la fede coinvolge e avvolge la persona nella sua integralità e, quindi, comprende anche scelte sociali, atteggiamenti visibili, produce strutture, si esprime in riti e tradizioni, diventa appunto religione proprio perché spirito e corpo sono intimamente connessi e interoperanti e comunicanti.
«Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede?»
...