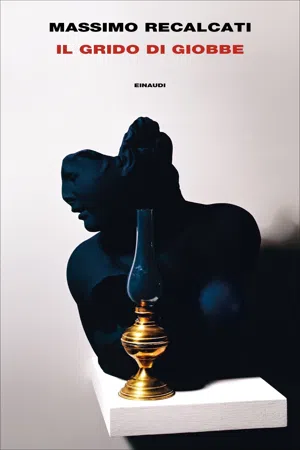La posta in gioco del Libro di Giobbe non è solo il senso della sofferenza umana, ma quello del rapporto dell’uomo con Dio e con la sua giustizia. Può Dio redimere il dolore, salvare la vita dal male, può garantire che il bene vinca sempre sul male, può promettere la salvezza dei suoi figli?
Nel celebre delirio psicotico del Presidente Schreber, analizzato da Freud e ripreso in piú occasioni da Lacan, Dio non è il nome del bene, non è il logos che istituisce l’ordine del mondo ma una ingerenza abusiva e immonda, l’espressione di una voluttà che distrugge ogni possibile ordine del mondo1. Il Dio schreberiano è un Dio che non ama le sue creature, ma gode impunemente di esse. È l’esecutore di quell’«assassinio di anime» che stravolge la Legge del mondo. Egli non rassicura né protegge gli esseri umani, ma si manifesta loro come una pura volontà di godimento che abusa illimitatamente dei loro corpi sottoponendoli a sevizie di ogni genere. Quello che dobbiamo ricordare è che questa rappresentazione persecutoria di Dio nella psicosi schreberiana segnala – nella lettura che ne propone Lacan – il fallimento della Legge del padre (metafora paterna) che dovrebbe rendere possibile al soggetto l’acquisizione del senso simbolico del limite (legge della castrazione). Diversamente, nella psicosi il padre non conosce limite alcuno e, come il Dio di Giobbe, si manifesta alternativamente nella forma dell’intrusione persecutoria o dell’abbandono melanconico. Se il Dio folle di Schreber incarna un potere senza argini che annienta dispoticamente la vita dei suoi sudditi, Lacan mostra che il significato primo del Nome del padre consiste nel dare senso alla vita, nell’«umanizzare il reale»2, nell’essere quella «strada maestra» che inquadra simbolicamente l’ordine del mondo permettendo di associare la vita al senso. Senza questa funzione di orientamento assicurata dal Nome del padre la vita si smarrirebbe, non avrebbe identità, cadrebbe nichilisticamente nel non senso. È solo l’esistenza del Nome del padre che può attribuire un senso all’esistenza. Non a caso in Giobbe la perdita della presenza amichevole di Dio, il suo trasfigurarsi in un nemico acerrimo, svuota la vita di ogni possibile senso gettandola come un rifiuto «in mezzo alla cenere» (Gb 2,8). La volontà di Dio appare quasi come una forza demoniaca, carica di voluttà sadica:
egli fa perire l’innocente e il reo! Se un flagello uccide all’improvviso, della sciagura degli innocenti egli ride. La terra è lasciata in balía del malfattore: egli vela il volto dei giudici; chi, se non lui, può fare questo? (Gb 9,22-24).
Dio non è il fondamento della Legge morale ma del suo stravolgimento immorale. Il suo arbitrio domina incontrastato e altera l’ordine del mondo in un disordine perpetuo; il Dio del patto lascia il posto al Dio della potenza, come lo stesso Schreber, nel suo delirio, annota:
Il concetto di moralità esiste esclusivamente all’interno dell’Ordine del mondo, cioè del vincolo naturale che lega Dio con l’umanità; una volta che l’Ordine del mondo sia infranto, non resta altro che una questione di potenza […]. Nel mio caso la cosa scandalosa dal punto di vista morale era che Dio stesso si fosse posto al di fuori dell’ordine del mondo3.
Anche la lettura junghiana del Libro di Giobbe sottolinea il tirannismo anarchico di Dio – «Dio smodato», «roso dall’invidia e dalla gelosia» – o, meglio, la sua esistenza divisa tra un’istanza benefica fatta di «ponderatezza», «bontà» ed «energia creatrice» e un’altra fatta di «sconsideratezza», «crudeltà» e «volontà di distruzione»4. Anche la sua lettura parte dalla constatazione dello stravolgimento dell’immagine benevola di Dio in quella di una presenza maligna. Come interpretare questo sdoppiamento di Dio in «persecutore» e «soccorritore»?5. Per Jung esso rivelerebbe il bisogno di Dio della sua creatura, la necessità che egli avverte di umanizzare la sua stessa esistenza. Le furie terribili di Dio contro gli uomini manifesterebbero, infatti, la sua profonda ambivalenza nei confronti delle sue creature. È ciò che spiegherebbe il patto scellerato con Satana e la sua totale assenza di pietà verso il povero Giobbe colpito dalla sventura. È solo la fede di Giobbe che svela l’antinomia di Dio che se «da una parte schiaccia senza il minimo scrupolo la felicità e la vita umana», dall’altra «sente di dover avere l’uomo come suo partner»6. Non a caso nell’interpretazione junghiana del Libro di Giobbe è solo Gesú, grazie alla mediazione di Maria, che può ristabilire la concordia tra Dio e l’uomo, placando l’ira di Dio e ricomponendo finalmente il suo dissidio con l’uomo, essendo Gesú l’uno e l’altro7. Cristo, il figlio, redime il Padre liberandolo dal suo dispotismo geloso, dalla tentazione satanica della potenza, di detenere un potere senza limiti. In questa prospettiva la lettura junghiana vede la soluzione del dramma di Giobbe attraverso la figura di Cristo: l’antinomia del Dio dell’Antico Testamento viene riconciliata in quella amorevole nel Nuovo Testamento. Cristo agisce come simbolo – coniunctio oppositorum – che oltrepassa il «duello immaginario» tra Dio e l’uomo. Se Giobbe ha svelato l’antinomia di Dio, allora Cristo è colui che è destinato a ricomporla.
Resta il fatto che nessun libro biblico come quello di Giobbe mostra il carattere apertamente ostile di Dio verso l’uomo. Il Signore per gran parte del libro non mostra alcuna pietas, compassione, delicatezza verso il dolore della sua creatura. Egli infligge pene atroci nella piú totale indifferenza. Giobbe ne è sconcertato: «mi ha afferrato per il collo e mi ha stritolato» (Gb 16,12), «ha acceso contro di me la sua ira e mi considera come suo nemico» (Gb 19,11). Il paradosso tremendo è come sia possibile che l’uomo giusto venga «percosso» da Dio con cosí tanto accanimento. Il Dio biblico non è qui sinonimo di salvezza ma appare simile al delirante Dio persecutore di Schreber, un avversario feroce e irriducibile dell’uomo:
mi toglie le forze, ha distrutto tutti i miei congiunti e mi opprime. Si è costituito come testimone ed è insorto contro di me: il mio calunniatore mi accusa in faccia. La sua collera mi dilania e mi perseguita; digrigna i denti contro di me (Gb 16,7-9).
Come è possibile che Dio da oggetto assoluto di fede, da Padre e Creatore della terra, si trasfiguri in un implacabile accusatore e calunniatore? In un avversario che colpisce senza nessun riguardo la vita di chi lo ama? Sappiamo bene che all’origine di questa ostilità è la scommessa concordata con Satana: bisogna togliere a Giobbe ogni cosa per misurarne la fede. Giobbe perderà progressivamente ogni bene, sino a veder svanire, per ultimo, anche quello della sua salute trovandosi cosparso di piaghe e ulcere, immerso nella cenere e nell’immondizia, malato nell’anima e nel corpo: «Ricoperta di vermi e di croste polverose è la mia carne, raggrinzita è la mia pelle e si dissolve» (Gb 7,5).
La domanda di Giobbe non ruota dunque solo intorno all’enigma della sofferenza ingiusta, del dolore che colpisce l’innocente, ma investe innanzitutto la natura della Legge di Dio, il suo essere Padre, la sua responsabilità rispetto alla presenza del male nel mondo. Non a caso, come è stato notato da molti commentatori autorevoli, l’etimo del nome Giobbe (‘yyîôb) deriva dall’unione di due parole ebraiche: ‘ayyeh che significa «dove?» nella sua forma interrogativa e ‘ab che significa «padre»8. Il suo nome proprio si può quindi tradurre con la domanda: «Dov’è il padre?» Se Dio è il luogo di una potenza smodata, priva di un patto simbolico con l’uomo, Giobbe si chiede quale sia il rapporto di Dio con la paternità. Che razza di padre sarebbe, infatti, quello che perseguita i propri figli? Nel racconto biblico la figura santa e giusta di Giobbe stride con la sua mancanza di origini. Nessun cenno viene fatto sulla sua provenienza, su suo padre e su sua madre, sulla sua genealogia, salvo riconoscere che Giobbe non è ebreo, quasi a rafforzare cosí la sua difficoltà a conformarsi ai principî stabiliti dalla religione ufficiale. Questa mancanza di informazioni sulle origini di Giobbe non è affatto frequente nel testo biblico dove il tema della discendenza occupa sempre un posto di grande rilievo. Il vuoto dell’origine sembra radicalizzare l’interrogazione sul padre di fronte all’irruzione del male. L’assenza di origini di Giobbe rivela che anche nella sua stessa storia il padre non è innanzitutto una presenza ma un’assenza. Nondimeno è nel Padre che è nei cieli che Giobbe insiste nel riporre la sua fede. Egli non segue le indicazioni disperate della moglie di fronte all’accumularsi delle disgrazie – «Rimani ancora saldo nella tua integrità? Maledici Dio e muori!» (Gb 2,9) – , ma resta vincolato alla sua fede che però assume la forma di una interrogazione radicale, la stessa, appunto, che egli porta scritta nel suo nome come fosse un destino: «Dov’è il padre?» La centralità di questa domanda non scaturisce da una meditazione astrattamente teologica, ma dall’esperienza della sofferenza: Giobbe non è affatto una categoria astratta ma un soggetto colpito dalla violenza del male «nelle ossa e nella carne» (Gb 2,5). Di qui il suo grido che interroga: quale male egli ha commesso per essere distrutto nella propria vita e in quella dei suoi cari? Qual è la sua colpa? Può Dio, il creatore del mondo, acconsentire che l’innocente sia perseguitato, che il giusto sia violentato dalla sofferenza?
Questa domanda scaturisce dal suo estremo dolore; sorge dall’impatto traumatico con una serie di disgrazie che spogliano la sua vita di ogni bene consegnandola al male, ovvero a una sofferenza sorda, eccessiva e priva di senso9. Ma, come abbiamo appena visto, nel susseguirsi delle disgrazie e dei lutti, la perdita piú grave è quella dell’amicizia con Dio. Giobbe si sente perseguitato e, al tempo stesso, abbandonato dal suo Creatore, dal destinatario della sua stessa fede. La sua sofferenza già grande viene cosí tragicamente amplificata dalla imperscrutabilità della volontà del Padre e dalla sua manifesta inimicizia. Non a caso la morte di un padre segna sempre nella vita di ogni uomo un trauma destinato a essere uno spartiacque nella sua storia. Lo ricorda anche Lacan quando definisce il padre e la sua parola come l’unico «scudo» di fronte al male reale della malattia e della morte10. L’esistenza del padre protegge la vita dall’impatto con il carattere innominabile della morte mantenendo la vita associata al senso. Ma se la funzione prima del Nome del padre è quella di presidiare questa associazione, di mostrare che la vita umana accade ed è accolta nell’ordine del senso, il suo venire meno provoca l’effetto di una dissociazione profonda del senso dalla vita. La vita allora diviene oggetto di rifiuto, come accade in modo esemplare nei quadri clinici della melanconia ma anche nella vicenda di Giobbe che, ridotto a essere un grumo di disgrazie, maledice il giorno della sua nascita aspirando melanconicamente alla quiete inumana della morte: «Perisca il giorno in cui nacqui […]. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo?» (Gb 3,3-11).
L’esperienza umana del dolore genera uno scollamento traumatico del reale dell’esistenza dall’ordine simbolico del senso presieduto dal Nome del padre. Nemmeno l’esistenza di questo Nome può risparmiare ai propri figli il duro impatto col reale della sofferenza. Questo incontro frantuma lo scudo del padre ponendo il soggetto di fronte alla propria radicale solitudine e al proprio abbandono. Nel Libro di Giobbe la solitudine del figlio abbandonato dal Padre è protagonista della scena, come, del resto, accadrà anche nella notte del Getsemani per Gesú, il figlio unico e prediletto di Dio, che nel momento del massimo bisogno non ottiene risposta alcuna dal suo amato Padre11. Con l’aggiunta che per Giobbe, diversamente che per Gesú, lo scandalo diviene totale perché non solo Dio non si rivela come Padre amorevole, riparo, scudo, Legge che ordina il mondo, ma si erige come avversario incallito, come una irriducibile forza ostile. L’assenza non segnala qui solo la lontananza di Dio – il suo abbandono –, ma la sua ira. Sicché l’invocazione di Dio si capovolge nel timore angosciato di fronte alla sua potenza. Non è piú Dio che aiuta ma è necessario essere aiutati per sopportare i suoi soprusi violenti: «Sappiate dunque che Dio mi ha schiacciato e mi ha avvolto nella sua rete. Ecc...