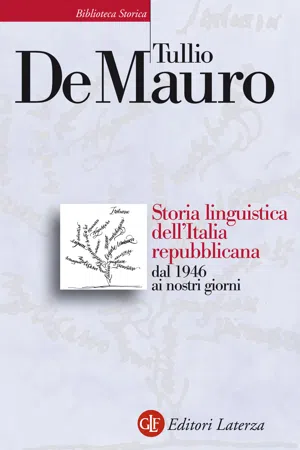1. Inno di Mameli e dintorni
L’inno (cinque strofe di otto senari e refrain di tre senari), oggi noto soprattutto come Fratelli d’Italia (3 milioni di pagine Google) o Inno di Mameli (ca. 700.000), col titolo Canto degli italiani e dapprima con l’incipit «Evviva l’Italia / l’Italia s’è desta», poi prontamente corretto e sostituito, fu scritto il 10 settembre 1847 dal poeta e patriota Goffredo Mameli (1827-1849), e musicato e presentato a Torino l’anno stesso, il 24 novembre, dal maestro Michele Novaro (cfr. L’Inno di Mameli musicato da Michele Novaro. Con note raccolte da A. Pastore e la musica trascritta pei giovanetti da G. Ferrari, Stabilimento tipolitografico generale dell’Annuario d’Italia, Genova 1889). Il poeta morì due anni dopo, ferito difendendo la Repubblica romana del 1849 contro le truppe francesi.
Nella bibliografia e tra le testimonianze, rari gli interventi simpatetici (Ignazio Baldelli, Fratelli d’Italia di Goffredo Mameli, in «Il Pensiero Mazziniano», n. LIII, 1998, pp. 57-62), frequenti le ripulse e prese di distanza. Hanno avuto notorietà quelle di Dario Fo, accompagnate da confusioni su chi fosse Scipio, che Fo scambiava per l’Emiliano «criminale razzista» mentre era per certo l’Africano (ma Fo poi mutò la sua valutazione negativa all’insorgere del leghismo: Elisabetta Rosaspina, «Corriere della Sera», 21 settembre 1977; Damiano Zito, «Il Fatto Quotidiano», 21 marzo 2011). Per altre notizie e critiche e discussioni cfr. Raffaello Monterosso, La musica nel Risorgimento, Vallardi, Milano 1948, pp. 195-198; Emilio Franzina, Inni e canzoni del Risorgimento, in Mario Isnenghi (a cura di), I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 115-152; Stefano Silvestri, Il 2 giugno e l’inno di Mameli, in «Golem. L’indispensabile», 30 novembre 1999; Tarquinio Maiorino, Giuseppe Marchetti Tricamo, Piero Giordana, Fratelli d’Italia. La vera storia dell’inno di Mameli, Mondadori, Milano 2001; Michele Serra, Per favore traducete l’inno di Mameli, in «la Repubblica», 7 aprile 2002; Stefano Pivato, Il Canto degli italiani: l’inno di Mameli, gli inni politici e la canzone popolare, in Maurizio Ridolfi (a cura di), Almanacco della Repubblica. Storia d’Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni e le simbologie repubblicane, Paravia-Bruno Mondadori, Milano 2003, pp. 145-160. Riecheggia in questi scritti il rimprovero di addensare in «strofe bolse e nazionaliste» (Spinelli) richiami storici e politico-diplomatici non a tutti noti (Scipione l’Africano, Legnano, Francesco Ferrucci, Vespri siciliani, Balilla, repressioni austrorusse contro polacchi e italiani) e di avere adoperato un lessico aulico (s’è desta per destata, Scipio per Scipione, s’è cinta la testa per si è messa in testa, coorte per schiera, calpesti per calpestati, speme per speranza ecc.), donde una presunta minore popolarità rispetto alla Bella Gigogin o a Garibaldi fu ferito ovvero, a Roma, E la breccia de Porta Pia / l’hanno vinta i bersajjeri. Tuttavia l’inno, cantato durante le Cinque giornate di Milano nel 1848 e poi dai Mille nel 1860, diventò rapidamente noto come Inno di Mameli o, dal suo verso iniziale, Fratelli d’Italia. Nel 1862 Giuseppe Verdi preparò per l’Esposizione internazionale di Londra un Inno delle Nazioni e alla Marsigliese e a God save the Queen per rappresentare l’Italia appena unita affiancò l’inno scritto quindici anni prima da Mameli.
Ufficialmente, e nonostante Verdi, l’inno restò a lungo in secondo piano, sopraffatto nelle cerimonie pubbliche dalla saltellante e adulatoria Marcia Reale del Regno di Sardegna (commissionata da Carlo Alberto re di Sardegna e composta nel 1831 da Giuseppe Gabetti, capobanda del Reggimento Savoia). A questa nel periodo fascista, dal 1925, fu d’obbligo affiancare l’Inno trionfale del Partito nazionale fascista, noto come Giovinezza, rifacimento, con parole di Salvator Gotta, di un altro rifacimento, quello degli Arditi durante la prima guerra mondiale, ripreso per le note da una canzoncina goliardica torinese, Il commiato, scritta nel 1909 dal giornalista Nino Oxilia e da Giuseppe Blanc e inserita due anni dopo da Oxilia e Sandro Camasio in Addio, giovinezza!, operetta, poi film, che consolidò la larga fortuna popolare della canzone a ridosso della prima guerra mondiale.
La memoria dell’inno di Mameli tuttavia sopravvisse nella comune cultura alla Marcia Reale e, nel ventennio fascista, all’accoppiata ufficiale di Marcia e Giovinezza. Fu messo in secondo piano, ma è difficile credere, come qualcuno ha supposto, che infastidissero gli elementi aulici e retorici, comuni nella versificazione ottocentesca e ancora in parte della poesia di D’Annunzio: la sensibilità linguistica antiaulica che nel tardo Novecento ha un giornalista come Michele Serra non era certo propria dei ceti dirigenti post-unitari (con le poche eccezioni di Francesco De Sanctis o Antonio Labriola). E del resto aulicismi, come brandi e cimieri, si incontrano a schiera nei canti e versi che contornano all’epoca l’inno (un buon quadro si ricava da Vanni Pierini, Versi e canti dell’Italia unita, 3 voll., Ediesse, Roma 2011, vol. I. Nascita d’una nazione (1796-1800), pp. 257-361). Molto più probabilmente infastidivano quel destarsi, quel volersi fare popolo unito e cercare, magari con l’aiuto del Signore ma non dei signori, le vie del riscatto. E in più i violenti accenti antiaustriaci non collimavano con gli equilibrismi diplomatici dello Stato unitario. Comunque nel primo Novecento, per esempio, le platee socialiste, capeggiate da Mussolini, allora in fase socialista massimalista, in genere per dileggiare oratori della destra del partito sensibili alle sollecitazioni unitarie di Giovanni Giolitti, lo intonavano e mostravano di averlo ben presente. All’inizio dell’«era fascista», nel 1924, da un verso dell’inno, «i bimbi d’Italia si chiaman Balilla» («Balilla» era il nick name dialettale del ragazzo genovese Giovanni Battista Perasso, iniziatore, tirando un sasso, della intifada antiaustriaca del 1746), fu tratto, passandolo da nome proprio a nome comune invariabile, balilla per designare i ragazzi inquadrati nella fascistica Opera nazionale Balilla, assorbita poi nella Gioventù italiana del Littorio. Nelle loro adunate Figli della Lupa (i più piccoli), Balilla (ragazzi più grandi) e Avanguardisti (adolescenti) erano tenuti a cantare l’inno di Mameli subito dopo l’Inno del balilla («Fischia il sasso / il nome squilla»). La notorietà dell’inno, restato sempre in ombra nelle cerimonie ufficiali degli adulti, fu garantita dal cerimoniale delle organizzazioni giovanili fascistiche.
Un segno di ripresa ufficiale si ebbe con il comunicato radio con cui il 25 luglio 1943 il governo presieduto dal generale Pietro Badoglio annunziò che il «cavalier Benito Mussolini» si era dimesso, che un nuovo governo si era insediato e che, in conclusione, «la guerra continua»: in apertura del comunicato, dopo la Marcia Reale, l’Eiar (l’emittente radio del tempo) mandò in onda l’inno di Mameli. Ma poi il governo Badoglio, firmato l’8 settembre l’armistizio con gli angloamericani e passato il Regno d’Italia dalla parte degli Alleati unendosi alla guerra contro l’ex alleata Germania, adottò come inno ufficiale la Canzone del Piave, composta da E.A. Mario (pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta) nel 1918, e l’inno di Mameli fu di nuovo messo da parte.
Formalmente, giuridicamente, fu anche incerto l’inizio del cammino di Fratelli d’Italia come inno ufficiale dello Stato repubblicano. Nell’ottobre 1946 il governo presieduto da Alcide De Gasperi dovette decidere quando e come provvedere alla prima rinnovata festa delle forze armate e al loro giuramento di fedeltà alla Repubblica. Il quando non pose problemi: la data fu quella del 4 novembre, ricorrenza della vittoria al termine della prima guerra mondiale. Il come era problematico: si temeva che alcuni ufficiali, fedeli alla monarchia, si rifiutassero di giurare ed era incerto lo svolgimento della manifestazione. Nella seduta del 12 ottobre il ministro della Guerra, Cipriano Facchinetti, massone rappresentante del Partito repubblicano italiano, propose la massima inflessibilità, cioè la radiazione, per chi (monarchico dichiarato o forse ancora di cuore fascista) avesse voluto sottrarsi al giuramento. E propose poi che nella cerimonia si eseguisse come inno ufficiale l’inno di Mameli. I verbali della seduta chiariscono che, con molta correttezza, il governo assunse la decisione in via provvisoria, annunziando che avrebbe poi sottoposto all’Assemblea Costituente, che esercitava al momento anche la funzione di organo legislativo, un provvedimento di legge che determinasse la materia in via definitiva. Del provvedimento non c’è traccia negli atti successivi del governo né in quelli della Costituente e probabilmente non fu mai formulato e inviato all’assemblea. Soltanto nel 2005 la discussione parlamentare si è riaccesa, senza approdare alla formalizzazione costituzionale dell’inno. Dal 1946, dunque, l’inno è diventato l’inno nazionale provvisorio e definitivo: un ossimoro emblematico di molte vicende italiane. Tuttavia il 14 giugno 2012 la Commissione cultura della Camera, con il voto favorevole di tutti i partiti tranne la Lega, ha approvato in sede legislativa un disegno di legge che promuove l’insegnamento dell’inno nelle scuole: un piccolo passo, anche se discutibile, verso l’ufficialità.
Ma per la storia sostanziale e non meramente formale dell’inno rispetto al 12 ottobre 1946 bisogna fare un passo indietro fino al 22 agosto 1943. I confinati politici antifascisti, da anni reclusi nell’isola di Ventotene, considerata confino di massima sicurezza, erano tornati formalmente liberi già da settimane, subito dopo il 25 luglio 1943 con la caduta del governo fascista e la nascita del governo Badoglio. Erano tuttavia rimasti bloccati sull’isola: tempo prima un caccia inglese aveva affondato l’unico piroscafo che collegava Ventotene a Gaeta e alla terraferma. L’attesa rischiava di prolungarsi, ma dopo varie settimane riuscirono a procurarsi una vecchia imbarcazione a vela («veliero» lo dicono le testimonianze) e la mattina del 22 agosto si accinsero a lasciare l’isola. Si erano radunati nel piccolo porto in attesa di imbarcarsi e gli isolani erano accorsi in gran numero per salutarli: nelle settimane di libertà ritrovata si erano stretti legami tra la gente del luogo e gli ormai ex confinati.
Specialmente popolare era uno di loro, Giuseppe Di Vittorio (1892-1957). Come il padre, curatolo di una grande azienda agricola morto precocemente, lui stesso, lasciata la scuola all’età di sette anni, per sostenere la famiglia era stato bracciante. Mentre continuava a studiare da autodidatta, era diventato dai primissimi anni del Novecento giovanissimo organizzatore sindacale socialista dei braccianti foggiani e pugliesi, poi, dal 1924, comunista. Più volte imprigionato, era stato esule in Francia, dove aveva riorganizzato un sindacato antifascista. Rientrato in Italia, fu arrestato e confinato a Ventotene. La sua popolarità tra gli isolani non si affidava solo alla fama di intransigente capo antifascista di contadini e operai. A Ventotene aveva ottenuto di poter affittare un piccolo campo e qui, con l’aiuto di qualche altro confinato, ma anche di contadini isolani, coltivava ortaggi, legumi e frutta e allevava una mucca e ne mungeva il latte, tutti alimenti preziosi per integrare la misera dieta dei confinati e degli ammalati.
A Di Vittorio e al vecchio inno toccò quella mattina del 22 agosto un ruolo decisivo. Ex confinati e isolani riuniti per un saluto festoso prima della partenza fraternizzavano, il chiasso cresceva, tutto stava prendendo la piega di una prima manifestazione politica dell’Italia libera. Richiamati da folla e voci, accorsero al porto i militari tedeschi che sull’isola presidiavano un potente aerofono. Preoccupati, si avanzarono minacciosi ad armi spianate. Sulla folla piombò il silenzio. Forse, secondo alcuni, gli fu suggerito da un altro degli ottocento confinati, Girolamo Li Causi (1896-1977: dirigente socialista, aderente al Partito comunista d’Italia dal 1924, nel 1926 arrestato e condannato a 21 anni di carcere e confino a Ventotene). Certo è che Di Vittorio saltò in piedi su un muretto e, sventolando allegramente un fazzoletto, recuperò l’atmosfera di un festoso saluto d’addio e intonò a voce stentorea l’inno che aveva in mente, appunto Fratelli d’Italia. Ex confinati e isolani lo seguirono con entusiasmo cantando in coro l’inno che evidentemente non era stato dimenticato. Italiani che cantavano una canzone: i tedeschi si rassicurarono e si ritirarono, quella non era una manifestazione politica, l’inizio d’una sommossa, ma una simpatica festicciola patriottica d’addio. Sbagliavano: era un inizio.
Intonato in tal modo a Ventotene, l’Inno degli italiani tornò in effetti a risuonare poche ore dopo, all’arrivo a Gaeta. Mentre il veliero approdava, su una nave da guerra ancorata nel porto si affollarono i marinai per vedere da vicino e per salutare gli antifascisti che tornavano. I marinai, incerti, volevano intonare un canto di benvenuto. Non poteva essere Giovinezza, la canzone da operetta trasformata in inno nazionale fascista: il fascismo era crollato da poche settimane tra universale giubilo. La saltellante Marcia Reale, ancora lecita, parve ragionevolmente inadatta: in esilio, nelle carceri, al confino, quelli sul veliero c’erano stati mandati con regi decreti e monarchici consensi. Qualche marinaio, sembra però senza trovare riscontro in una risposta corale, provò a intonare l’Internazionale, la cui memoria evidentemente era sopravvissuta tra le mura domestiche durante gli anni della dittatura fascista. In verità anche gli ormai ex confinati avrebbero voluto cantare qualcosa, ma erano incerti. L’Internazionale (che qualcuno, come Altiero Spinelli, provò a canticchiare) non andava bene per i parecchi confinati non socialisti o comunisti e talora fieramente anticomunisti. Altiero Spinelli, confinato sull’isola da cui nel 1943 aveva lanciato con Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi il manifesto federalista per l’unità d’Europa, ha raccontato che sul veliero i comunisti si appartarono per consultarsi tra loro e quando già la nave era alla banchina di nuovo intonarono l’inno di Mameli. E ancora una volta tutti, confinati e marinai, senza più incertezze, si unirono lasciandosi coinvolgere nel coro.
Su confinati, loro liberazione, ritorno da Ventotene a Gaeta, inno, cfr., oltre al racconto di Altiero Spinelli riportato in Silvestri, Il 2 giugno e l’inno di Mameli, cit., le testimonianze di Filomena Gargiulo (di cui si veda anche Ventotene isola di confino. Confinati politici e isolani sotto le leggi speciali 1926-1943, L’ultima spiaggia, Genova 2009) e di Francesco Giasi, entrambe raccolte in occasione del convegno A 50 anni dalla scomparsa di Di Vittorio. Gli anni del confino (Ventotene, 4-5 ottobre 2008), accessibili in rete nel sito della Fondazione Di Vittorio. Sulla vicenda umana, politica e linguistico-culturale di Di Vittorio, “evaso” dalle prigioni dell’analfabetismo con la fortunosa scoperta del «libro in cui ci sono tutte le parole», e cioè un vocabolario, cfr. La vita di Giuseppe Di Vittorio raccontata da Felice Chilanti (costruita con interviste allo stesso Di Vittorio), apparsa nel 1953 a puntate in «Il Lavoro», ora nel sito di «Rassegna Sindacale», www.rassegna.it.