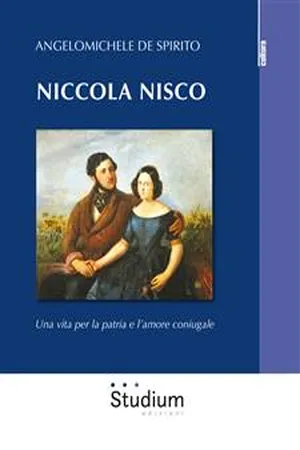Quando il 29 settembre
1816 a San Giorgio la Montagna – dal 1860 in provincia di Benevento
e dal 1929 denominato San Giorgio del Sannio – nasceva Niccola
Nisco, da Giacomo e Onorata Corona, nel Sud d’Italia sorgeva una
nuova entità statale: il Regno delle Due Sicilie; il cui re,
Ferdinando IV di Borbone, prese il nome di Ferdinando I. L’anno
innanzi era terminato il Congresso di Vienna, che, segnando la fine
dell’impero napoleonico in Europa, dopo la battaglia di Waterloo,
aveva sancito il consolidamento della Restaurazione e dei sovrani
assoluti anche in Italia. Il nuovo assetto politico, deciso dalle
potenze vincitrici: Austria, Russia, Prussia e Inghilterra, si
articolava in dieci Stati, il più antico e il più popoloso dei
quali era il Regno di Napoli e di Sicilia con 6 milioni e 700 mila
abitanti su di un totale di 20 milioni; e comprendeva tutto il
Meridione, ad eccezione di Benevento, che fin dal 1077 apparteneva
allo Stato pontificio.
In quello stesso anno 1815, erano falliti anche i tentativi di
Gioacchino Murat – dal 1808 re di Napoli per volere del cognato
Napoleone –, di sollevare le popolazioni italiane contro la
dominazione austriaca e creare una nazione unita e indipendente.
Per questo, nel
Proclama di Rimini, del 30 marzo, egli aveva spronato gli
italiani affermando: «L’ora è venuta in cui debbono compiersi gli
alti destini d’Italia. La Provvidenza vi chiama ad essere una
nazione indipendente [...]. Stringetevi saldamente ad un governo di
vostra scelta». Certamente, quel proclama, ritenuto in seguito il
punto di partenza del Risorgimento italiano, era l’espressione dei
sentimenti di uomini appartenenti ad una aristocrazia colta e
geniale, come Pellegrino Rossi, che lo aveva scritto, o come Silvio
Pellico, Cesare Balbo e Alessandro Manzoni, che lo evocava nei
versi:
O delle imprese alla più degna accinto,
Signor che la parola hai proferita,
che tante etadi indarno Italia attese…
Ma, altrettanto certamente, quel pressante invito non
rispecchiava i sentimenti e le idee di tutto un popolo. Il quale,
al di là della “mala volontà” dei suoi governanti, si trovava a
subire proprio in quei due anni e in tutta Europa anche la
carestia, il cui impatto sulla
situazione economica suscitava, in diverse parti d’Italia,
manifestazioni di malcontento, e perfino tumulti, prontamente
repressi. Né mancavano diffuse epidemie, come i molti casi di peste
verificatisi soprattutto in Puglia.
Va però ricordato che dalla Restaurazione del 1815 fino
all’assedio di Gaeta del 1860 – in quasi mezzo secolo di governo
borbonico –, nel regno non si ebbero aumenti di tributi; che anzi
spesso diminuirono. C’erano: una sola tassa diretta, la fondiaria,
che in gran parte fu messa durante il decennio francese, e quattro
indirette: una sulla dogana dei tabacchi, sali, polveri da sparo e
carte da gioco, e tre sul registro, la lotteria e le poste.
«Provammo co’ fatti – scrive lo storico Giacinto de’ Sivo
(1814-1867) – il miglior governare esser quello che costa meno.
Calcolate le imposte sulle popolazioni, ogni Napolitano pagava lire
14 di tasse all’anno, dove ogni Piemontese ne pagava 28». Sulla
buona tenuta delle finanze napoletane, che al momento
dell’unificazione contribuirono più d’ogni altro Stato ad
arricchire l’Italia, dà conto anche Francesco Saverio Nitti
(1868-1953), notando i 443 milioni di lire oro corrisposti dal
Regno delle Due Sicilie a fronte di neppure la metà del resto della
Penisola. Il Mezzogiorno, poteva egli dire, «nel 1860, era un paese
povero, ma aveva accumulato molti risparmi, avea grandi beni
collettivi, possedeva, tranne la educazione pubblica, tutti gli
elementi per una trasformazione». E questa non avvenne; anzi fu
ostacolata dai nuovi governanti “unitari”.
È vero che c’era il «protezionismo borbonico», di cui parla
anche Niccola Nisco, ma quella politica protettiva – scadente
talvolta nel “paternalismo” –, almeno inizialmente era l’unica
possibile, data la scarsità di materie prime essenziali, per
avviare il regno a dotarsi di proprie industrie, formare manodopera
specializzata, acquisire tecnologie e rafforzare l’indipendenza e
la neutralità. Tuttavia, che si possa parlare di una “tradizione
industriale” del Mezzogiorno, lo dimostrano non pochi studi,
iniziati a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, i quali
evidenziano come il settore più avanzato fosse quello siderurgico e
metalmeccanico. L’opificio di Pietrarsa, tra Portici e San Giovanni
a Teduccio, dava lavoro a più di 1.000 operai, disponeva di una
fonderia, produceva artiglierie navali e terrestri, macchine a
vapore, locomotive ecc.; e servì da modello – sei anni dopo – a
quello di Sampierdarena, vicino a Genova, ma con soli 480 operai.
Lo stesso dicasi per le dimenticate ferriere e fonderie di Mongiana
in Calabria; o dei primi pozzi artesiani introdotti in Italia, come
riferisce Giuseppe Buttà. All’indomani dell’unificazione, il primo
censimento del Regno d’Italia registrava nell’ex territorio
borbonico un numero complessivo di occupati nell’industria pari a
1.189.000, a fronte degli operai di Lombardia, Piemonte e Liguria,
che raggiungevano appena gli 810.000.
La marina mercantile siculo-napoletana, che nel 1856 contava
11.500 legni, era per tonnellaggio la terza in Europa, e tra le 25
Compagnie di navigazione primeggiava la «Società delle Due
Sicilie», anche a detta di Nisco «la più poderosa in Italia». I
Cantieri Reali di Castellammare costituivano l’eccellenza mondiale
per la fabbricazione di navi da guerra. L’industria molitoria, con
oltre 300 impianti e le più grandi fabbriche di paste alimentari;
la lavorazione di pelli e cuoio, tanto diffusa da poter fare a meno
della importazione; il settore tessile, con l’industria della seta,
facevano concorrenza a quelle estere; mentre lo stabilimento di San
Leucio, vicino a Caserta, voluto nel 1789 da Ferdinando IV, e in
origine direttamente comunicante col parco della reggia, era
divenuto famoso anche per l’organizzazione del lavoro e il buon
governo di quella comunità.
Last but not least, ancora dal suddetto censimento si
apprende che, se al Nord c’erano 7.087 medici per 13 milioni di
cittadini, al Sud ce n’erano 9.390 per 9 milioni. E in tempi e
luoghi di economia essenzialmente agricola – non solo nel Sud –, di
pauperismo “globalizzato” e di situazioni igienico-sanitarie oggi
inimmaginabili, accadeva che all’inizio del Novecento i livelli più
bassi di mortalità infantile si registravano proprio in Campania,
negli Abruzzi e in Sardegna; mentre fino alla fine dell’Ottocento i
più alti esistevano in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Che
sono le regioni citate esemplarmente da Nisco, per «quelle
istituzioni civilizzatrici di cui – a suo dire – erano dotati i
loro villaggi». Ma, nonostante quanto fin qui sommariamente
esposto, egli, divenuto antiborbonico dopo il 1848, osava
“malignare”, parlando di «un paese – il Regno delle Due Sicilie –
dai Borboni economicamente sgovernato per poi sbrigliatamente
tiranneggiarlo».
Riguardo all’
ordinamento etico-politico, grazie all’opera di alcuni
ministri illuminati, come il cardinale Ercole Consalvi a Roma o
Luigi de’ Medici a Napoli, in quei primi anni vennero impediti gli
eccessi di una restaurazione intransigente; che, anzi, talvolta
riusciva a trovare una certa continuità con il riformismo
settecentesco. Pertanto, se Pio VII, rientrato a Roma dalla
prigionia francese, soppresse la tortura e abolì diritti e
privilegi feudali; Ferdinando IV, rientrato a Napoli dalla Sicilia,
graziò i 250 compagni dell’ultima impresa di Murat, espellendoli
dal regno, che essi volevano riconquistare. Ma a lui il re
“dovette” comminare la pena capitale, il 13 ottobre 1815, in forza
di quel codice penale dallo stesso Murat precedentemente
promulgato, contro chi si fosse macchiato di atti rivoluzionari.
Nacque così il detto popolare: «Giacchino facette ’a legge e
Giacchino murette acciso», a significare che chi è causa del suo
male pianga se stesso. Un monito ben noto pure a Nisco e a molti
suoi contemporanei e “compagni di sventura”. Anch’io l’ho ascoltato
più volte nella mia infanzia. Ma solo dopo molti anni ho potuto
capire chi fosse realmente quel misterioso e ambiguo «Giacchino».
Intanto nel regno, sebbene fosse stata sciolta la setta
reazionaria dei
Calderari, che, a difesa di una piena restaurazione,
raccoglieva baroni dell’aristocrazia meridionale ed anche elementi
provenienti dalle bande brigantesche borboniche, negli ambienti
liberali i nostalgici dell’età napoleonica, i costituzionalisti e i
rivoluzionari non cessavano di riorganizzarsi in società segrete
con ascendenze massoniche e diversi gradi di iniziazione. Al
riguardo, l’8 agosto 1816, cinquanta giorni prima che Nisco
nascesse, fu emanata una legge, che – regolarmente pubblicata anche
sul
Giornale dell’Intendenza di Principato Ulteriore – si
rivelò quasi un presagio o un saggio avvertimento, che un giorno lo
avrebbe personalmente riguardato e privato, per alcuni anni, della
libertà, perché sarà arrestato e «condannato come settario».
Il re Ferdinando, infatti, su proposta del ministro di grazia e
giustizia, il marchese Donato Tommasi, e udito il Consiglio degli
altri ministri, vietava «le associazioni segrete che costituiscono
qualsivoglia specie di
setta, qualunque sia la loro denominazione, l’oggetto ed
il numero de’ loro componenti»; e le dichiarava «manifesti
attentati alla legge». Puniva i trasgressori con «la pena del bando
da’ nostri reali dominj da cinque a venti anni»; e per chi
concedeva la propria abitazione per le riunioni, da tre a dieci
anni, più una multa da dieci a cinquecento ducati. Anche chi
conservava «emblemi, carte, libri o altri distintivi della
setta» sarebbe stato punito con la prigione da uno a
cinque anni.
Queste rigide norme erano spiegate e motivate dal fatto che «gli
sforzi che tali associazioni fanno per circondare di mistero
l’oggetto delle loro instituzioni, i simboli religiosi che talune
di esse fan servire a materie profane, spargono giustamente la
pubblica diffidenza sulle loro operazioni». Sebbene all’inizio è
possibile che si propongano finalità innocue, col passar del tempo
e «secondo l’impulso delle circostanze, possono facilmente
degenerare in unioni criminose». Infine, la loro reciproca
opposizione sui princìpi che le regolano, «creano lo spirito di
fazione, di turbamento e di discordia civile». Tuttavia, nonostante
queste proibizioni, la
Carboneria, diffusa particolarmente nel Sud, con le sue
«vendite» o sezioni – nel 1820 solo in Irpinia 192 –, e con
ramificazioni in altre parti d’Italia, continuava clandestinamente
la sua attività. Per cui, cinque anni dopo, anche Pio VII, il 13
settembre 1821, la condannò, in quanto «imitazione, se non
emanazione», della Società dei Liberi Muratori o Massoni.
Oggi, senza voler completamente accogliere il poco generoso
giudizio di George Bernanos, che, ne
I grandi cimiteri sotto la luna (1938), opinava essere
l’unificazione d’Italia «la creazione più pura della massoneria
universale del diciannovesimo secolo», va quantomeno tenuto
presente quel che, il 16 maggio 1925, alla Camera dei deputati,
pure Antonio Gramsci faceva notare: «La massoneria in Italia ha
rappresentato l’ideologia e l’organizzazione reale della classe
borghese capitalistica». E ad essa appartennero sia uomini di
Destra che di Sinistra: da Cavour, che fu Gran Maestro, a
Garibaldi, Depretis, Crispi, Bixio, De Sanctis, Zanardelli e molti
altri.
In campo culturale e artistico, nel Regno borbonico, qui
basti ricordare, ed emblematicamente considerare, come proprio
nell’anno in cui nacque Nisco, la notte del 16 gennaio un incendio
distrusse il
San Carlo di Napoli, che aveva come direttore musicale
Gioacchino Rossini. Era il più antico e uno dei più bei teatri
lirici al mondo, voluto ottant’anni prima da Carlo III, che aveva
regnato dal 1735 al 1759. Ricostruito ed inaugurato meno di un anno
dopo, sarà il luogo dove – come vedremo –, il 12 gennaio 1848,
alcuni estrosi liberali inscenarono una manifestazione patriottica,
servendosi proprio del palchetto riservato a Nisco e consorte. In
quell’anno e nel precedente, c’erano in cartellone due opere di
Giuseppe Verdi: l’
Attila, con la cavatina del prologo
Santo di patria indefinito amor; e il
Nabucco, col celebre coro del
Va’, pensiero. Ancora nel 1816, poco distante da quel
teatro, prospiciente il Palazzo reale, Ferdinando I eresse la
basilica di S. Francesco di Paola, dalla cupola solo inferiore a
quelle di S. Pietro in Roma e di S. Maria del Fiore a Firenze. Là,
in quel fatidico 1848, suo nipote Ferdinando II giurò solennemente
la promessa Costituzione. E non molto lontano, al rione
Pizzofalcone, nei primi anni del suo lungo soggiorno napoletano,
dimorava lo studente Niccola Nisco.