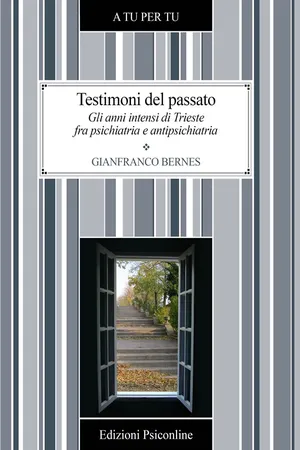![]()
1973
Il 4 gennaio si fece la prima riunione delle 5 del 1973. Non era molto affollata, però c’erano i medici di Gorizia, pronti a inserirsi nel nostro ospedale, Vittorio e Giuliano.
“I colleghi di Gorizia” disse Basaglia “rimarranno con noi. Questi, invece, sono mio cugino Vittorio e Giuliano. Gli ho invitati a Trieste perché inventino qualcosa di nuovo. Con loro ci sarà da lavorare, per questo penso si possa mettere a disposizione il padiglione P, da poco svuotato.”
Vittorio, pittore e scultore, viveva con intensità il suo lavoro proiettandolo in situazioni di estrema avanguardia che, per quei tempi, poco forse sapeva di arte avendo una connotazione prettamente sociale. Giuliano, invece, era un uomo di teatro e uno scrittore attento, molto sensibile nei rapporti e supportato da una notevole cultura.
“Inventare qualcosa è troppo vago” disse Caretti.
Giuliano colse al volo la battuta. “Noi non siamo psichiatri, o artisti guaritori. Non siamo venuti a guarire con l’arte, cioè a fare arte terapeutica che ci sembra pericolosamente equivoca, e neanche siamo venuti per creare opere d’arte, né psicodrammi, ma per unire la nostra azione allo sforzo di tutti voi. Siamo qui per fare qualcosa che va inventato giorno per giorno, e tenuto teso e vivo per un tempo abbastanza lungo, vale a dire due mesi, il periodo che ci siamo imposti assieme a Basaglia.”
“Cercheremo di coinvolgere tutti e avremo bisogno di altre persone che, come prima qualità, dovranno essere umanamente disponibili.” Aggiunse Vittorio e subito dopo illustrò il programma.“Si tratterà di animare i grandi oggetti, usandoli come pretesti e stimoli, facendo nascere intorno a essi una gran quantità di avvenimenti, immaginandoli e discutendoli collettivamente.”
Il progetto prevedeva due schemi di lavoro e nel primo si doveva fabbricare un grande oggetto.
“Si costruisce una casa” spiegò Vittorio “che diventa poi una casa fantastica dove ci piacerebbe abitare. Dopo la casa bisogna far nascere altri oggetti, i personaggi. Penso a dei pupazzi, attorno ai quali inventeremo delle storie. Come obiettivo ho detto la casa, perché mi piacerebbe costruirla, ma si potrebbe fare qualcosa d’altro.”
Il secondo schema riguardava l’informazione permanente. Fu Giuliano a spiegarlo.
“Tutti dovranno sapere cosa stiamo facendo e noi lo comunicheremo attraverso vari canali, che potrebbero essere questi: il giro dei reparti per avere un contatto personale, un volantino quotidiano per informare tutti sull’andamento del lavoro, il giornale murale, dove si disegnerà e si scriveranno gli avvenimenti della giornata e sarà portato in ogni reparto. Infine il teatro vagante, posto su un carretto, per portare in giro i materiali costruiti e farli vedere a tutti.”
“Avete carta bianca.” Sentenziò Basaglia
“Noi proponiamo un tipo di lavoro a partecipazione, di cui possiamo intravedere solamente le linee generali. Non si può sapere quale sarà lo svolgimento, perché questa è un’esperienza nuova per tutti. Sarà molto importante una collaborazione generale.” Queste parole uscirono da Vittorio con molta determinazione. Aveva recepito l’indifferenza di alcuni di noi, ma la cosa non lo sconvolse, anzi mi sembrò stimolato.
Il giorno dopo un’ala del P, con tre grandi stanze luminose, fu destinata al nuovo lavoro. Il vecchio padiglione si riapriva, questa volta non per rinchiudere il dolore ma per ospitare l’allegria.
“Lo chiameremo laboratorio P” disse Vittorio, mentre assieme a Giuliano e a Federico, un giovane pittore veneziano appena arrivato, stava cercando il materiale utile per il lavoro. Serviva un po’ di tutto: colori, carta, pennelli di ogni dimensione, legname, chiodi, cartone, collanti. Con l’aiuto di alcuni operatori e di qualche degente volonteroso fu setacciato l’ospedale e, in poco tempo, gran parte dell’occorrente fu trovata. Il difficile era come mettere in pratica le idee affinché il tutto non fosse recepito come un gioco, con il pericolo di allontanare maggiormente la realtà che stava al di fuori di queste mura.
La riunione per creare il primo volantino si protrasse sino alle due di notte. Si trattava di una seduta abbastanza ristretta con presenti i tre veneziani, Basaglia e sua moglie, Maria Grazia, una giovane sociologa da poco unitasi all’équipe, Caselli e io.
Si discusse su come elaborare il foglio affinché le parole e le immagini potessero essere capite da tutti.
“Dato che vogliamo essere considerati per quello che siamo, dobbiamo assegnarci un nome.” Era questo per Vittorio il primo obiettivo da raggiungere.
“Pittori sarebbe il termine più logico” affermò Basaglia.
“Anche insegnanti o registi” aggiunse sua moglie.
Sembrava una sciocchezza ma l’argomento invece era profondo, perché la qualifica con la quale il gruppo si sarebbe presentato poteva significare il successo o meno di questa scommessa, come io l’avevo chiamata parlandone con Caselli.
Alla fine Giuliano propose di usare il termine artisti “in modo che per tutti sia chiaro che siamo venuti qua a proporre di fare cose che riguardano il nostro mestiere.”
Trovare un carretto per il teatro vagante non fu difficile. Qualcuno ricordò che sulla “montagna”, nell’ex scuderia, ce n’era uno rosso e verde, appartenente alla storia del manicomio. Sino allo scorso autunno ogni giorno era trainato da un cavallo per trasportare i cambi di biancheria dai padiglioni alla lavanderia e viceversa. Il rumore degli zoccoli e delle ruote sull’asfalto era un appuntamento quasi per tutti. “Arriva Marco Cavàl”, questo era il suo nome, ed era un avvenimento per il manicomio: una stereotipia del luogo.
Marco Cavallo aveva tanti anni e ormai faceva fatica a raggiungere la montagna. Basaglia decise di metterlo in pensione, ma appena circolò la voce che sarebbe stato ammazzato ci fu un’autentica sommossa e una petizione con quasi un migliaio di firme lo salvò dal mattatoio. Venne messo in vendita e ad acquistarlo fu il farmacista, per portarlo in un paesino del Friuli. La sua partenza pose fine a un capitolo del manicomio e, dopo cinque mesi, il rumore di quegli zoccoli mancava a tutti.
Gli artisti si muovevano per l’ospedale alla ricerca di contatto e comunicazione. I degenti li guardavano senza troppo interesse e parecchi medici e infermieri mostravano totale indifferenza. Così il primo giro per i reparti con il numero uno del giornale murale e del volantino non fu un successo. Molti leggevano più che altro per curiosità, ma non sembravano né interessati né attratti. Qualcuno addirittura mostrava un netto rifiuto.
Il terzo giorno non si registrarono progressi. Alcuni ricoverati, sollecitati dal collega Della Pozza che molto si adoperava per animare il laboratorio, si avvicinarono, mostrando ancora indifferenza. Qualcuno accennò a disegnare, qualche altro disse poche parole, ma tutto sapeva di forzato.
Nella riunione serale Giuliano era deluso. “Siamo imbarazzati perché non sappiamo quali parole usare e i malati sembrano assenti.”
“Ognuno di noi deve vivere in modo critico e creativo il proprio ruolo. Voi come artisti, noi come psichiatri.” Affermò Basaglia.
“Per un artista deve essere essenziale il superamento continuo della sua espressività ripetitiva, dei suoi stereotipi.”
Su queste parole di Vittorio, Basaglia insorse quasi con violenza. “Artista è chiunque esce dal proprio cerchio e reinventa il suo ruolo nel rapporto con gli altri.”
Fortunatamente il giorno seguente, nonostante una forte Bora che quasi distrusse il carretto, il laboratorio si animò. Evidentemente l’invito del volantino numero due aveva fatto effetto: sul foglio a grandi lettere era scritto “Venite tutti al laboratorio P”.
Vittorio spiegò il lavoro da fare. “Dobbiamo costruire un grande oggetto.”
In un angolo Angelina stava disegnando un cavallo, dividendone la pancia in piccoli rettangoli.
“Perché fai quei rettangoli?” chiese Giuliano.
“Vorrei far entrare nel cavallo tante cose.”
“È una bella idea.”
“Avete detto che volete fare un grande oggetto? Perché non facciamo un cavallo?” disse Angelina alzandosi tutta sorridente.
L’idea di costruire un cavallo fu il toccasana che coinvolse molta gente. Era ancora vivo in tutto l’ospedale il ricordo di Marco Cavallo, perciò il progetto non poteva che trovare grandi consensi. Il laboratorio P divenne l’appuntamento obbligatorio della giornata, creando incontri, amicizie, discussioni e facendo rivivere tante storie, sinora rimaste chiuse nelle grandi stanze dei padiglioni di degenza.
I freddi ambienti del P si riempirono di vita. Arrivò Silvana, un’ex maestra da tempo ricoverata nel reparto O. Lei era sempre cupa e apatica, non parlava quasi mai con gli altri degenti. Le sue giornate le trascorreva stando inginocchiata in mezzo al reparto e più volte lo sconforto l’aveva portata a cercare il suicidio. La sua era una patologia grave, insorta dopo un incidente con uno scolaro. La sua melanconia appariva evidente: era come avvolta in un tabarro di dolore.
Marina, l’infermiera che l’aveva accompagnata, s’illuminò quando vide un piccolo sorriso stamparsi sulla bocca di Silvana. Lo fece mentre raccoglieva una scatola di pastelli con la figura di Giotto. Iniziò a disegnare dimostrando subito la sua cultura scolastica. Chiamava Vittorio “signor maestro”, provocandogli una grossa emozione.
Sergio si presentò improvvisamente al laboratorio. Lui appena letto il primo volantino, l’aveva posato su una siepe dicendo agli artisti: “No, non vengo, voi mi portate via il lavoro, se vengo da voi non lavoro più io.” Sergio, infatti, sulla “montagna” aveva un piccolo laboratorio di ceramica. Di lui si diceva che era stato un valido tennista e un giorno cominciò ad abbattere la propria casa per costruire al suo posto un campo di tennis. Ora amava dipingere ininterrottamente le porte di verde e quando smetteva si dedicava alla fisarmonica. Con la musica ci sapeva fare e per questo gli fu chiesto di trasformare una sua canzone in quella di Marco Cavallo, l’oggetto di cartapesta già progettato da Vittorio, diventato un emblema per tutti.
Giovanni era entrato in ospedale nel 1949 con diagnosi di schizofrenia. Negli ultimi vent’anni la sua unica occupazione era quella di rifare i letti del padiglione P. Era schivo e parlava sempre sottovoce, specialmente con i medici, verso i quali portava enorme rispetto, dettato, forse, da un senso di paura. Qualche volta accennava al lavoro nei campi e parlava di Messina. Da molti anni, periodicamente, scriveva una lettera a un medico con allegate 500 lire. Erano parole buttate sulla carta, a tratti incomprensibili, con le quali chiedeva un pezzo di terra in ospedale per seminare, a seconda delle stagioni, il grano oppure le patate. Le 500 lire erano il prezzo che voleva pagare affinché il medico s’interessasse al suo caso.
Giovanni era nato vicino Umago, in Istria, e aveva sempre fatto il contadino sino a quando, appena finita la guerra nel 1945, fu coinvolto, come tanti istriani, nell’esodo che lo portò a Trieste, allora Territorio libero governato dagli anglo-americani, e poi all’ospedale psichiatrico che, alla fine degli anni Sessanta, era pieno d’istriani vissuti nei campi profughi.
Della Pozza, sempre presente in tutte le attività, era attualmente il destinatario delle lettere. Un giorno decise di portarlo al laboratorio e, davanti a un enorme foglio bianco, Giovanni cominciò a disegnare una storia. Ne uscì una barca con dentro quattro persone. Indicando la barca disse: “Questa è Messina”. Poi, mostrando le persone, “Questo è mio padre Giovanni. Ecco Antonio. Ecco Guerrino. E questo sono io.” Antonio e Guerrino erano i fratelli.
Un disegno, neanche tanto ben fatto, aveva ricostruito un momento di vita, forse uno dei più belli, ai quali Giovanni, in venticinque anni di manicomio, aveva dedicato tanti momenti e tante lacrime, come quelle che, dopo aver sentito la storia, rigavano il volto di alcune persone le quali, per camuffarle, tossivano e si soffiavano il naso.
Il giorno dell’Epifania, Carla era stata dimessa perché suo padre stava male. Non era questa la prima volta poiché spesso, anche se per brevi periodi, viveva nella casa paterna di Prosecco, una frazione molto bella vicina Trieste. Da ricoverata il suo posto fisso era il Q, l’Osservazione, con qualche puntata anche all’O, il reparto agitate, che affiancava il D, dov’era ricoverato Giovanni.
Si erano conosciuti, o meglio si erano visti e guardati, una domenica di tanti anni fa nella chiesa dell’ospedale. Lei seduta sulle panche di sinistra, lui in quelle di destra, perché allo psichiatrico questa era la regola che andava rispettata sempre, anche nelle passeggiate. L’arrivo di Basaglia aveva tolto questa specie di senso unico, perciò il rapporto tra i due si era fatto più vicino e tutti pensavano che si volessero bene.
Giovanni non usciva mai, perciò quando Carla andava in permesso lo veniva a trovare per portargli le sigarette. Lui molto raramente riceveva visite, poiché la madre viveva in Istria e suo fratello era troppo impegnato. Aveva vissuto male da emigrato in Germania ed era rientrato con solo gli occhi per piangere. Non ce la faceva a reggere ed era finito in manicomio, dove spesso aveva pensato di porre fine ai suoi giorni.
Il primo vero incontro avvenne il Natale del 1971. Da allora furono sempre più uniti e quando, verso la fine del 1972, Carla fu costretta a letto Giovanni non la abbandonò mai e, per la prima volta, in entrambi sorse la volontà di abitare assieme.
Dopo pochi giorni che Carla era stata dimessa, suo padre fu ricoverato a San Giovanni per uno stato di agitazione. Così, pur essendo “libera”, passava quasi tutta la giornata allo psichiatrico: un po’ con il papà, di più con Giovanni, che ora stava meglio. Carla, frattanto, aveva iniziato a lavorare nella trattoria del fratello, per cui quando il padre fu dimesso, dovendo assisterlo e non potendo venire a trovare Giovanni, chiese ed ottenne che fosse lui ad andare a farle visita alla domenica a Prosecco. Era l’inizio di una delle prime storie d’amore nel nostro manicomio.
Nadia, con i suoi genitori, abbandonò Capodistria alla fine degli anni Cinquanta, in quella diaspora di migliaia di persone che non accettarono il regime jugoslavo del maresciallo Tito. Era una famiglia povera: il papà tappezziere e la mamma a servizio nelle case per guadagnare lo stretto necessario per vivere.
Sin da piccola Nadia aveva avuto problemi e per i medici abbisognava di attenzioni e affetto materno, cosa non facile perché la mamma stava tutto il giorno al lavoro. Nel 1951, quando aveva quattro anni, varcò il cancello di via San Cilino per entrare nell’Istituto medico pedagogico, quello vicino alla direzione, fatto costruire dal barone de Ralli. Qui frequentò le elementari, aspettando la domenica quando il padre, ma molto più spesso la nonna, la venivano a prendere. Salivano sul tram, che a lei tanto piaceva, e andavano vicino al mare a vedere le barche. Con il padre aveva un rapporto sufficientemente buono. Negativo era invece quello con la madre che era intollerante e non l’accettava affettivamente, per questo Nadia aveva sempre delle reazioni nei suoi confronti, anche violente.
Ogni rientro era un trauma. L’allontanarsi dei suoi per lei significava abbandono, una sensazione tremenda che feriva sempre più gli affetti, provocando un dolore, trasformato in un pianto e soffocato in fievoli lamenti che si perdevano in due parole: papà, nonna.
Intorno ai quindici anni, come quasi tutti i bambini del pedagogico, fu “promossa” al manicomio, dove si adagiò al ritmo quotidiano, scandito dai soliti orari che imponevano la sveglia, il pranzo, la cena e il dormire. La giornata era sempre la stessa e andava consumata tra il letto e il grande camerone-soggiorno, dove le degenti camminavano in lungo e in largo urtandosi e senza mai parlare. L’unico rapporto per Nadia, la più giovane di tutte, era quello di qualche scambio, come una caramella per una sigaretta. Stava sempre accanto alla finestra, quella rivolta all’uscita, come se aspettasse qualcuno. Le mani erano in continuo movimento, impegnate con un oggetto qualsiasi che faceva passare dal palmo alle dita e da una mano all’altra.
Quando aveva vent’anni la nonna morì e lei rivolse il suo affetto a Graziella, un’assistente sociale. Poi, nel 1972, le porte si aprirono e Nadia cominciò a uscire, accompagnata, dall’ospedale. Le piaceva salire sull’autobus, che aveva sostituito il suo amato tram, ed entrava nelle tabaccherie per acquistare caramelle, sigarette, cartoline e tutto ciò che brillava. Si accorse che gli uomini la guardavano, ma non capiva il perché.
Ai genitori chiedeva di rimanere in casa. Per lei, ora che aveva annusato il sapore della libertà vivendo la città e i negozi, il rientro serale la colmava di tristezza e i suoi episodi di negatività non trovavano sollievo nemmeno con i farmaci. I colori le piacevano, per questo partecipava all’attività del laboratorio P, compiacendosi, adesso che sapeva il perché, pure delle attenzioni maschili.
La sua storia all’ospedale di San Giovanni si concluse a febbraio, quando face cadere dalle scale di casa la madre che si fratturò un polso. Fu aperta un’inchiesta e il giudice istruttore, letta la perizia psichiatrica ch...