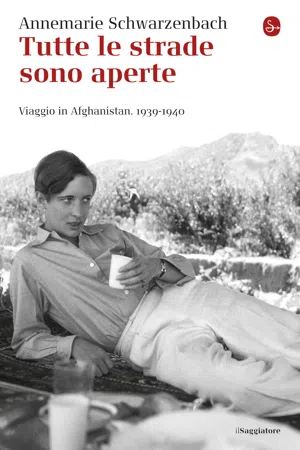![]()
Herat, 1º agosto 1939…
Datare le lettere è una consuetudine e quindi abbiamo fatto i calcoli più volte e confrontato i nostri diari: oggi è indubbiamente il 1º agosto. Ma quando arriverà in patria questa lettera? I falò saranno già dimenticati, questa data apparirà obsoleta e un po’ bizzarra in un mondo abituato alla radio? I giornalisti, coloro che ritengono di aver qualcosa da dire sui giornali, non dovrebbero essere pronti e trovare sempre il modo di far arrivare le notizie…? Ecco, forse, quello che pensa la gente. Non siamo, tra l’altro, così lontane dall’Amu Darja, dal confine con il Turkestan, e dall’altra parte c’è la ferrovia – ma cosa contano mai qui il numero dei chilometri e gli orari! A Mashhad, sentendo che volevamo raggiungere l’Afghanistan con la nostra Ford, un giovane iraniano ci ha detto: «Un cammello è più lento di un cavallo, ma è più sicuro di arrivare alla meta». Due giorni dopo eravamo bloccate nella sabbia, in mezzo alla terra di nessuno, vicino al posto di confine tra Iran e Afghanistan, dove non si vede la minima traccia del passaggio di automobili. A conti fatti, erano solo venti metri di sabbia, ma ogni metro ci costò molta fatica e quasi mezz’ora per percorrerlo. In queste circostanze avremmo avuto bisogno, se non di un cavallo, almeno di una coppia di buoi…
Non c’è da stupirsi allora che, arrivando oggi a Herat, se non avesse fatto troppo caldo, avremmo avuto ottime ragioni per accendere un falò. Dalle colline gialle a nord della città soffia costantemente un vento impietoso; chiudiamo tutte le finestre per tenere fresca la stanza centrale della nostra piccola casa, completamente priva d’ombra. Il vento dura un mese, ci dicono gli abitanti di Herat, poi inizia un gradevole autunno. Per questo è meglio riposare nel pomeriggio e attendere la sera.
Mi sono alzata verso le cinque di mattina per portare la Ford dal capomeccanico; i commercianti stavano allestendo le loro bancarelle, riempivano le ceste di uva, innalzavano piramidi di meloni gialli e verde pallido, versavano latte in pelli di pecora tese, aggiungendovi una polverina e un po’ di mast del giorno prima, per far fermentare il latte fresco. I cavalieri entravano galoppando in città, i loro turbanti bianchi sventolavano, alcuni asini ragliavano e il meccanico, vestito di una splendida kula di pelo grigio di karakul, mi aprì, insieme ai suoi aiutanti, il portone del cortile dove la carcassa di una Chevrolet in disarmo giaceva solitaria sotto il sole del mattino. La nostra automobile aveva dovuto superare molte prove: una tempesta di sabbia, il deserto di cardi e letti di fiume pieni di grossi ciotoli; inoltre, il giorno prima, mentre attraversavo un insidioso ponticello di argilla, la macchina si era ribaltata sul fianco sinistro, finendo in un fosso piuttosto profondo, proprio davanti alla casa del mudir al quale avevamo fatto visita. Il capomeccanico tasta le molle delle sospensioni, sorride e promette di fare del suo meglio. Lo guardo per un’oretta mentre lavora. Più tardi, sulla via del ritorno, fa già quasi troppo caldo. Aspettiamo quindi la sera. E quando la macchina sarà pronta, partiremo forse per il Nord e pernotteremo da qualche parte fra le montagne dove ci sono ombra, acqua buona e le tende nere dei nomadi.
Non si può dire che le sere qui a Herat siano fresche, ma hanno un colore dorato e la luna fluttua pallida sopra le antiche mura della città, di argilla gialla completamente erosa, e poi veleggia verso le montagne azzurre, le prime propaggini dell’Hindu Kush con le sue fantastiche creste. I vicoli del bazar si riempiono di turbanti bianchi e di rispettabili kula, e le strade che portano fuori città sono leggermente scosse dal rapido trotto dei bei cavalli focosi che tirano i gadi a due ruote, diretti verso il viale di abeti e i verdi giardini immersi tra le colline brulle. Lassù si ammassano i cammelli delle grandi carovane e si sentono risuonare i loro campanacci…
Un giovane polacco ci rende visita – è l’unico europeo a Herat, un ingegnere impiegato dallo stato per costruire strade, ponti e case. «Avete giornali?» ci chiede subito. «Sapete cosa sta succedendo nel mondo?» Cielo, no, ne sappiamo quanto lui, abbiamo perfino faticato a calcolare la data da indicare sulla lettera. Qual è la situazione politica? Ma è proprio per fuggire dalla politica che siamo andate così lontano! «Ben lontano» mormora il giovane polacco, «ben lontano!», e mi regala un pacchetto di vere sigarette inglesi. Dovrei forse spiegare che cosa significa un simile regalo, qui, ai confini del mondo. Ma cala la sera, il vento è meno violento, la luce meno accecante: vogliamo uscire in strada e fermare un gadi, magari trainato da un cavallo bianco o pezzato. Le lettere aspetteranno, il tempo qui non costa nulla. Torniamo ai meloni e alle pesche dell’Afghanistan.
![]()
Tre volte l’Hindu Kush
C’è un detto tra i giornalisti in viaggio: «Se rimani sei settimane in un paese, scriverai un libro con animo leggero. Se rimani sei mesi, farai fatica a finire un articolo. Se rimani sei anni, non scriverai più…». Ma se questa regola è valida, esistono anche le eccezioni. Quando arrivai per la prima volta dal Nord, dalla rovente pianura del Turkestan, raggiunsi l’Hindu Kush e superai i suoi grandiosi passi storici, mi venne la tentazione di scrivere un inno e nient’altro. Un inno al suo nome, perché i nomi sono molto più che indicazioni geografiche, i nomi sono suono e colore, sogno e ricordo, mistero, magia; e non è disincanto quello che si prova, ma piuttosto l’inizio di un processo meraviglioso, quando un giorno li ritroveremo, carichi di splendore e ombra, di fuoco e della fredda cenere della realtà. Pamir, Hindu Kush, Karakorum: oggi non era per me diverso da quando nel passato, sul banco di scuola, mi rifiutavo testardamente di credere che i nomi che imparavo e leggevo sulla carta geografica potessero diventare reali prima di averli visti con i miei occhi, sfiorati con il mio respiro, toccati, per così dire, con mano. La contemporaneità di vicinanza e lontananza mi confondeva, mi sembrava che passato, presente e futuro potessero incontrarsi in un luogo per conferirgli il pieno senso della vita. Il fatto però che la vita, nello stesso istante, esistesse qui e là, da questa parte e dall’altra dei mari e delle montagne, mi pareva qualcosa di cui dubitare seriamente. Sono questi i dubbi che volevo togliermi e che forse mi hanno spinto a cominciare a viaggiare: sono partita non per conoscere la paura, ma per verificare il contenuto di questi nomi e per sentire sul mio stesso corpo la loro magia, così come si percepisce la forza meravigliosa del sole davanti a una finestra aperta, dopo che lo si è visto a lungo specchiarsi su lontane colline e posarsi sui prati bagnati dalla rugiada.
Quella volta, dunque, ero indubbiamente destinata a incontrare l’Hindu Kush, perché mi trovavo, venendo dalla Persia, nelle province settentrionali dell’Afghanistan, diretta verso sud, verso Kabul, la capitale, e tra il Nord e il Sud di questo paese selvaggio l’Hindu Kush si erge come una possente fortezza. Leggevo il suo nome anche sulla cartina inglese e seguivo l’unica strada possibile: da Herat a Kala-i-Nao, da Kala-i-Nao a Bala Murghab, Mana e Andkhoi; fino a quando, ai bordi del deserto, appaiono le rovine di Balkh, la pista sabbiosa termina a Mazar-i-Sherif, la capitale del Turkestan afghano. Ormai non mancava molto, avrei dovuto essere sicura del fatto mio. Ma ero in viaggio da molto tempo e la gente che incontravo continuava a rispondermi: «Nastik ast, bissjar nastik…» (è vicino, vicinissimo!). A cavallo o a piedi, con il mulo al trotto o con il passo ondeggiante dei cammelli delle carovane? Qualche giorno di viaggio, qualche ora? Forse la pista si perdeva nella sabbia, come i fiumiciattoli che scorrevano inutilmente verso il grande corso dell’Amu Darja, forse a sud si stendeva il deserto, come a nord, forse il calore autunnale durava centoventi giorni, come il famoso vento del Nord di Herat, e forse questo viaggio ai margini delle enormi pianure del Turkestan non sarebbe finito mai…
Ricordo che una notte rimasi a piedi, con due ruote forate, tra le mura dei giardini, sature di calore e spettralmente silenziose, di un villaggio che sembrava perdersi tra rovine e strani scogli argillosi come nel labirinto di uno dei gironi danteschi. La località si chiamava Tash Kurghan e, qualche ora dopo, il capo della polizia, avvertito, fece scortare la mia macchina fino al portone di un palazzo fiabesco che si trovava in fondo a un giardino quasi infinito, leggermente in salita e bianco sotto la luce della luna. Dietro le alte mura del giardino vidi una catena di monti azzurri, meravigliosa, che non sembrava appartenere a questo mondo ma al cielo notturno. Là, pensai, non potevano esistere né rocce né erba, né gole né valli, né alberi o pascoli, fuochi di pastori, ghiacciai e tempeste. Era tutto materia uniforme, vellutata, avvolta da un delicato vapore, imbevuta e pervasa dal chiarore della luna, fino alla cresta dalle fantasiose frastagliature, che, a volerla toccare, si sarebbe sicuramente dissolta e fusa con le nubi lattiginose. Rimasi estasiata da una così stupenda visione, non ero curiosa, ma il capo della polizia di Tash Kurghan me lo disse comunque: là, a sud, disse, c’era la prima catena di monti dell’Hindu Kush…
Sono passati quattro mesi o forse un po’ di più. Che altro rimane da dire? L’inno! L’inno per celebrare la fine di una notte di luna e la strada serpeggiante tra mura di argilla che si sgretolano, la strada che lasciava dietro di sé giardini agonizzanti nel pallido calore, che portava in alto, in una lunga alba priva di luce, attraverso una valle dai dolci pendii spogli, fino a raggiungere Haibak, nello splendido chiarore del mattino, tra prati verdi e dolci colline, campi gialli, spighe mosse dal vento, deliziosi boschetti e un antico ponte sopra un fiume che corre scrosciando.
Là, vicino al ponte, alcuni uomini allegri, dalla barba bianca, sedevano davanti a una chaykhana, la casa da tè, con le gambe incrociate su una stuoia di paglia, con accanto le scarpe a becco d’anatra dal bordo colorato, il samovar fumante, e c’erano tè verde, pane uzbeko caldo e meloni profumati, l’aria era fresca e dalle montagne scendeva una piacevole brezza. Più tardi, ricordo, arrivò un passo e, poi, l’umida e calda pianura di Pol-i-Khomri, piena di nugoli di zanzare, anatre selvatiche, bufali indiani. Pol-i-Khomri dove, dietro la punta di una collina disseminata di rovine buddhiste, il mondo si trasforma all’improvviso. In mezzo alla natura selvaggia, satura di malaria, comparvero una diga, fornaci da mattoni, edifici di fabbriche incompiuti, case bianche coperte di lamiera ondulata, e ancora: sale da tè, bancarelle di bazar, colonie di tende, scritte in persiano, in russo e tedesco, profughi russi, ingegneri tedeschi e uzbeki, turkmeni, hazari, tagiki, afghani, nomadi condannati al lavoro in fabbrica, contadini obbligati alle corvée, il più strano miscuglio di razze e di lingue, il nuovo proletariato di uno stato che aspira alla civilizzazione. E tutto questo in mezzo all’Hindu Kush, alle porte della provincia di Badakhshan, celebre per i bei cavalli dal muso bianco fin dai tempi degli imperatori della dinastia Tang e di Gengis Khan!
Dietro Pol-i-Khomri, le colline diventavano più ripide, le rocce si avvicinavano, si aprivano gole, le ombre si allargavano. A un’altezza incredibile, si vedevano cime di montagne infuocate, una striscia di cielo azzurro e si diventava ora dopo ora prigionieri della cupa strettoia nella quale le carovane scivolavano come ombre lungo la scarpata e gli asinai dagli occhi allungati accendevano enormi fuochi sotto la roccia per una lunga notte. Si fece giorno e poi di nuovo notte, tè a Doshi, trote e vento freddo a Bulula, tende nere di nomadi, le ultime iurte turkmene, i primi uomini delle tribù afghane, dai lunghi capelli e gli occhi incandescenti, adorni di orecchini, che parlavano pashtun. E finalmente il passo Shibar, ripido, spoglio e impressionante, tanto che si dice sia la strada più alta percorribile in auto. In ogni caso porta oltre, sull’altro versante, verso i pendii meridionali dell’Hindu Kush e giù, in una valle di rara bellezza. Sì, qui la terra è più clemente e ci sono villaggi, mandrie, fieno profumato, i grandi venti restano alle nostre spalle, il respiro del deserto è bandito…
Questo avveniva quattro mesi fa, o poco prima, come ho detto. Allora credevo che fosse il mio primo e ultimo incontro con il grande Hindu Kush, ero convinta di lasciare dietro di me, a ogni passo, un pezzetto di terra, un ciuffo d’erba, un respiro pieno di vento, un’esperienza, per sempre. Perché mai continuo a elencare nomi di villaggi, passi, tribù, li ho dimenticati, cancellati, sono scivolata attraverso il mio sogno dell’Hindu Kush come attraverso il tramonto, la nebbia di prima mattina, e le prime ore del meriggio ebbro di sole forte e cocente. Tutto questo è alle mie spalle, avevo già preso congedo quando imboccai la pianura di Kabul, le settimane passarono senza che le contassi, arrivò l’autunno.
Poi, un giorno, mi ritrovai di nuovo in viaggio per il Turkestan. Ero partita nell’ultima ora della notte e, all’alba, vidi comparire i monti lontani, azzurri, freddi, coronati di neve e splendidi. «Per la seconda volta l’Hindu Kush» mi dissi, ma ora tutti questi nomi contavano e rimanevano impressi nella memoria. Scoprii altre valli, altre vette, e mi sentii invadere di gioia esaltante quando, verso mezzogiorno, ritrovai un giardino ricco di alberi dove già una volta mi ero fermata a riposare, e nella piazzetta circondata da piccole case da tè di Chorband rividi un giovane commerciante che allora mi aveva venduto uva e meloni e ora stava contando sulle dita centoventi noci per un afghano. Ma sebbene la mia memoria venisse risvegliata e dolcemente animata da questi panorami, così belli, già sognati, e da melodie già ascoltate, il grande paesaggio dell’Hindu Kush mi sembrò diverso, perché stavo andando verso nord, incontro alle tempeste, ai bassopiani del Turkestan, avvolti da nubi di sabbia striscianti, dove già regnava il grande freddo: stavo andando verso i confini della Russia. Il viaggio era duro, il mio cuore, questa volta, non gioiva mentre mi avvicinavo a destinazione. E i giardini di Tash Kurghan, ora lo sapevo, erano l’ultima oasi protetta, strappata a un deserto spietato, ai piedi delle montagne…
È un deserto terribile, una terra che sta morendo. Per quanto andassi verso nord, verso l’invisibile fiume Oxus e la frontiera proibita della Russia, le tracce della morte, gli scheletri, i cocci di argilla e le colline di rovine erose dal vento di città, fortezze, cimiteri sepolti, non finivano mai. Penuria di acqua, attacchi di orde di nomadi… Verso sera, nell’oscurità sempre imbevuta del lucore lattiginoso di astri lontani, guardavo talvolta verso sud, cercando conforto, e incontravo la catena ormai familiare di montagne azzurre. La sua esistenza era comprovata, il suo magico nome rimaneva vivo come un potente battito del cuore. E lassù, nelle più alte gole ancora visibili, ogni notte bruciavano grandi fuochi. Chi vi si riscaldava?
Si potrebbe pensare che il ritorno attraverso l’Hindu Kush per la stessa strada diventi un’impresa banale, perfino noiosa. Tash Kurghan e Haibak, Doab e Doshi… ma le notti erano più lunghe e più fredde, alle quattro le stelle erano immobili, come congelate nella loro aureola azzurra, alle sei iniziava un’alba grigia che sembrava mescolarsi, nelle gole strette di Doab, con un giorno caliginoso, come se il sole non dovesse mai più risplendere; in compenso, lo splendore abbacinante delle distese di neve sul passo Shibar era quasi fatale per l’occhio e il cuore dei mortali. E di là, sul pendio meridionale, centinaia di uomini erano inginocchiati, il turbante in testa e la camicia svolazzante, sulla riva ghiaiosa del fiume, perché era la fine del Ramadan ed era un giorno di grande festa.
Nello splendido e mutevole quadro dell’Hindu Kush mi manca il verde tenero, il vento delicato, il canto commovente della primavera. Ma non siamo noi a decidere dei nostri sogni e io non osavo guardare indietro, verso le cime innevate che stavano scomparendo mentre avanzavo nella pianura: non sta a me decidere di incontri e separazioni e tracciare il confine tra realtà e visione.
A me rimane la magia, il nome, il cuore meravigliosamente toccato.
![]()
Nel giardino delle belle ragazze di Kaisar
Fino a quel momento, Ella e io avevamo potuto fare solo discorsi teorici sulle donne afghane. Nel corso di molte settimane trascorse in questo paese, rigidamente maomettano, avevamo fatto amicizia con contadini e funzionari, cittadini, soldati, commercianti dei bazar e governatori di provincia. Ovunque eravamo state accolte con ospitalità e avevamo cominciato ad affezionarci a questo popolo di uomini coraggiosi, allegri e integri. Nella magnifica antica città di Herat, avevamo assistito alle gare di scherma e alla preghiera comune dei giovani che, la sera, si riunivano su un prato davanti alla porta della città. In viaggio, durante i lunghi percorsi senz’ombra, quando facevamo una sosta, si univano a noi semplici contadini che dividevano con noi i loro meloni. Non avevamo mai dovuto piantare la tenda e cucinarci la zuppa da sole. Nei paesi venivamo salutate dai sindaci e accolte con tè e uva. La sera ci accompagnavano in bei giardini, dove attenti servitori portavano il pilaf, la pietanza locale a base di riso, e mentre mangiavamo arrivava l’ospite con il suo seguito per farci visita, fermandosi spesso a parlare a lungo con noi.
Ma sembrava di vivere in un paese senza donne! Conoscevamo il chador, l’abito che nasconde tutto il corpo delle maomettane e che ha poco in comune con l’immagine romantica del delicato velo delle principesse orientali. Avvolge stretto il capo e davanti al viso ha una specie di piccola grata, per ricadere poi in ampie pieghe fino a terra, lasciando a malapena visibili le punte ricamate e i tacchi consumati delle calzature. Avevamo visto alcune di queste figure imbacuccate, informi, passare veloci per i vicoli dei bazar e sapevamo che erano le donne degli afghani che camminavano fieri e liberi, che amavano la compagnia, stavano allegramente a conversare e trascorrevano metà della giornata a oziare nella casa da tè e nel bazar. Ma queste apparizioni spettrali avevano poco di umano. Erano ragazze, madri, vecchie, che età avevano, erano allegre o tristi, belle o brutte? Come vivevano, che cosa facevano, a chi andava la loro attenzione, il loro amore o il loro odio? In Turchia, così come in Iran, avevamo visto scolare, giovani esploratrici, studentesse, anche donne autonome, che lavoravano, oppure altre, impegnate nel sociale, che contribuivano alla costruzione di una fisionomia nazionale e la cui esistenza non poteva più essere ignorata nella vita del paese. Sapevamo che il giovane re Amanullah, di ritorno da un viaggio in Europa, aveva introdotto in Afghanistan una serie di riforme realizzate in modo precipitoso, tentando di seguire, in particolare, l’esempio della Turchia. Aveva proceduto troppo in fretta. Gli veniva soprattutto rimproverata l’emancipazione delle donne. Per qualche settimana nella capitale, Kabul, era stato abolito il chador, poi era scoppiata la rivoluzione, le donne erano ritornate nell’harem, relegate in casa, e potevano ora mostrarsi nuovamente in strada solo coperte dal velo.
Questi primi accenni di libertà erano già stati dimenticati, queste poche settimane dell’anno 1929 erano state cancellate dalla memoria delle donne?
Un giorno fummo ospiti di un giovane governatore, aperto e intelligente, in una località del Nord. Ella osò fare la domanda. Il nostro ospite aveva dimostrato grande comprensione per le necessità dello stato afghano e aveva detto che la costruzione di strade avrebbe aperto il paese al commercio, che sarebbero poi nate industrie, ma anche scuole e ospedali. Si potevano escludere le donne da un simile programma di progresso? Non avevano il diritto di partecipare a questa nuova vita e di essere liberate da quella restrizione della loro esistenza che le rende insensibili a tutto? Il governatore ci rispose in maniera evasiva. Quando chiedemmo cortesemente se potevamo fare visita a sua moglie, in un primo momento ce lo concesse, ma poi inventò una scusa.
Solo a Kaisar, un piccolo villaggio in un’oasi nella provincia del Turkestan, a nord del paese, con nostra grande sorpresa fummo condotte dall’hakim Saib, il sindaco stesso, senza tante cerimonie, attraverso una porticina, all’interno di un giardino della sua casa, nel giardino delle sue mogli e figlie. Due ragazzine in abiti estivi, i capelli scuri avvolti da un leggero velo morbido, ci vennero incontro sorridenti. Erano entrambe molto belle, e lo era anche la madre, dal portamento nobile e lo sguardo serio e gentile, che ci accolse sotto i grandi alberi dove erano stesi alcuni tappeti. Vi giocavano anche i bambini, i fratellini e le sorelline più piccoli, e il bimbetto biondo di Sara, la nuora. Il suo secondo figlio dormiva in un’amaca all’ombra. Un po’ discosto, sotto la tettoia di una semplice casa di argilla, c’era il samovar. Portarono prima una bacinella d’acqua e alcuni asciugamani, poi tè e frutta. Un’ora dopo ci venne servito il pilaf. La madre mangiò con noi al tavolo, alla maniera europea. Le figlie ci servirono e poi si sedettero a mangiare con i bambini sul tappeto, tutti prendendo il cibo con le dita dalla stessa enorme scodella di riso. Gli abbondanti resti del pasto furono mangiati dalle serve, alla fine. Mentre la famiglia dell’hakim aveva i tratti belli e severi degli afghani, le serve erano evidentemente di razza mongolica, forse turkmene o uzbeke.
Dopo pranzo, portarono materassi di seta e zanzariere, ma non c’era tempo per riposarsi. Sebbene le ragazze non parlassero nemmeno una parola di francese, e noi conoscessimo solo qualche parola di persiano, cominciammo una conversazione animata. Ci portarono un tessuto di seta azzurro e un paio di forbici, chiedendoci di tagliare loro un vestito. Non osammo farlo e promettemmo di mandare loro, da Kabul, dell...