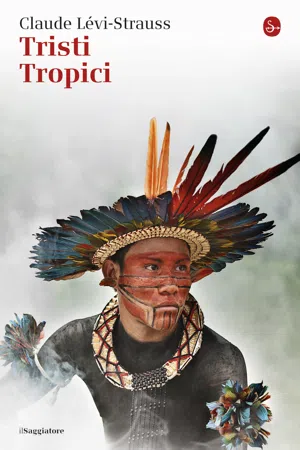![]()
SETTIMA PARTE
Nambikwara
![]()
24. II mondo perduto
Una spedizione etnografica nel Brasile centrale va preparata al quadrivio RéamurSébastopol. Lì si trovano riuniti i grossisti in articoli di confezione e di moda; lì c’è speranza di stanare gli articoli normalmente graditi al gusto difficile degli indiani.
Un anno dopo la visita ai bororo, tutte le condizioni richieste per fare di me un etnologo erano state raggiunte: benedizione di Lévy-Bruhl, Mauss e Rivet, retrospettivamente accordata; esposizione delle mie collezioni in una galleria del Fauburg Saint-Honoré; conferenze e articoli. Grazie a Henri Laugier che presiedeva alla giovane vita del servizio di ricerca scientifica, ottenni fondi sufficienti per una più vasta impresa. Dovevo anzitutto equipaggiarmi; tre mesi di intimità con gli indigeni mi avevano reso edotto delle loro esigenze, sorprendentemente simili da un capo all’altro del continente sudamericano.
In un quartiere di Parigi che mi era ancora altrettanto sconosciuto quanto l’Amazzonia, mi abbandonai dunque a strani esercizi sotto gli occhi di importatori cecoslovacchi. Ignorando tutto del loro commercio, mancavo di termini tecnici per precisare i miei bisogni. Potevo soltanto applicare i criteri indigeni. Mi misi con impegno a selezionare le più piccole fra le perle da ricamo dette «pietrine», che in pesanti matasse riempivano gli scaffali. Provai a schiacciarle per controllare la loro resistenza; le succhiai per verificare se erano colorate nella massa e non rischiassero di stingere al primo bagno nel fiume; variavo l’importanza dei miei acquisti dosando i colori secondo i canoni indiani: prima il bianco e il nero; poi il rosso; di gran lunga inferiore il giallo; e, per scrupolo di coscienza, un po’ di blu e di verde, che probabilmente sarebbero stati disdegnati.
Le ragioni di tutte queste predilezioni sono facili a capirsi. Fabbricando a mano le loro perle, gli indiani danno loro un valore tanto più elevato quanto più sono piccole, cioè richiedono lavoro e abilità; come materia prima, utilizzano la scorza nera delle noci di cocco, e la madreperla lattiginosa delle conchiglie di fiume, ricercando l’effetto nel contrasto delle due tinte. Come tutti gli uomini apprezzano specialmente ciò che conoscono; avrei dunque avuto successo col bianco e nero. Il giallo e il rosso formano spesso per loro una sola categoria linguistica, dipendente dalle variazioni della tintura d’urucu che, secondo la qualità dei grani e la loro maturazione, oscilla fra il vermiglio e il giallo arancio; il rosso conserva tuttavia il primato, per il suo cromatismo intenso, che certe bacche e certe piume hanno reso familiare. Quanto al blu e al verde, questi colori freddi si trovano soprattutto illustrati allo stato naturale dei vegetali; doppia ragione che spiega l’indifferenza indigena e l’imprecisione del loro vocabolario corrispondente a queste sfumature: a seconda delle lingue, il blu è assimilato al nero o al verde.
Gli aghi dovevano essere abbastanza grossi per poter usare un filo robusto, ma non troppo, data la piccolezza delle perle che avrebbero dovuto infilare. Quanto al filo, lo volevo a colori vivi, rosso di preferenza (gli indiani colorano il loro con l’urucu) e fortemente ritorto per conservare un aspetto artigianale. Di norma, avevo imparato a diffidare dalla paccottiglia: l’esempio dei bororo mi aveva comunicato un profondo rispetto per le tecniche indigene. La vita selvaggia sottomette gli oggetti a dure prove; per non screditarmi di fronte ai primitivi – per quanto paradossale possa sembrare – mi occorrevano gli acciai meglio temprati, la vetreria colorata nella massa, e del filo che neanche il sellaio della corte d’Inghilterra avrebbe disapprovato.
A volte mi capitavano commercianti che si entusiasmavano a questo esotismo conveniente alla loro merce. Dalle parti del canale Saint-Martin, un fabbricante di ami mi cedette a basso prezzo tutti i suoi fondi di magazzino. Per un anno ho trascinato attraverso le brughiere diversi chili di ami che nessuno voleva, perché erano troppo piccoli per i pesci che il pescatore amazzonico riteneva degni di sé. Li ho finalmente smaltiti alla frontiera boliviana. Tutte queste mercanzie dovevano servire a una doppia funzione: come regali e materiali di scambio per gli indiani, e come mezzi per procurarsi viveri e servizi nelle regioni arretrate dove raramente penetrano i commercianti. Alla fine della spedizione, avendo esaurito le mie risorse pecuniarie, mi guadagnai qualche settimana di soggiorno in più aprendo una bottega in una capanna di cercatori di caucciù. Le prostitute del luogo acquistavano una collana contro due uova, e non senza contrattare.
Mi proponevo di passare una intera annata nella brughiera e avevo lungamente esitato sull’obiettivo. Senza poter sospettare che il risultato avrebbe contrastato i miei progetti, interessato com’ero più a comprendere l’America che ad approfondire la natura umana fondandomi su un caso particolare, avevo deciso di fare un taglio attraverso l’etnografia – e la geografia – brasiliana, limitandomi a percorrere la parte occidentale dell’altopiano, da Cuiaba al Rio Madeira. Fino a poco tempo addietro questa regione era rimasta la meno conosciuta del Brasile. Gli esploratori paulisti del XVIII secolo, non avevano neanche sorpassato Cuiaba, respinti dalla desolazione del paesaggio e dalla ferocia degli indiani. Al principio del XX, i millecinquecento chilometri che separano Cuiaba dall’Amazzonia erano ancora terra proibita, a tal punto che, per andare da Cuiaba a Manaus o a Belem, sul Rio delle Amazzoni, era più semplice passare per Rio de Janeiro e continuare verso il Nord per mare, risalendo poi il fiume dal suo estuario. Solo nel 1907, il generale (allora colonnello) Candido Mariano de Silva Rondon cominciò la penetrazione; questa doveva durare otto anni, spesi nell’esplorazione e nella posa di un filo telegrafico d’interesse strategico che collegava per la prima volta, passando per Cuiaba, la capitale federale alle stazioni di frontiera del Nordovest.
I rapporti della commissione Rondon (che non sono ancora stati pubblicati integralmente), qualche conferenza del generale, i ricordi di viaggio di Theodore Roosevelt che l’accompagnò nel corso di una delle due spedizioni, e infine un gradevole libro del compianto Roquette Pinto (allora direttore del Museo nazionale) intitolato Rondonia (1912), davano indicazioni sommarie sulle popolazioni molto primitive di questa zona. Ma dopo di allora, la vecchia maledizione sembrava essere ricaduta sull’altopiano. Nessun etnografo professionista vi si era più spinto. Seguendo la linea telegrafica, o ciò che ne restava, era allettante cercar di sapere chi erano esattamente i nambikwara e, più a nord, quelle popolazioni enigmatiche che nessuno aveva visto dopo che Rondon si era limitato a segnalarle.
Nel 1939, l’interesse fin allora ristretto alle tribù della costa e delle grandi città sui fiumi, vie tradizionali di penetrazione all’interno del Brasile, cominciava a spostarsi verso gli indiani dell’altopiano. Presso i bororo, mi ero convinto dell’eccezionale grado di raffinatezza, sul piano sociologico e religioso, di tribù erroneamente considerate di cultura molto grossolana. Si veniva a conoscenza a quel tempo dei primi risultati delle ricerche di un tedesco oggi scomparso: Kurt Unkel, che aveva adottato il nome indigeno di Nimeuendaju e che, dopo anni passati nei villaggi gé del Brasile centrale, confermava che i bororo non rappresentavano un fenomeno a parte, ma piuttosto una variazione su un tema fondamentale comune con altre popolazioni. Nelle savane del Brasile centrale si trovavano dunque, addentrandosi per circa duemila chilometri, i superstiti di una cultura notevolmente omogenea, caratterizzata da un’unica lingua che si diversificava in dialetti della stessa famiglia, e presso i quali un livello di vita materiale relativamente basso faceva contrasto con una organizzazione sociale e un pensiero religioso molto evoluti. Non bisognava forse riconoscere in essi i primi abitanti del Brasile dimenticati poi in fondo alle loro brughiere, o ricacciati, poco tempo dopo la scoperta, in terre più povere, da popolazioni bellicose partite, non si sa da dove, alla conquista della costa e delle vallate fluviali?
Sulla costa, gli esploratori del secolo XVI avevano incontrato un po’ dappertutto dei rappresentanti della grande cultura tupi-guarany, che occupavano anche la quasi totalità del Paraguay e il corso del Rio delle Amazzoni, tracciando un anello di tremila chilometri di diametro, interrotto per breve tratto alla frontiera paraguayo-boliviana. Questi tupi, che offrono oscure affinità con gli aztechi, cioè coi popoli arrivati in seguito nella vallata del Messico, erano anch’essi dei nuovi venuti; nelle vallate dell’interno del Brasile, la loro installazione è continuata fino al secolo XIX. Avevano cominciato a muoversi forse qualche centinaio d’anni prima della scoperta, spinti dalla convinzione che esistesse in qualche luogo una terra senza morte e senza male. Così pensavano ancora quando al termine delle loro migrazioni piccoli gruppi sboccarono, alla fine del secolo XIX, sul litorale paulista, avanzando sotto la guida dei loro stregoni, danzando e cantando le lodi del paese dove non si muore, e digiunando a lungo per meritarselo. Nel secolo XVI, in ogni caso, si disputavano aspramente la costa con degli occupanti anteriori, dei quali abbiamo poche notizie, ma che sono forse i nostri gé.
A nordovest del Brasile, i tupi coesistevano con altri popoli: i caraibi o caribi, simili per la cultura ma non per la lingua e che si adoperavano per conquistare le Antille. C’erano anche gli arawak, gruppo piuttosto misterioso: più antico e più raffinato degli altri due, formava il grosso della popolazione delle Antille e si era spinto fino in Florida. Pur distinguendosi dai gé per una altissima cultura materiale, soprattutto nel campo della ceramica e del legno scolpito, vi si avvicinava per l’organizzazione sociale che sembrava dello stesso tipo. Si poteva pensare che caribi e arawak avessero preceduto i tupi nella penetrazione del continente: nel secolo XVI si trovavano infatti riuniti nelle Guyane, all’estuario del Rio delle Amazzoni e nelle Antille. Ma piccole colonie sussistono ancora nell’interno, su alcuni affluenti della riva destra del Rio delle Amazzoni: Xingu e Guaporé. Gli arawak hanno dei discendenti anche nell’alta Bolivia. Furono loro probabilmente a portare l’arte della ceramica presso gli mbaya-caduvei, poiché i guana, ridotti come si ricorderà in schiavitù da questi ultimi, parlano un dialetto arawak.
Attraversando la parte meno conosciuta dell’altopiano, speravo di trovare nella savana i rappresentanti più occidentali del gruppo gé; e raggiunto il bacino del Madeira, speravo di poter studiare le vestigia inedite delle tre famiglie linguistiche sul limitare della grande via di penetrazione: il Rio delle Amazzoni.
La mia speranza non si è realizzata che in parte, a causa del semplicismo col quale noi consideriamo la storia precolombiana dell’America. Oggi, dopo le recenti scoperte, e grazie, per quanto mi concerne, agli anni consacrati allo studio dell’etnologia nordamericana, mi rendo conto che l’emisfero occidentale dev’essere considerato come un tutto omogeneo. L’organizzazione sociale, le credenze religiose dei gé ripetono quelle delle tribù delle foreste e delle praterie dell’America del Nord; già da tempo, del resto, si sono notate – senza trarne conseguenze – analogie fra le tribù del Chacho (come i guaiacuru) e quelle delle pianure degli Stati Uniti e del Canada. Per mezzo del cabotaggio lungo le coste del Pacifico, le civiltà del Messico e del Perù hanno certamente influenzato diversi momenti della storia di quelle regioni. Di tutto ciò non si è tenuto abbastanza conto a causa della convinzione, che per molto tempo ha dominato gli studi americani, che la penetrazione del continente abbastanza recente, datando appena da cinque o seimila anni prima della nostra era, è interamente attribuita a popolazioni asiatiche arrivate dallo stretto di Bering.
Si poteva dunque disporre soltanto di qualche migliaio di anni per spiegare come questi nomadi si fossero spostati da un capo all’altro dell’emisfero occidentale, adattandosi a climi diversi; come avessero scoperto e poi addomesticato e diffuso su enormi territori le specie selvatiche che nelle loro mani sono diventate tabacco, fagiolo, manioca, patata dolce, patata comune, arachide, cotone e soprattutto granturco; come infine fossero nate e si fossero sviluppate le civiltà successive, nel Messico, in America centrale e nelle Ande, di cui gli aztechi, i maya e gli incas sono i lontani eredi. Per riuscirci, bisognava comprimere ciascuna di queste evoluzioni in pochi secoli: la storia precolombiana dell’America diventava una successione di immagini caleidoscopiche in cui il capriccio dei teorici faceva a ogni istante apparire immagini nuove. Tutto avveniva come se gli specialisti d’oltre Atlantico cercassero di imporre all’America indigena quella assenza di profondità che caratterizza la storia contemporanea del Nuovo mondo.
Queste prospettive sono state sconvolte da scoperte che arretrano in modo considerevole la data in cui l’uomo è penetrato nel continente. Noi sappiamo che qui ha conosciuto e cacciato una fauna oggi scomparsa: tardigradi, mammut, cammelli, cavalli, bisonti arcaici, antilopi, il cui ossame è stato trovato insieme alle sue armi e ai suoi utensili di pietra. La presenza di alcuni di questi animali in luoghi come la vallata del Messico implica condizioni climatiche molto diverse da quelle attuali e che hanno richiesto diversi millenni per modificarsi. L’impiego della radioattività per determinare la data dei resti archeologici ha dato indicazioni nello stesso senso. Bisogna dunque ammettere che l’uomo era già presente in America ventimila anni fa; e in certe zone, da più di tremila anni coltiva il granturco. Nell’America del Nord, un po’ dappertutto, si trovano vestigia che risalgono a quindici o ventimila anni or sono. Nello stesso tempo, le date dei principali giacimenti archeologici del continente, ottenute misurando la radioattività residua del carbone, si stabiliscono da cinquecento a millecinquecento anni prima di quanto non si supponesse. Come quei fiori giapponesi di carta compressa che si aprono quando li si immerge nell’acqua, la storia precolombiana dell’America acquista tutto a un tratto il volume che le mancava.
Soltanto che, con questo fatto, ci troviamo di fronte a una difficoltà inversa da quella incontrata dai nostri predecessori: come riempire quegli immensi periodi? Noi ci rendiamo conto che i movimenti migratori che ho tentato di tracciare or ora sono del tutto superficiali e che le grandi civiltà del Messico o delle Ande sono state precedute da qualcosa d’altro. Già nel Perù e in diverse regioni dell’America del Nord, sono venuti alla luce resti dei primi occupanti: tribù senza agricoltura seguite da società contadine e giardiniere, ma che non conoscevano ancora né il granturco né le stoviglie; i raggruppamenti che si formarono poi praticavano la scultura su pietra e la lavorazione dei metalli preziosi, in uno stile più libero e più ispirato di tutto ciò che verrà dopo. Gli incas del Perù, gli aztechi del Messico, che credevamo espressione e riassunto di tutta la storia americana, sono tanto lontani da quelle vive sorgenti quanto il nostro stile impero lo è dall’Egitto e da Roma a cui si è tanto ispirato: arti totalitarie in tutti e tre i casi, avide di grandiosità ottenuta con la durezza e nell’indigenza, espressione di uno Stato intento ad affermare la sua potenza concentrando le sue risorse su tutt’altro (guerra o amministrazione) ma non nello sviluppo della propria raffinatezza. Anche i monumenti dei maya esprimono la fiorita decadenza di un’arte che aveva raggiunto il suo apogeo mille anni prima.
Da dove venivano i fondatori? Dopo le certezze di un tempo, siamo costretti a confessare che non ne sappiamo niente. I movimenti delle popolazioni nella regione dello stretto di Bering sono stati molto complessi: gli eschimesi vi partecipano solo in data recente; per circa mille anni furono preceduti da paleoeschimesi la cui cultura ricorda la Cina arcaica e gli sciti; e durante un lunghissimo periodo, forse dall’VIII millennio fino alla vigilia dell’era cristiana, vi si succedettero popolazioni diverse. Da sculture che risalgono al millennio precedente la nostra era, sappiamo che il tipo fisico degli antichi abitanti del Messico era molto lontano da quello degli indiani attuali: orientali grandi dai visi glabri debolmente modellati e personaggi barbuti dai tratti aquilini, simili a profili del nostro Rinascimento. Lavorando su materiali di altro genere, i biologi affermano che almeno quaranta specie vegetali, selvagge o rese domestiche dagli americani precolombiani, hanno la stessa composizione cromosomica delle specie corrispondenti dell’Asia, o una composizione derivata da quelle. Dobbiamo concludere che il granturco che figura su questa lista sia originario dell’Asia del Sudest? Ma come sarebbe possibile, se gli americani quattromila anni prima già lo coltivavano, in un’epoca in cui l’arte della navigazione era certamente rudimentale?
Senza seguire Heyredahl nelle sue audaci ipotesi d’un popolamento della Polinesia da parte di indigeni americani, si deve ammettere, dopo il viaggio del KonTiki, che contatti transpacifici hanno potuto verificarsi, e spesso. Ma all’epoca in cui le grandi civiltà fiorivano in America, verso il principio del millennio precedente la nostra era, le isole del Pacifico erano vuote; nulla, almeno, vi è stato trovato che permetta di risalire così indietro. Al di là della Polinesia, dovremmo dunque guardare alla Melanesia, già popolata forse, e alla costa asiatica nella sua totalità. Oggi siamo certi che le comunicazioni fra l’Alaska e le Aleutine da una parte, e la Siberia dall’altra, non sono mai state interrotte. Pur essendovi sconosciuta la metallurgia, si adoperavano in Alaska utensili di ferro già al principio dell’era cristiana; troviamo la medesima arte ceramica dalla regione dei Grandi Laghi fino alla Siberia centrale, come anche le stesse leggende, gli stessi riti e gli stessi miti. Mentre l’Occidente viveva ripiegato su se stesso, sembra che tutte le popolazioni settentrionali, dalla Scandinavia fino al Labrador, passando per la Siberia e il Canada, mantenessero fra loro i più stretti contatti. Se i celti hanno attinto alcuni dei loro miti da questa civiltà subartica, di cui non conosciamo quasi nulla, si capisce come mai il ciclo del Graal dimostri, con i miti degli indiani delle foreste dell’America del Nord, una parentela più stretta che con qualunque altro sistema mitologico. E non è probabilmente neppure un caso che i lapponi costruiscano ancora tende coniche identiche a quelle di questi ultimi.
Al Sud del continente asiatico, le civiltà americane mettono in luce altri punti di contatto. I popoli delle frontiere meridionali della Cina, e che questa qualificava come barbari, e più ancora le tribù primitive dell’Indonesia presentano straordinarie affinità con gli americani. Sono stati raccolti nell’interno del Borneo miti che non si differenziano dai più diffusi dell’America del Nord. Ora, gli specialisti hanno già da tempo richiamato l’attenzione sulle somiglianze fra i documenti archeologici provenienti dall’Asia del Sudest e quelli che appartengono alla protostoria della Scandinavia. Vi sono dunque tre regioni: Indonesia, Nordest americano e paesi scandinavi che formano, per così dire, i punti trigonometrici della storia precolombiana del Nuovo mondo.
Non si potrebbe supporre che questo avvenimento fra i maggiori della vita dell’umanità, voglio dire l’apparizione della civiltà neolitica – con la diffusione della ceramica e della tessitura, l’inizio dell’agricoltura e della pastorizia, i primi tentativi verso la metallurgia – dapprincipio circoscritta nel Vecchio mondo, fra il Danubio e l’Indo, abbia messo in moto stimolandoli i popoli meno evoluti dell’Asia e dell’America? È difficile capire le origini delle civiltà americane senza ammettere l’ipotesi di una attività intensa, su tutte le coste del Pacifico – asiatico o americano – che si propagava di zona in zona, grazie alla navigazione costiera; e tutto ciò per diversi millenni. Noi rifiutavamo un tempo la dimensione storica all’America precolombiana, perché l’America postcolombiana ne era stata privata. Ci rimane forse da correggere un secondo errore, che consiste nel pensare che l’America sia rimasta per ventimila anni tagliata fuori dal mondo intero, come lo era stata dall’Europa occidentale. Tutto fa pensare piuttosto che al grande silenzio atlantico rispondesse, su tutto il contorno del Pacifico, un ronzio di alveare.
Comunque sia, all’inizio del millennio che precede la nostra era, un ibrido americano sembra aver già generato tre germogli solidamente innestati sulle varietà problematiche, risultato di un’evoluzione più antica: nel genere primitivo, la cultura di Hopewell che si è diffusa, in tutta la zona degli Stati Uniti a est delle pianure, o l’ha contaminata, fa riscontro alla cultura di Chavín nel Nord del Perù (alla quale Paracas fa eco nel Sud); mentre Chavín si avvicina per suo conto alle prime manifestazioni della civiltà detta olmeca e prelude allo sviluppo dei maya. In tutti e tre i casi, siamo in presenza di un’arte corsiva, la cui morbidezza e libertà, il cui gusto intellettuale per il doppio senso (a Hopewell come a Chavín, certi motivi si leggono in modo diverso secondo che si guardino al diritto o al rovescio) cominciano appena a trasformarsi nella rigidità angolosa e nell’immobilismo che siamo abituati ad attribuire all’arte precolombiana. Cerco a volte di persuadermi che i disegni caduveo perpetuino a modo loro questa lontana tradizione. È forse proprio in quest’epoca che le civiltà americane hanno cominciato a divergere, il Messico e il Perù assumendosi l’iniziativa e camminando a passi da gigante, mentre il resto si manteneva in una posizione intermedia o magari si trascinava per via, cadendo ...