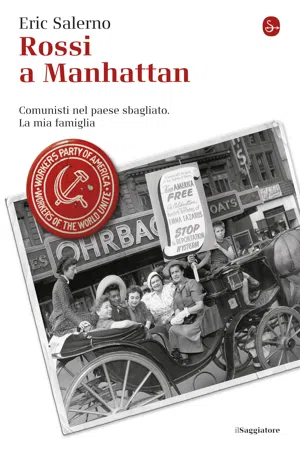![]()
Paese Sera, Italia
Raggiungemmo Michele nell’estate del 1951, quasi un anno dopo la sua deportazione dagli States. Non era stato facile vivere senza di lui. Betty era stata costretta a riprendere a lavorare, ancora una volta in una fabbrica di abiti confezionati. Usciva presto la mattina per prendere la metropolitana e rientrava nel pomeriggio tardi, stanca e infelice. Non avevamo molti amici nel quartiere e di rado anche nei weekend loro o noi avevamo la possibilità di incontrarci. Lei si sentiva sola: una metà importante della sua esistenza si era allontanata, con tutta l’eccitazione, il tormento, la sofferenza e l’incertezza che una deportazione improvvisa, verso un paese a lei sconosciuto, e la realtà complessa della ricostruzione postbellica potevano comportare. Aveva sulle spalle il peso di un figlio da crescere senza sapere quando e come la piccola famiglia si sarebbe riunita. L’alternativa, pensare di trasferirsi in Italia, le faceva male, ancora una volta si sarebbe sentita straniera, ignara della lingua e delle abitudini, senza amici né punti di riferimento oltre a quelli intimi di marito e figlio. Il futuro era tutto da definire e spaventava.
Io ero decisamente più fortunato. A undici anni si riflette poco su ciò che ti succede intorno. Continuavo a frequentare la solita scuola elementare nel Bronx, di fronte al grande parco, e cercavo di non pensare troppo al fatto che papà era stato spedito lontano e che ancora non si sapeva quando, con precisione, l’avremmo raggiunto nel paese distante, per me tutto da scoprire. Sottovalutavo le difficoltà. Vedevo in quella situazione soltanto l’avventura. Le lettere che ricevevamo da Roma erano interessanti, colme di fiorite e acritiche descrizioni della città che un giorno anch’io avrei visto e di tristezza per la nostra forzata separazione. Nelle buste Michele infilava manciate di francobolli italiani per la mia collezione. Quei pezzettini di carta colorata finirono per aiutarmi a capire molto dell’Italia. C’erano i paesaggi che un giorno avrei imparato senza difficoltà ad amare, nomi di personalità, alcune a me già note e altre da studiare, avvenimenti della storia remota, dal classico al rinascimentale, e di quella recente, dagli anni del regno al fascismo, alla liberazione e alla creazione della Prima repubblica. Un mondo nuovo. Quando sarei finalmente arrivato a Roma, senza conoscere una parola d’italiano, sarei stato in grado di indicare a mia madre località e cose a me ormai familiari.
Michele abitava in una stanza buia e un po’ ammuffita in una pensione nella centrale via Quintino Sella, a pochi passi dal Ministero delle Finanze. A volte scendeva a piedi, lungo via XX settembre, passava davanti al Palazzo del Quirinale con i suoi corazzieri sempre lustrati a nuovo, fino a via IV Novembre e l’Uesisa, il palazzo della stampa comunista dove, oltre all’Unità, avevano redazione, amministrazione e anche tipografia Il Paese e Paese Sera. Dopo essere stato parcheggiato per qualche settimana all’Ufficio esteri della Cgil, Michele era stato assunto agli «esteri» di Paese Sera, una scelta scontata. Non solo per la sua perfetta conoscenza dell’inglese ma anche per la lunga esperienza negli Stati Uniti, paese che più di ogni altro in quel dopoguerra pieno di incertezze e di complesse e spesso incomprensibili polemiche, avrebbe influito sulla politica e sul costume degli italiani. Il giornale andava bene, faceva un’opposizione dura, intelligente per quegli anni e, soprattutto, era considerato da tutti, anche dai concorrenti, un ottimo prodotto giornalistico e una buona scuola per chi si avviava al mestiere. Il giornalista Salerno vi si trovò a proprio agio. Dopo ventotto anni di esilio negli Stati Uniti, si sentiva finalmente a casa, in famiglia, circondato da persone che condividevano i suoi pensieri politici e la sua ideologia. Le bandiere rosse, la falce e il martello non erano più simboli in mano a una pericolosa minoranza di sovversivi, come gli americani li percepivano, ma elementi della vita quotidiana. Sventolavano nei giorni di festa accanto alla bandiera tricolore, le manifestazione sindacali si inondavano di rosso e c’erano i numerosi raduni più strettamente politici. In Italia Michele, quelle bandiere, ce le indicava con orgoglio, un sentimento che non fece molta breccia nel cuore ancora triste di Betty. Non riusciva a sentirsi a casa.
Invasione italiana, 22 agosto 1949. A Roma il quotidiano filocomunista Il Paese gridava contro un prodotto insidioso che avrebbe potuto far diventare bianchi i capelli di un bambino nell’arco di una notte. L’invasore: Coca Cola. Cinque stabilimenti di imbottigliamento funzionavano a pieno ritmo, alcune centinaia di migliaia di bottiglie venivano vendute quotidianamente e i comunisti giustamente temevano che fosse una nuova vittoria per la free enterprise americana. Un rosso si lamentò: «Sono andato ieri dal mio vinaio preferito e vi ho trovato tre persone. Tutti bevevano Coca Cola. Che umiliazione!». [Time, numero speciale dedicato ai cinquant’anni memorabili dell’Europa, inverno 1996.]
Gli anni del nostro approdo in Italia erano quelli della Guerra fredda, vera, gelida, senza compromessi: la contrapposizione spietata tra Est e Ovest, tra Urss e Usa, tra comunismo e capitalismo. Il governo italiano rispondeva ai richiami e ai dettami di quella stessa politica americana che aveva voluto la deportazione di Michele. L’opinione pubblica era divisa, da una parte respingeva l’ideologia anticomunista, dall’altra si lasciava circuire, come stregata dalle immagini del consumismo d’oltreoceano alle quali tentava – e tenta ancora – di opporre le grandi tradizioni mediterranee.
Ci stringemmo nella stanza di papà, nella pensione di via Quintino Sella, per un mese intero. Tutto sapeva di vecchio: l’edificio, le scale, la sala da pranzo buia con le tovaglie ricamate, i centrini colorati fatti a mano e che risultavano, per noi appena arrivati dalla metropoli americana, tanto antichi. Fiori secchi sempre polverosi e gli anziani proprietari, che avevano praticamente adottato Mike. Come introduzione all’Italia mi andava pure bene, mamma era stravolta. Quell’odore di muffa la infastidiva, mangiare fuori non le piaceva, non si fidava delle trattorie. La gente la lasciava perplessa, non comprendeva la lingua, non riusciva a rilassarsi. Lei, che era così conservatrice nell’alimentazione, guardava la cucina nascosta dietro la porta e gli stessi ristoratori con ostilità e sospetto. Risultato: cappuccino o cioccolata calda con panna e cornetto per colazione, un panino a pranzo, uova fritte o un pezzo di carne sbattuto sulla griglia la sera, nella trattoria di fronte. Di tanto in tanto si andava all’American Bar in cima a via Nazionale, ritrovo di turisti e di qualche marine dell’ambasciata, per mangiare i pancake, un hot-dog, o meglio ancora un blt, nel gergo della cucina d’oltreoceano toast al bacon, lattuga e pomodoro. Per fortuna, il McDonald, supporto gastropsicologico angosciante e angoscioso degli americani all’estero, non era stato ancora inventato.
L’appartamento che papà aveva preso in affitto in via del Vascello era ancora in costruzione e sarebbe stato pronto soltanto un mese dopo. Monteverde Vecchio era bello, pieno di fiori e verde e aria buona da respirare – l’inquinamento, allora, era minimo: poche auto e motorini rumorosi – con i due parchi di Villa Sciarra e del Gianicolo; e c’era la storia dell’Italia dietro l’angolo con le statue dei garibaldini, il loro mausoleo, i luoghi dello scontro tra laici e clero.
Io mi divertivo anche se di amici non ne avevo. Avevo dodici anni e Michele, forse ricordandosi di come era il suo paese trent’anni prima, mi esortava a non dare l’impressione di voler troppo infastidire le ragazzine. «Non siamo in America» diceva, facendo balenare immagini di vendette familiari e di matrimoni imposti come riparazione per una mano sfiorata, un bacio innocente, o poco più.
Betty continuò a soffrire. Non le era facile adattarsi alla nuova vita, ai luoghi da scoprire non come turista ma con l’impegno di chi sa che non andrà più via. I prodotti sugli scaffali dei negozi le erano estranei. Imparare l’italiano era estenuante. Una mattina si confuse e l’intero mercato di Monteverde Vecchio si scosse in un’amichevole, profonda risata. Aveva acquistato del pesce e non voleva portare a casa le teste. «Può tagliare i capelli, per favore?» chiese più volte alla signora perplessa dietro il banco.
Aveva, Betty, anche un problema con la sporcizia italica. Evidentemente non aveva mai guardato dietro al bancone del delicatessen nel Bronx, dove una volta la settimana, o giù di lì, si andava tutti insieme a comprare sandwich al corned beef, patate fritte, qualche cetriolo e, confesso, una Coca Cola. Il parmigiano, poi, era – ed è rimasto per sempre – per lei troppo unto. Le dava fastidio persino maneggiarlo, così viscido, figuriamoci mangiarlo. Una volta Mike la sorprese nella cucina di via del Vascello mentre lavava col sapone alcune fette di salame: il coltello del salumiere, spiegò piuttosto irritata di fronte alle giuste lamentele di mio padre, non era pulito.
Per la mamma l’Italia era una specie di esilio. Per me era una tappa nuova nel quadro dell’internazionalismo al quale mio padre mi aveva indirizzato. Per Michele era il ritorno alle origini, agli odori, ai sapori, ai colori della giovinezza, alla sua lingua. Per tutti era confortante sapere che comunisti e socialisti non erano cittadini di terza classe, che l’Fbi non era appostata dietro ogni angolo, che le streghe, se esistevano, se ne stavano tranquille in attesa di tempi migliori. Andavamo alle Feste dell’Unità, alle manifestazioni dove si intonavano i canti partigiani costruiti sulle melodie delle vecchie musiche popolari e militari russe, le stesse che avevo ascoltato al cinema Stanley di Manhattan e che molti anni più tardi avrei riconosciuto nella città vecchia di Gerusalemme, dove un gruppo di anziani sionisti e di sopravvissuti all’Olocausto, i numeri tatuati sugli avambracci nei campi di sterminio pienamente visibili, ricordavano cantando gli anni pionieristici e lo sforzo per trasformare un antico sogno in realtà e costruire uno Stato nuovo, socialista, laico e democratico. Lo Stato c’è, quello del sogno no.
Le jeep scoperte della Celere sfrecciavano su e giù per via IV Novembre, si infilavano in piazza Venezia e tornavano indietro sparando manciate di lacrimogeni per disperdere la folla. I manifestanti brandivano bastoni e bandiere tricolori, lanciavano sampietrini contro il palazzo della stampa comunista. Per me, da poco arrivato a Roma, i loro slogan erano incomprensibili; fu Michele a spiegarmi che quella gente voleva che Trieste tornasse all’Italia. Ricordavo i francobolli italiani sovrastampati A.M.G.-F.T.T., sapevo che quella scritta stava per «Governo militare alleato, territorio libero di Trieste». Erano fascisti, quelli che manifestavano, diceva papà, e non chiesi altro. Intuivo vagamente il motivo della protesta. Molti anni dopo, leggendo i suoi vecchi scritti, compresi quale tormento doveva essere per lui quello scontro con i militanti dell’estrema destra. Michele, quando ancora si trovava negli Stati Uniti, aveva assunto una posizione ambigua riguardo Trieste e la Venezia Giulia, una posizione molto vicina a quella dei comunisti americani i quali, a loro volta, avevano sposato la linea di Mosca in netto contrasto con quella nazionalista partorita da Togliatti. Che cosa sosteneva il comunista Salerno sulle pagine dell’Unità del Popolo?
Abbiamo sempre riconosciuto che gli italiani sono una maggioranza all’interno della città di Trieste […]. È nella tradizione democratica italiana subordinare a problemi nazionali gli interessi della pace e della democrazia internazionale. All’interno delle frontiere della Jugoslavia gli italiani di Trieste serviranno meglio gli interessi del popolo d’Italia perché rafforzeranno il fronte mondiale della democrazia e della pace.
Un abbaglio, quello di Michele, dettato sicuramente dai troppi anni di lontananza dalla madrepatria e dai suoi sogni di costruire un mondo migliore al di sopra dei nazionalismi. È interessante, a questo proposito, un altro suo articolo riguardo il problema dell’Alto Adige.
Gli interessi nazionali dell’Italia non possono essere lasciati all’arbitrio di un movimento nazionalistico di dubbia ispirazione e di natura non democratica. Perché? Perché non abbiamo dimenticato […] un principio elementare di democrazia secondo il quale i movimenti cosiddetti irredentisti vanno appoggiati solo se e quando sono nell’interesse della pace e della democrazia mondiale.
Chi sa come avrebbe affrontato la questione del Kosovo e il conflitto che, ancora prima, aveva spezzettato la Jugoslavia. Su una cosa, anni fa, comunisti e capitalisti erano stati d’accordo: il rifiuto della balcanizzazione. Era un no netto alla frantumazione degli Stati, un sì alle entità più vaste, economicamente molto più facili da gestire. E se andiamo indietro nel tempo, agli anni dell’impero austroungarico, tutto sommato anche più facili da gestire nel rispetto delle minoranze.
Andammo a visitare le Fosse Ardeatine in una giornata di sole. Un miniviaggio alla periferia di Roma, un salto indietro nel tempo. Da piccolo, avevo letto un libro con la svastica nera impressa sulla copertina giallognola, trovato sullo scaffale di casa, e avevo capito bene di quale portata fossero gli orrori del nazismo. Nel Bronx avevo anche visto qualche film, prodotto mediocre dello sforzo americano per raccontare l’Olocausto e i demoni delle SS. Una cosa, però, sono le immagini di un filmato o il bianco e nero delle fotografie, altro è avvicinarsi alla realtà. Alle Fosse Ardeatine sembrava di toccare con mano. L’immenso lastrone che copre le tombe; le grotte dove i cittadini romani, molti dei quali ebrei rastrellati nel Ghetto poco prima dell’eccidio, vennero massacrati dai reparti speciali di Hitler prima di venir sepolti sotto il terreno fatto franare con le bombe, i nomi delle vittime, famiglie intere. Un giorno, frequentando la scuola media Ugo Foscolo nel cuore del Ghetto romano a pochi passi da ponte Garibaldi e via Arenula, mi sarei trovato seduto al banco con una ragazzina carina, simpatica, dolce, ma non sempre allegra. Il suo cognome compare molte volte alle Fosse Ardeatine. Lei era bambina quando i nazisti arrivarono quella notte nel Ghetto. Non le chiesi, forse per pudore, per non infierire, con chi e come era sfuggita al rastrellamento.
L’Italia nel 1951 non era un paese a cui era facile abituarsi per chi arrivava dagli Stati Uniti. Lo stipendio di Paese Sera era modesto ma sufficiente per tirare avanti, il vero problema, inatteso, venne da un’altra direzione. Nel Bronx avevo terminato le elementari e l’arrivo a Roma doveva coincidere con l’inizio delle medie. Purtroppo, quando Michele tentò di iscrivermi a scuola affrontando il problema con un ottuso burocrate del ministero delle Pubblica istruzione privo di tatto e piuttosto astioso, si trovò di fronte un muro: «Signor Salerno, noi prepariamo i nostri figli perché possano emigrare negli Stati Uniti e lei ci porta un americano che non parla una parola d’italiano. È ridicolo. Noi, qui, non ci possiamo fare nulla. Provi una scuola privata o qualcosa del genere. Oppure, ancora meglio, perché non rimanda suo figlio a New York per completare gli studi?».
Così fu. Dopo meno di un anno, Betty e io, tristi e frustrati, tornammo negli States. Non più a New York, bensì a Rochester, a casa di mio zio Shimon, il giustiziere del cosacco. Un viaggio bizzarro. La Saturnia era sempre più vecchia, il tempo pessimo, il mare primaverile grosso. Facevo la corte a una coetanea dodicenne: non ricordo il suo nome ma ho trovato una nostra foto sbiadita dal tempo, rovistando nel solito album di famiglia.
Dopo qualche giorno in mare fummo reintrodotti ai giochi della Guerra fredda. Un giovane alto, bello e vestito bene ci avvicinò premuroso e pieno di sorrisi e, con il passare dei giorni, di domande. Un pomeriggio mentre pagava una bibita notai il distintivo all’interno del suo portafogli: era un agente federale. Lo dissi a Betty e, quando lei chiese spiegazioni, fu costretto ad ammettere di lavorare per il governo: aveva il compito di controllare gli stranieri sulla nave prima del loro arrivo a New York. Riguardo a noi voleva sapere per quale motivo tornavamo in America e se la nostra mossa preludesse a un profondo rovesciamento ideologico di Mike.
A Rochester, la città dove George Eastman aveva creato l’impero delle macchine fotografiche Kodak, mi iscrissi alla Benjamin Franklin – scuola media e liceo di un quartiere periferico medio-alto – e portavo con orgoglio una grande F sulla mia giacca invernale rossa e nera. Il giornale scolastico mi intervistò perché ero l’unico degli studenti a essere stato in Europa.
Betty si trovò un lavoro non nuovo: faceva le asole dei sempre più lussuosi abiti da uomo di Hickey Freeman, la medesima fabbrica in cui aveva lavorato molti anni prima quando da giovane era approdata in quella cittadina, sempre ospite del fratello Shimon. Ogni sera attendevo ansioso il suo ritorno dallo stabilimento per contare i tagliandini colorati che costituivano la prova di tutte le asole da lei tagliate e cucite con cura. Il cottimo era stato abolito, ma le industrie avevano trovato il modo per aggirare l’ostacolo, offrendo un bonus che integrava i minimi salariali. Come un gioco d’asilo, ogni tagliandino doveva essere riposto per colore, come tanti francobolli, in un quaderno grigio. Il giorno dopo il tutto sarebbe finito nell’ufficio contabile della fabbrica dove la quantità e la qualità del lavoro compiuto, rappresentate dai diversi tagliandi, sarebbero state calcolate per poi costituire la sostanza del salario di Betty. Che, tanto per cambiare, non era molto alto.
Dopo alcune settimane trascorse con gli zii, trovammo un appartamento di una stanza con angolo cottura al primo piano di quella che una volta era stata una stazione di polizia. Era piccolo, ma avevamo la chiave di una delle celle al piano terra e potevo tenervi la mia bicicletta, una splendida Lazzaretti, acquistata a Roma e spedita per nave, che avrebbe provocato l’invidia di non pochi compagni di scuola. La Ben Franklin era ottima. E divertente. Le attività extra erano abbondanti e piacevoli. Era già inverno quando mi decisi a guadagnare qualche soldo vendendo, ogni pomeriggio, il quotidiano locale. All’inizio, in sella alla Lazzaretti, facevo il giro di un quartiere, tutte case basse con giardino annesso, condividendo con un amico un percorso stabilito. Passai poi a fare lo strillone in centro mentre aspettavo che Betty finisse di lavorare. Papà era un giornalista, io sognavo medicina. Chi sa, forse un giorno avrei calpestato il suo stesso terreno. Cominciavo dal basso, nel modo più americano possibile.
Il 19 giugno 1953 – mi mancavano meno di due mesi per i quattordici anni (e per il nostro ritorno in Italia) – stavo vendendo giornali davanti allo stabilimento dove lavorava mamma quando Julius e Ethel Rosenberg vennero uccisi sulla sedia elettrica del penitenziario di Sing Sing. Il lor...