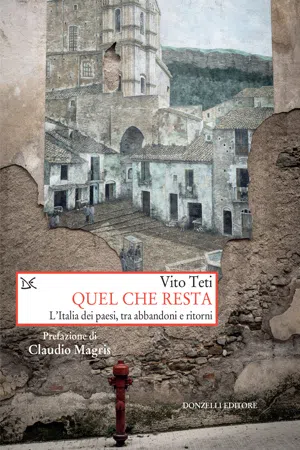![]()
Parte prima
Schegge
There’s a blood-red circle
on the cold dark ground
And the rain is falling down,
The church door’s thrown open
I can hear the organ song
But the congregation’s gone
My city of ruins
My city of ruins
(Bruce Springsteen, My City of Ruins)
| | Coloro che non hanno radici, e sono cosmopoliti, si avviano alla morte della passione e dell’umano: per non essere provinciali occorre possedere un villaggio vivente nella memoria, a cui l’immagine e il cuore tornano sempre di nuovo, e che l’opera di scienza o di poesia riplasma in voce universale. |
(Ernesto de Martino, L’etnologo e il poeta)
![]()
I. Rovine
1. La chiesa è spalancata: paesi abbandonati e città di rovine.
La storia e l’antropologia della Calabria, del Mezzogiorno dell’interno e di numerose aree del Mediterraneo, tutti luoghi di cui mi occupo in questo libro, sono segnate dall’esperienza dell’abbandono e della ricostruzione dei luoghi, della distruzione e della rifondazione degli abitati. I crolli e le rovine hanno fatto parte del vissuto delle popolazioni, ne hanno definito caratteri e mentalità, paure e speranze. Non soltanto nel lontano passato. Sono ancora nitide e vive, grazie alla presenza di televisioni nazionali e locali che le hanno diffuse in tutto il mondo, le immagini del crollo delle case di Cavallerizzo, la comunità arbëreshë, abbandonata precipitosamente, nella notte tra il 6 e 7 marzo del 2005, a seguito di una enorme frana che lavorava da molto tempo, in maniera non tanto silenziosa.
Svegliati da un personaggio da romanzo, che vegliava il paese pericolante, i circa trecento abitanti hanno fatto appena in tempo a prendere qualcosa nelle case. Sono scappati nella notte, a piedi o con le macchine. Il rumore della montagna e delle case che scricchiolano, divorate dalle frane, se lo portano nelle orecchie e nel ricordo. L’indomani, quando ancora le case cadevano, sono tornati nella chiesa del paese, hanno recuperato la statua di san Giorgio e così si sono sentiti definitivamente in salvo. In salvo ma con i ricordi fissati a quella terribile notte. La vita di nessuno di loro sarà mai più come prima. Oltre al problema della ricostruzione dell’abitato in una località vicina, una volta accertata (secondo alcuni in tempi e con conclusioni discutibili) l’impossibilità di ricostruire nel vecchio sito, adesso si pongono quello di cosa avverrà delle vecchie case, di quelle rimaste ancora in piedi, della chiesa che non è crollata. Affermano in maniera ancora imprecisata il desiderio che quel luogo non vada in rovina, che le case non diventino macerie. Ho visto anziani e giovani, donne e bambini guardare dal muro della vicina Cerzeto, di cui Cavallerizzo è frazione assieme a San Giacomo, una sorta di luogo del pianto, in direzione della frana, delle case distrutte, del paese crollato. Mi è stato impossibile non associare quel crollo ad altri crolli più fragorosi e che hanno segnato la nostra vita, certo, in maniera più profonda.
Non è possibile più, direi che è impensabile, parlare del senso dei luoghi, del rischio che i luoghi finiscano, delle rovine del più ignoto, ignorato, periferico paese del nostro mondo antico, del territorio in cui abitiamo, senza avere dinnanzi agli occhi le macerie e le rovine contemporanee, così lontane, così vicine. Niente più dell’abbattimento delle Torri Gemelle (ma, come vedremo, vale anche per la città di Aleppo, scarnificata da una guerra infinita che l’ha trasformata nell’immagine di uno scheletro senza carne e senza sangue) può fare pensare a una sorta di profezia apocalittica che si è autoavverata. La letteratura, la poesia, il cinema, i fumetti, le leggende metropolitane avevano già raccontato in mille modi le rovine di New York. La città del dopo catastrofe, dove si aggirano tra le macerie i volti angosciati e smarriti dei superstiti, che continuano ad aggrapparsi alla vita, ci è stata tante volte consegnata e raccontata, al punto che le sequenze drammatiche e in presa diretta delle Due Torri sono parse a molti un déjà vu, insieme atteso e temuto.
Non possiamo più pensare a catastrofi, a crolli, a distruzioni del passato prescindendo dalle immagini delle macerie provocate dai bombardamenti nell’ex Jugoslavia, in Afghanistan, in Iraq, in Siria, che ci hanno accompagnato quotidianamente negli ultimi anni e continuano a farlo. La storia passata e quella futura hanno, almeno per il momento, come punto di partenza all’indietro o in avanti, le rovine recenti. Lo tsunami che provocò, nel dicembre del 2005, centinaia di migliaia di vittime assomiglia a una specie di controcanto e di ulteriore ammonimento della natura alle distruzioni consapevolmente organizzate dall’uomo.
C’è un frammento di Corrado Alvaro, che affiora spesso nella mia memoria, preciso e drammatico nella sua forza visiva:
Il paese abbandonato intorno si sfascia rapidamente, le piazze e le strade deserte sono amplificate dai meandri che si aprono nelle case crollanti, di dove hanno portato via le porte e le finestre, gli ammattonati e le tegole. Crollano a ogni pioggia, con un polverino minuto, i tetti e i pavimenti nelle cucine e nelle stalle. […] La chiesa è spalancata, l’altare disadorno, e qui il muro che si sfalda è pieno di dramma: sembra che qui sia un perpetuo Venerdì Santo, quando si manomettono gli altari e se ne abbattono le suppellettili (Alvaro 1990b).
È lecito domandarsi se esistano davvero e, se esistono, attraverso quali percorsi si sono definiti, legami e reciproci rimandi tra la «chiesa spalancata» descritta da Alvaro, che racconta di un paese calabrese che si disgrega e si sfalda a seguito della discesa delle popolazioni dell’interno lungo le marine, la «chiesa spalancata» della City of Ruins cantata da Bruce Springsteen e la chiesa dove ritornano gli abitanti di Cavallerizzo per recuperare la statua del santo patrono (e le chiese di tanti paesi calabresi e di altre parti d’Italia vuote e in rovina dove le persone continuano a tornare). Queste vicende di mondi lontani e diversi, che vedono nella fine del «centro», del «tempio», la fine del mondo, sono riconducibili a una medesima matrice storica e culturale?
Ad accomunare e avvicinare i luoghi, tutti i luoghi dell’antico e del nuovo mondo, sono una storia e delle concezioni della storia di lunga durata, vi sono vicende diverse e anche lontane che, nell’epoca della globalizzazione, convergono verso un analogo sentimento – un’analoga esperienza – della fine che le rovine presentificano.
Le immagini catastrofiche e le visioni apocalittiche del nostro tempo sono state «preparate», annunciate, da storie, concezioni, riflessioni che appartengono fin dall’antichità, quasi «dalle origini», a quella che definiamo, con buona approssimazione, tradizione occidentale. Come quello della melanconia a cui è indissolubilmente legato, il tema delle rovine, che rivela il senso della storia e di ciò che accaduto e che non torna più, risale all’antichità. La letteratura sulle rovine è sterminata e variegata; qui intendo soltanto ricordare che se le rovine sono presenti in molte società antiche e in diverse culture extra-occidentali, orientali, primitive, l’attenzione per esse si è affermata soltanto in quella tradizione culturale chiamata «occidentale», come ha avuto modo di ricordare Salvatore Settis (2003).
Le rovine, le distruzioni, gli abbandoni segnano la storia e le culture delle civiltà del Mediterraneo e dei luoghi adiacenti ad esso influenzandoli profondamente. I miti delle origini riportano sempre a un Diluvio, a una Distruzione. Atlantide è il sogno e la nostalgia di una città scomparsa, che affascina ancora oggi. E ciò che l’uomo costruisce è soggetto a distruzione dell’uomo. Troia nell’Iliade e Gerico nel Vecchio Testamento sono esempi di come ciò che è grande e potente sia destinato a essere distrutto. Pensiamo ancora alla sorte di Pompei e di Ercolano, a quella di Gerusalemme, e alla Roma degli incendi: gli uomini del passato hanno avuto esperienza e consapevolezza delle rovine, dei resti di ciò che passa e non dura in eterno. Settis ha commentato, in questa prospettiva, il famoso passo di Tucidide che all’inizio della Guerra del Peloponneso riflette sulla grandezza e sul potere di Sparta:
«Se Sparta fosse ridotta in rovina, e ne sopravvivessero solo i templi e le fondamenta degli edifici, i posteri non potrebbero mai attribuirle la potenza di cui le fonti pur serberanno la fama […], poiché essa non ha un’imponente struttura urbana né templi o edifici sontuosi, ma è un insediamento all’antica, per villaggi» (I.10,2). Tucidide fa dire poi a Pericle: «Noi Ateniesi non abbiamo bisogno di nessun Omero che canti la nostra gloria» (II.41,4). Lo «scheletro e il rudere, la gloria e la fortuna» delle due città si misurano per un istante col vertiginoso scorrere del tempo: altra è la grandezza presente dei territori e degli eserciti, altra la traccia che ne resterà (Settis 2003).
Percezione dello scorrere del tempo, ossessione della fine e senso delle rovine sono motivi indissolubili e già presenti negli autori dell’antichità classica. Ma sono indubbiamente l’incendio e il crollo di Roma, la città immensa e meravigliosa, a rendere irreversibile l’attenzione per le rovine. Un’attenzione consolidata dalla brusca frattura segnata dalla fine dell’impero romano e la «drastica rottura di continuità» che ne seguì: il crollo più o meno simultaneo (e permanente) di una religione, di un’organizzazione dello stato e del territorio e di una società. Di tutte le fratture e le discontinuità conosciute dai diversi popoli (almeno occidentali), quella di Roma si configura come una fine del mondo e non è paragonabile a quanto accade in altre tradizioni culturali. Come ricorda ancora Settis (ibid.), l’attenzione alle rovine, pure centrata su Roma, nasce fuori da Roma e implica una sorta di sguardo da lontano prima di penetrare poi in Italia. Come se i «locali» non si rendessero conto della catastrofe in corso, e i Romani considerassero non definitivo il crollo dell’impero. Spetta ai cittadini di Roma, che vivono fuori da Roma o che sono originari delle periferie dell’impero, manifestare il dolore e lo stupore per lo spopolamento delle città e per l’immagine della capitale ridotta a un cumulo di macerie. Le rovine di Roma, ancora per tutto il medioevo, sono viste dai Romani, spesso segnalate come confini, ma non «guardate», non danno origine a riflessioni e a descrizioni (ibid.).
Eppure non mancano esempi di sguardi interni-esterni, insieme da lontano e da vicino. Si può certamente ricordare tutta quella letteratura della fuga, del ritorno, del rimpianto che accompagna la distruzione e il crollo della Roma imperiale, che troviamo in autori che vivono a Roma, ma vengono dalla periferia dell’impero o in osservatori che, sgomenti e angosciati, osservano e raccontano le devastazioni dei barbari. È un sentimento della fine, narrato in presa diretta, che assume quasi i contorni di una Fine del Mondo, proprio per quello che Roma e l’impero rappresentavano (il centro del globo e della cristianità intera). Lontano da Roma, forse, si acquista una maggiore consapevolezza che niente sarà più come prima. Nel suo «ritorno», un vero e proprio nóstos, da Roma alla sua patria agognata, la Gallia distrutta e devastata dalle numerose invasioni del IV-V secolo, Claudio Rutilio Namaziano incontra i segni delle devastazioni e dell’abbandono. Il De reditu suo è il poema, denso di rassegnazione e melanconia, del viaggio di esilio, compiuto tra il 415 e il 418, dalla grande e amata Roma alle terre di origine devastate e rovinate, che egli è chiamato a ricostruire:
Non si possono più riconoscere
i monumenti dell’epoca trascorsa,
immensi spalti ha consunto il tempo
vorace.
Restano solo tracce fra crolli e rovine
di muri,
giacciono tetti sepolti in vasti ruderi.
Non indigniamoci che i corpi mortali
si disgreghino:
ecco che possono anche le città morire.
Scrive ancora Rutilio Namaziano: «Non dura mai troppo a lungo ciò che piace senza fine» (1992). Sembra esservi la consapevole accettazione e l’atteggiamento rassegnato della finitezza dell’uomo, delle città, delle sue costruzioni, quasi come un fatto naturale, che rientra in un ordine di cose naturale, ma emergono anche una visione e una concezione della storia che avevano origini in una più consolidata tradizione e che sembrano anticipare il moderno delle rovine e l’altrettanto moderno sentimento della melanconia.
Non solo in quelle che furono le regioni e le città del Nord dell’impero, ma anche al Sud la caduta di Roma coincide con rapine, devastazioni e lutti di cui permangono vaste tracce nella letteratura a sfondo religioso. Dopo la guerra greco-gotica della seconda metà del VI secolo, con la crisi dell’antico sistema viario, la povertà e la miseria imperanti, il Mezzogiorno d’Italia appare un paese di città spopolate e di campagne abbandonate. L’invasione longobarda esaspera tale situazione:
le città sono devastate, i castelli abbattuti, le chiese bruciate, i monasteri maschili e femminili distrutti. I campi sono spopolati e la terra giace in solitudine, abbandonata da ogni coltivatore. Nessun proprietario la abita. Gli animali hanno occupato i luoghi dove prima viveva una moltitudine di uomini (Gregorio Magno, cit. in Dalena 2003).
Città spogliate, luoghi di culto dati alle fiamme sono motivi che ritroveremo in tanta letteratura successiva e sono immagini che ancora oggi ci arrivano da testimonianze orali, a conferma di storie di abbandoni e trasformazione dei luoghi nella lunga durata. Il crollo dell’impero resta certo l’evento di eccezionale portata per l’affermarsi della consapevolezza delle rovine. Tutta la letteratura su Roma, prodotta fuori dalla città (in Inghilterra, ma anche in Francia), che si diffonde in Italia assumendo connotazioni tendenzialmente antiquarie, è all’origine della nascita di una consapevole attenzione occidentale per le rovine.
L’interesse moderno per le rovine, una sorta di tautologia dal momento che attenzione per le rovine e nascita della modernità vengono quasi sempre associate, viene datato da studiosi, archeologi, artisti a partire da una tradizione pittorica e artistica che possiamo far risalire al Quattrocento. Nicole Dacos, in Roma quanta fuit. Tre pittori fiamminghi nella Domus Aurea (2001), mostra come, a partire dai primi decenni del Cinquecento, sono alcuni artisti fiamminghi (Heemskerck, Posthumus, Sustris) a inventare, con riferimento a Roma, il «paesaggio delle rovine» che influenzerà la tradizione iconografica dei secoli successivi. Maarten van Heemskerck è autore non solo di disegni di antichità romane, ma anche di incisioni in cui il crollo di città come Babilonia o Gerico è colto nel momento fatale; Hieronymus Cock compone nel 1551 il più antico libro di incisioni che ha come tema le rovine di Roma. Da allora fino ad oggi il paesaggio delle rovine di Roma rimane un «cantiere aperto» (Settis 2003). Per cogliere la moderna attenzione alle rovine, che poi sfocerà in riflessioni filosofiche, estetiche, letterarie, Michel Makarius si rifà a una tradizione iconografica che parte da un’illustrazione di Francesco Colonna, l’Hypnerotomachia Poliphili, apparsa nel 1546, fino a giungere alle tavole di Giovanni Battista Piranesi del 1759 sulle antichità romane. Dietro non ci sono soltanto l’immagine e la nostalgia, il rimpianto e il mito di Roma – abbastanza omogenei al clima culturale dell’Umanesimo e del Rinascimento che hanno come punto di riferimento ineludibile il «classico» –, c’è anche la tradizione apocalittica medievale, che si rifà a quella antica, nella rappresentazione di distruzioni e rovine di città. I due motivi non sono separati. Le rovine di Roma, ma anche quelle dell’Antico Testamento e quelle delle Apocalissi medievali, che entrano in scena, sono la testimonianza che una nuova Apocalisse è sempre possibile. Le rovine di Roma sono un regesto, una sorta di memento, di appunto, di lezione per quanto potrà accadere, per quanto accadrà.
La transizione al Moderno viene collegata alle opere, ai quadri e alle riflessioni sulle rovine prodotte con maggiore intensità dal Seicento alla fine del Settecento. In questo periodo le riflessioni dei giovani artisti europei che scendono in Italia, i protagonisti del Grand Tour e le scoperte archeologiche, alimenteranno il fascino e il sentimento delle rovine e influenzeranno in maniera decisiva gli scrittori romantici. Dal Quattrocento ai nostri giorni, insomma da Colonna a Piranesi, da Chateaubriand a Baudelaire, da Simmel a Benjamin, la letteratura e le opere, le considerazioni e le produzioni sulle rovine in qualche modo accompagnano la nascita della modernità, concorrono a una sua definizione (cfr., di recente, Makarius, Speroni, Belpoliti).
«Manifesto» di un nuovo modo di intendere il tempo, la storia e il destino dell’uomo, le rovine e i resti prefigurano sempre più il sentimento della fine. Tra il XVII e il XIX secolo, con l’erosione e la dissoluzione delle culture tradizionali basate sul mito dell’eterno ritorno, si afferma definitivamente l’idea di un tempo lineare entro cui la rovina appare ineliminabile, annunciata, una costruzione (talvolta quasi un desiderio, un bisogno) dell’uomo. Anche il fascino delle rovine sembra legato al sentimento tutto moderno della fine.
Dopo il crollo dell’impero di Roma, dopo la caduta di Bisanzio e il terremoto di Lisbona, in epoca moderna, le rovine assurgono definitivamente a segno e metafora della fine della civiltà, dovuta agli uomini o alla natura. È allora che i resti del passato vengono scoperti, cercati e osservati come testimonianza e memoria di un’epoca gloriosa da rimpiangere e da contrapporre al presente. Il sentimento delle rovine, come racconteranno Baudelaire e Benjamin, è tutto moderno: esse alimentano il senso della storia dell’umanità, sia essa vista come progresso sia percepita come caduta e decadenza.
Le rovine sono la traccia di qualcosa che è stato e non è più: un passato che va interpretato e con cui bisogna fare i conti, in una cornice nella quale il modello circolare del tempo entra in crisi, a favore di quello lineare e irreversibile della modernità. In questa cornice, la nostalgia non racconta più un ritorno, ma l’impossibilità del ritorno che le rovine accentuano. Il patto col diavolo, la figura dell’eroe romantico fatale e maledetto, il vampiro sono manifestazioni della paura di morire e del desiderio di eternità. Questa attenzione alle rovine, la produzione artistica ad esse legata, le riflessioni che esse suscitano sono talmente interne alla tradizione occidentale da diventare una sorta di discrimine tra noi e gli altri. Quello che è l’esito di una storia particolare, che si svolge una e una sola volta, diventa quasi categoria universale.
Chateaubriand, nel Genio del cristianesimo, distingue tra rovine della natura e rovine provocate dall’uomo e nota che tutti gli uomini hanno una segreta attrazione per le rovine, a causa di un sentimento del sublime destato dal contrasto fra la nostra condizione umana e la caduta dei grandi imperi. Ma questa attrazione è soltanto occidentale. In Cina (come ricorda Wu Hung 1995), ad esempio, nessuna scena narrativa è mai posta su uno sfondo di rovine. Nei dipinti non vi sono mai resti di edifici abbandonati: piuttosto, campi non coltivati o alberi vicini alla morte; rovine, insomma, sì, ma della natura. Nella tradizione cinese gli edifici in rovina non erano mai oggetto di venerazione e di riflessione. Anche l’Africa, che pure ha le sue rovine, è lontana dall’ossessione per esse. E l’attenzione alle rovine di altre grandi civiltà sembra dovuta più allo sguardo e alla sensibilità di noi occidentali che non delle popolazioni locali.
Le grandi civiltà extra-occidentali, ma anche quelle arcaiche e primitive, hanno conosciuto paesaggi di rovine (della natura, dei villaggi, dell’abitato), ma le rovine non hanno costituito un’ossessione, esse sono state inserite all’interno della natura e collocate in una concezione «ciclica» del tempo, in una visione del mondo che prevedeva la morte, il ritorno e la rinascita. Mircea Eliade ricorda come le speculazioni indù sul tempo ciclico mostrino con particolare insistenza il «rifiuto della storia». Nella tradizione arcaica, primitiva e nelle culture orientali, la distruzione di un raccolto, la siccità, il saccheggio di una città da parte del nemico, epidemie, terremoti, tutto questo trova la sua giustificazione nel «trascendente, nell’economia divina» (Eliade 1968). L’originalità della tradizione occidentale consiste proprio nella distanza che essa inaugura e stabilisce dalla concezione mitica del tempo e ciclica del ritorno.
2. Da Ulisse a Mosè: fine del mito dell’eterno ritorno.
Il senso occidentale delle rovine è legato all’esistenza di una precedente concezione dentro la quale anche quel crollo può essere inserito, decifrato e raccontato.
I paesaggi di rovine nati a seguito della caduta dell’impero non fanno che inverare quelle profezie, concezioni, filosofie e visioni apocalittiche dentro le quali le rovine (passate o future) avevano già una loro collocazione e assumevano un senso. Secondo le previsioni dell’apocalisse ebraico-cris...