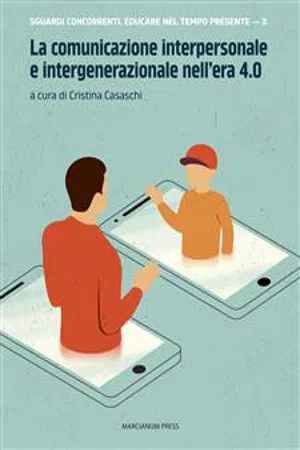Oltre che essere molto accelerato, il mondo attuale è anche molto
vario e articolato. Le società post-moderne presentano un problema
nuovo ma anche molto interessante: la pluralità. Categorie uniche,
predefinite e per lo più polarizzate, come uomini vs. donne,
cristiani vs. atei, giovani vs. anziani, “destra” vs. “sinistra” e
così via, sono vieppiù venute a sfrangersi in molteplici specchi
caleidoscopici.
La cultura occidentale fatica a pensare il molteplice, visto che
la storia filosofica dell’Occidente s’è impegnata nel dare una
visione sistematica e totalizzante della realtà. Di molte categorie
della filosofia, della sociologia, della pedagogia del secolo
scorso, l’unica che sembra essere ancora universalmente operativa è
la techné, come Emanuele Severino
[1]
ha magistralmente indicato. Anche la pedagogia risente di una
qual certa “didattica” intesa in termini tecnici, come traspare da
espressioni quali “livelli minimi di apprendimento”, “bilancio
delle competenze”, “oggettività della valutazione”, ecc., ecc.,
tutte forme di tecnicizzazione del rapporto educativo che già Don
Lorenzo Milani aveva stigmatizzato. Forse che la sacca di ragazzi
NEET, oltre a molti altri ragazzi non agganciati dalla scuola,
costituisce una classe di “resistenti” alla pressione della techné
scolastica, la quale, scavalcando le intrinseche difficoltà del
confronto con il molteplice, impone un unico standard? Dopo tutto,
il problema della scuola d’oggi ha molto a che fare con l’ampio
ventaglio delle situazioni “a-normali”: dai DSA, alle disabilità
comportamentali, psichiche, fisiche, ecc. L’appello all’inclusività
rischia di rimanere lettera morta se non si consente a ciascun
istituto di adattare la propria azione organizzativa secondo
parametri locali. Come già ebbe a dire nel 1967 Don Milani
l’istituzione scolastica è necessaria proprio per chi più ne è
lontano socialmente, culturalmente e come forma mentis. Ma, come si
legge in un Blog di Maurizio Parodi del marzo 2016, fondatore del
movimento “Basta compiti”:
Il Ministero della Pubblica
Istruzione ha fatto sapere che gli studenti con disturbi specifici
di apprendimento, certificati (Dsa), sono 186.803, di cui 108.844
dislessici, 38.028 disgrafici, 46.979 disortografici e 41.819
discalculici; ma secondo l’Associazione italiana della dislessia
sarebbero più di 350 mila. Nel 2010/2011 erano lo 0,7% della
popolazione scolastica; quattro anni dopo, 2014/2015, sono saliti
al 2,1%: un aumento vertiginoso e inquietante delle diagnosi che
dovrebbe allarmare e suggerire riflessioni non più differibili, a
cominciare da un interrogativo di elementare buon senso: possibile
che con il passare del tempo, storico, i bambini e i ragazzi siano
sempre più “disturbati”, più “deficienti”, meno “adattabili”, meno
“adatti”? Siamo sicuri che la certificazione dei problemi di
apprendimento non sia il modo più comodo, per la scuola, di non
mettersi in discussione, di perpetuare logiche e pratiche non
“adatte” o “adattabili”? Davvero siamo convinti che la
medicalizzazione del disagio non rappresenti una forma di
“irresponsabilità” professionale e di autoreferenzialità
istituzionale? Il sospetto, ampiamente suffragato (v. dati OCSE), è
che l’apparato funzioni secondo principi più o meno inconsapevoli o
inconfessabili che troppo spesso sono all’origine dei disturbi
lamentati. Ipotizziamo, per esempio, che la didattica si fondi sul
paradigma secondo cui “la scuola è giusta e semmai gli studenti
(che non riescono) sono sbagliati”: cosa accadrebbe? Esattamente
ciò che sta accadendo: chi meglio si adegua viene accolto, chi non
vuole o non può adattarsi viene considerato “anormale”,
etichettato, separato e magari “respinto”. Un autentico paradosso,
considerato che la scuola non dovrebbe emarginare chi è diverso,
chi non sa, chi non riesce, chi non ha voglia di sapere,
riconoscendo, anzi, tutti questi come suoi problemi, come l’oggetto
stesso del proprio operare, e non come ostacoli al suo ordinato
svolgimento. Se così non fosse, sarebbe più onesto dichiarare, sul
frontespizio del PTOF: “Gli studenti sono al servizio della scuola,
e non viceversa.
Le antropologie sottostanti al priore di Barbiana, da una parte,
e ai cultori della didattica oggettiva, dall’altra parte, declinano
molto probabilmente quello che nella storia del pensiero
occidentale si ricollega all’intreccio di due approcci
complementari, come quello analitico scientifico e quello simbolico
umanistico. Il primo sembra essere maggiormente interessato alle
cose e al loro manifestarsi esteriore (all’ “oggettivo”), anche in
termini di cause che producono certi effetti, che vanno valutati e,
se del caso, rinforzati o dissuasi. Il secondo approccio sembra
maggiormente interessato al mondo interiore dell’essere umano (al
“soggettivo”), alla sua coscienza al di qua di come essa si
manifesti in termini di effetti sul mondo. In generale, i due
approcci possono essere ricondotti a due filosofie pedagogiche
radicalmente opposte, come quella platonica, per un verso, e
aristotelica, per un altro.
Per Platone, infatti, l’educando “già sa” e compito
dell’educatore è guidarlo nel “trar fuori”, alla luce della
coscienza, il proprio bagaglio di conoscenze sul mondo. Per
Aristotele (ma forse sarebbe meglio dire per l’aristotelismo),
l’insieme delle conoscenze è da raccogliersi e trasmettere alle
nuove generazioni, secondo il vaglio della razionalità affinata
dalla logica. L’approccio aristotelico sembra molto più
unidirezionale, sotto la legge del logós che non ammette
contraddizioni, mentre l’approccio platonico si basa tutto sul
metodo dialettico, in cui il maestro è il levatore che porta a
manifestarsi la verità-conoscenza dell’educando. Nel Menone,
Platone racconta un esperimento di geometria con uno schiavo
ignorante per mostrare come il sapere sia già nella mente
dell’uomo. L’Etica a Nicomaco di Aristotele è un magnifico manuale
d’istruzione circa la conoscenza pratica che serve a un uomo per
essere cittadino attivo della propria comunità politica.
Entrambi gli approcci hanno ovviamente una loro dignità da
coltivare e da agire alternativamente l’una con l’altra, ma in
tempi di dominio della tecnica, la visione platonica della
maturazione conoscitiva va sempre più a finire nella pedagogia dei
margini, quella per i disabili, gli stranieri, gli emarginati
sociali (che, da questo punto di vista, sembrerebbero quasi
paradossalmente “più fortunati”, perché la loro esclusione dalle
forze dominanti ne fa una categoria che solo un approccio
relazionale à la Platone può sperare di conquistare).
Un’educazione maieutica parte dai moventi del complesso
corpo-mente
[2]. Nella didattica programmata sembra non possa esserci
spazio per un’esperienza il cui obiettivo non può essere già
previsto. Per la pedagogia platonica, invece, ogni gruppo e ogni
individuo sono realtà a sé. L’impossibilità di “ripetersi” rende
tale proposta pedagogica sospetta a tutti coloro che invece puntano
sulla progettazione dell’esperienza didattica per garantire dei
supposti principi generali dell’istruzione. La cosa è comprensibile
perché trasmettere il sapere è diverso che formare le persone.
Partendo dal corpo in azione e dalle sue reminiscenze, come le
chiama Platone, l’approccio “centrato sul soggetto” può entrare
anche nella didattica delle discipline scolastiche, come la
matematica, la geometria, il disegno, la lingua e la storia, ecc.
Sentire, ricordare, fare e disfare sono tutte operazioni che nelle
attività del corpo includono operazioni come misurare, operare
secondo la logica naturale, proiettarsi in uno spazio attraverso
l’azione: si conta su base dieci come le dita della mano, lo spazio
euclideo è l’ambito dell’azione-enazione
[3], la storia è la sequenza degli eventi che hanno generato il
presente, ecc. ecc. Perché non chiedersi, per esempio, se non sia
possibile insegnare la storia a ritroso, partendo dalla condizione
dei bambini qui e ora, così da rendere tangibile quanto il passato
determini il presente; oppure sperimentare la matematica partendo
dalle dita o dalle braccia, assumendo una base binaria del calcolo?
Perché, ancora, non sviluppare la memoria con l’antico metodo dei
loci, che richiede un camminare in uno spazio famigliare dove
depositare i ricordi, uno spazio che prima è esperienziale e, poi,
mentale?
Prendendo atto di tutte le variazioni generazionali delle
condizioni del vivere storico-sociale dell’essere umano, dobbiamo
altresì ricordare che egli è, nella sua struttura
fisico-antropologica, lo stesso da 40.000 anni. Questo ci fa quindi
“sperare” che alcune “leggi” della comunicazione siano ancora
valide, nonostante i cambiamenti della mente tecnologizzata.