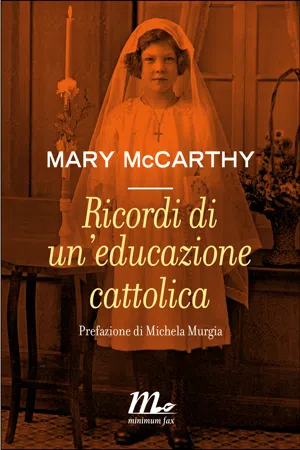1. CHI È QUEL CONTADINO LAGGIÙ?2
Ogni volta che noi bambini andavamo a stare per qualche tempo dalla nonna, ci mettevano a dormire nella «stanza del cucito», un locale rettangolare, destinato esclusivamente a usi pratici, squallido e male arredato, più studio che camera da letto, più soffitta che studio; quella insomma che, nella gerarchia delle stanze, teneva il posto del parente povero. Raramente gli altri membri della famiglia ci entravano, raramente la cameriera ci passava la scopa. Era una stanza senza pretese: la vecchia macchina per cucire, qualche sedia scompagnata, una lampadina senza paralume, rotoli di carta da pacchi, cataste di scatole di cartone che un giorno o l’altro avrebbero potuto servire, cartine di spilli e scampoli di stoffa, insieme alle brandine di ferro pieghevoli, adibite al nostro uso, e alle nude assi del pavimento, contribuivano a dare l’impressione di una intensa e spietata precarietà. I copriletti bianchi e leggeri, come quelli che si usano negli ospedali e negli istituti di beneficenza e, alle finestre, le persiane spoglie, senza tendine, ci ricordavano la nostra condizione di orfani e la natura effimera del nostro soggiorno; non c’era nulla, nella stanza, che ci incoraggiasse a considerare come nostra quella casa.
I bambini del povero Roy, così ci definiva la deprimente commiserazione di tutti, non potevano permettersi illusioni, secondo il punto di vista della famiglia. Nostro padre ci aveva condannato all’emarginazione sociale morendo all’improvviso d’influenza e portando via con sé la nostra giovane madre: una defezione, questa, che veniva sottolineata con un misto di orrore e di cordoglio, come se mamma fosse stata una graziosa segretaria con la quale papà si era licenziosamente involato verso l’irresponsabile Eden dell’aldilà. La nostra reputazione era offuscata da quella sciagura. Non solo in famiglia, ma anche tra i fornitori, i domestici, i conducenti del tram e gli altri che gravitavano nella nostra orbita era diffusa la sensazione che il nonno, uomo ricco, si fosse comportato con straordinaria munificenza stanziando una somma mensile per il nostro mantenimento e installandoci con antipatici parenti di mezza età in una casa squallida a due isolati dalla sua. Non si faceva parola delle alternative che il nonno avrebbe avuto: probabilmente avrebbe potuto mandarci in un orfanotrofio e nessuno l’avrebbe biasimato comunque. E anche coloro che simpatizzavano con noi erano convinti che conducessimo un’esistenza privilegiata: privilegiata perché non avevamo nessun diritto, e il fatto stesso che ogni anno, alla festa di Halloween o di Natale a casa di uno zio, noi apparissimo così tristi, mal vestiti e malaticci in confronto ai nostri rosei e raffinatissimi cugini, confermava il giudizio che di noi era stato dato: era palesemente un impulso generoso quello di tenerci in famiglia. E dunque, più meschina era la nostra condizione, più grande appariva la magnanimità del nonno, punto di vista che condividevamo noi stessi, guardando con dolcezza e timidezza il vecchio signore – con i suoi reumatismi, il viso roseo e i capelli bianchi, messi in risalto dai boccioli di rosa che gli adornavano il bavero e la Pierce-Arrow3 – come fosse la sorgente della bontà e della filantropia; e la monetina da cinque centesimi che ogni tanto ci regalava perché la domenica, in chiesa, la lasciassimo cadere nel piatto delle offerte (normalmente il nostro contributo era di due centesimi) ci riempiva non d’invidia, ma di semplice ammirazione per la sua potenza: questo era davvero un gesto principesco, questo era il vero modo di donare! Non ci veniva in mente di giudicarlo per la disparità dei nostri stili di vita. Qualsiasi risentimento provassimo, lo riservavamo ai nostri custodi, i quali, ne eravamo certi, si intascavano indebitamente il denaro destinato a noi, poiché le comodità della casa dei nonni – le stufe elettriche, i caminetti a gas, gli scaldini da grembo, gli scialli dolcemente avvolti intorno alle vecchie ginocchia, la carne bianca di pollo e quella rossa di manzo, l’argenteria, le tovaglie candide, le cameriere, l’autista ossequioso – ci persuadevano che il budino di riso con le prugne, gli intonaci scrostati e gli abiti rattoppati erano hors concours per quelle persone, e quindi non potevano essere voluti da loro. La ricchezza, nella nostra mente, era l’equivalente dell’abbondanza, e la povertà solo un sintomo di animo meschino.
Eppure, anche se ci fossimo convinti dell’onestà dei nostri custodi, saremmo comunque rimasti aggrappati all’immagine benefica del nonno che il mito familiare ci proponeva. Eravamo troppo poveri – spiritualmente parlando – per mettere in dubbio la sua generosità, per chiederci come mai permetteva che vivessimo a una certa distanza da lui, in un’atmosfera di gelo, di privazioni e di oppressione, e incappucciava i suoi occhi azzurri e bonari nelle irsute sopracciglia grigie da milionario ogniqualvolta si trovava davanti la prova delle nostre sofferenze. La risposta ufficiale la conoscevamo: i nostri benefattori erano troppo vecchi per sobbarcarsi quattro bambini scatenati; il nonno era assorbito dai suoi affari e dai suoi reumatismi, ai quali si dedicava come a un pio dovere, portandoli con sé nei pellegrinaggi a Sainte Anne de Beaupré e a Miami e offrendoli con imparziale riverenza al miracolo della Madre del Nord e del sole del Sud. Questi reumatismi consacravano il nonno dandogli il marchio di una vocazione particolare: ci conviveva come un artista o un brizzolato Galahad, e lo sottraevano a tutti noi, perfino alla nonna, la quale, non soffrendo di quell’acciacco, conduceva un’esistenza relativamente ingiustificata e manifestava, nei rapporti con noi bambini, uno spirito più aspro e più bellicoso. Nonostante tutto, sentiva di essere esposta alle critiche, e allontanando da sé con la vecchia mano esperta questa consapevolezza, non cessava mai di scrutare nel nostro animo in cerca di segnali di ingratitudine.
Noi, in realtà, eravamo grati fino al servilismo. Non formulavamo richieste, non nutrivamo speranze. Eravamo appagati se solo ci si permetteva di godere della luce riflessa di quella solare prosperità e di andarci qualche volta a sedere, nei pomeriggi d’estate, all’ombra del portico, o di oziare, in un mattino d’inverno, sulle poltroncine di vimini della veranda, o di fissare a bocca aperta il piano meccanico nella sala da musica, o di annusare l’aroma del whisky nell’armadietto di mogano della biblioteca, o di arrampicarci qua e là, nel salotto in penombra, per scrutare i dipinti sotto vetro con le loro massicce cornici dorate, ricordi del viaggio dei nonni in Europa: gruppi di bruni italiani in pellegrinaggio, pesanti e lustri come grappoli d’uva, donne napoletane che portavano ceste al mercato, vedute di canali veneziani, scene di mietitura in Toscana: temi profani che all’animo irlandese-americano apparivano intrisi di cattolicesimo per osmosi geografica rispetto al Santo Padre. Non chiedevamo a quella casa nient’altro che l’orgoglio di esserle legati; e questo fu un bene per noi, giacché la nonna, che in fatto di ospitalità era grande sostenitrice del principio «se gli dai un dito, quelli si prendono il braccio», non offrì mai, per quanto ricordo, il minimo rinfresco a nessun visitatore, giudicando abbastanza salutare e nutriente la sua conversazione. Vecchia, brutta e arcigna, con un mostruoso seno a davanzale, officiava, come un prete che intona la messa, con voce inespressiva e cantilenante, una ben determinata serie di argomenti, a cui la ripetizione aveva conferito una solennità senza senso. Gli argomenti erano questi: l’udienza concessale dal Santo Padre; il fatto che papà avesse violato la tradizione familiare votando per i democratici; un pellegrinaggio a Lourdes; la Scala Santa, a Roma, macchiata di sangue dal primo Venerdì Santo, che lei aveva salito in ginocchio; i miei mignoli arcuati, che testimoniavano quanto fossi bugiarda; un osso miracoloso; l’importanza del funzionamento regolare dell’intestino; la malvagità dei protestanti; la conversione di mia madre al cattolicesimo e, infine, l’asserzione che la mia nonna materna si tingeva senza dubbio i capelli. I ricordi più banali (come l’episodio della zia che aveva avuto un attacco isterico sopra un covone di fieno) traevano dal tono della sua esposizione e dalla religiosità del contesto un forte sapore di ammonimento: ispiravano paura e senso di colpa, cosicché gli ascoltatori vi cercavano per forza una morale, come in una fiaba oscura e intricata.
Per fortuna, sto scrivendo delle memorie e non un’opera di fantasia; non sono dunque tenuta a descrivere la sgradevole personalità di mia nonna e a individuare il complesso edipico o l’esperienza traumatica in grado di conferirle quell’autenticità clinica che attualmente è così richiesta nel ritratto di un personaggio. Non so come avesse fatto la nonna a diventare quella che era; presumo, dalle fotografie di famiglia e dall’inflessibilità delle sue abitudini, che fosse così da sempre, e mi sembra inutile indagare nella sua infanzia, così come sarebbe inutile chiedersi di che malattia soffrisse Jago o cercare l’errore educativo responsabile della personalità di Lady Macbeth. La storia sessuale della nonna, irta di mortalità infantili com’era tipico di quel periodo, fu robusta e decisiva: le crebbero tre figli alti e aitanti e una figlia devota e sollecita. Il marito la trattava sempre con gentilezza. Aveva denaro, molti nipoti e una religione a sostenerla. I capelli bianchi, gli occhiali, la pelle morbida, le rughe, i lavori di ricamo: gli attributi da figura materna li aveva tutti; eppure era una vecchia fredda, polemica e piena di rancori, che passava tutto il giorno seduta in soggiorno a ricamare motivi copiati dai modelli, a scorrere periodici religiosi e a serrare la mascella d’acciaio contro qualsiasi infrazione alle sue regole.
Il tratto dominante della sua natura era, a mio avviso, la combattività. Benché frequentasse aggressivamente la chiesa, era del tutto priva di sentimenti cristiani; la misericordia del Signore Gesù non le era mai entrata nel cuore. La sua devozione era un atto di guerra contro i parenti protestanti. Le riviste religiose sparse sul tavolo non le fornivano materiale per la meditazione, ma sempre nuovi pretesti per la collera; la sua lettura preferita erano gli articoli che attaccavano il controllo delle nascite, il divorzio, i matrimoni misti, Darwin e l’istruzione laica. Gli insegnamenti della Chiesa non le interessavano, a meno che non suonassero come rimproveri agli altri: «Onora il padre e la madre», il comandamento che non era più chiamata a rispettare, era quello che più spesso le veniva alle labbra. La grazia che invocava non era la perfezione spirituale, ma lo sterminio del protestantesimo. La sua mente era ossessionata dalla volontà di convertire: la conquista di un’anima a Dio era l’occupazione preferita della sua fantasia: un protestante di meno al mondo! Le missioni all’estero, con i loro propositi di buona volontà e di servizio sociale, l’attraevano meno; non era certo un raccolto di anime quello che mia nonna aveva in mente.
Questa combattività non si limitava all’entusiasmo settario. C’era anche la difesa dei mobili e della casa dalle immaginarie invasioni dei visitatori. Il suo non era il senso di conservazione gentile e tremante diffuso fra le vecchie signore, che temono il danneggiamento delle loro proprietà con un’ansia davvero commovente, perché deducono la fragilità di ogni cosa da quella delle loro vecchie ossa e avvertono lo schianto della mortalità nel pericoloso tintinnio di una tazza da tè. L’atteggiamento interiore della nonna era più autocratico: detestava che ci si sedesse sulle sue sedie e si camminasse sui suoi prati o si facesse scendere l’acqua nei suoi lavabi, senz’altro motivo che la pura invadenza del gesto; portava rancore perfino al postino che ogni giorno percorreva il vialetto d’ingresso. La sua casa era un centro di potere, e non permetteva che venisse sminuita da un uso confidenziale e democratico. Sotto il suo occhio geloso le qualità sociali della casa si erano atrofizzate; nella struttura familiare fungeva solo da quartier generale politico. Vi si tenevano le riunioni di famiglia, le consultazioni con i medici e i sacerdoti; vi venivano condotti i bambini ribelli per una predica o per una pausa di meditazione; vi si leggevano i testamenti, vi si negoziavano prestiti e vi si ricevevano, nelle occasioni ufficiali, gli emissari del partito protestante. La nostra famiglia non aveva amici, e ricevere ospiti veniva considerata una manifestazione di cortesia sciocca e superflua, così come lo era fra consanguinei. Nei giorni di festa, i pranzi ricadevano come un dovere sui membri meno importanti dell’organizzazione: le figlie e le nuore (che avevano abiurato la falsa religione) servivano la meringa ripiena di gelato su un vassoio, come fosse la testa di san Giovanni Battista, mentre i vecchi troneggiavano intorno alla tavola, e solo i loro processi digestivi salutavano, con rumorosi ed enigmatici gorgoglii, la festività in questione.
In un’unica terribile circostanza, tuttavia, la nonna aveva aperto la sua casa. Durante le fatali settimane dell’epidemia d’influenza, quando non si trovavano letti in ospedale e la gente circolava con la mascherina o se ne stava chiusa in casa, e il terrore del contagio paralizzava tutti i servizi e faceva di ogni uomo il nemico del suo vicino, lei ci aveva accolti tutti. A uno a uno fummo fatti scendere dal treno che ci aveva portati dal lontano Puget Sound a crearci una nuova casa a Minneapolis. Quando avevamo salutato gli amici alla stazione di Seattle, non sapevamo di portare con noi l’influenza, nei nostri scompartimenti, insieme con i doni e i mazzi di fiori; ma uno dopo l’altro, a mano a mano che il convoglio procedeva verso est, eravamo stati colpiti dal morbo. Noi bambini non capivamo se il nostro battere i denti e il torpido giacere della mamma nella sua cuccetta rientrassero o meno nelle necessità del viaggio (fino ad allora il pesante malessere fisico, nella nostra mente, era stato associato all’avvento di qualche novità: aveva sempre preceduto l’arrivo in casa di un nuovo bambino), e cominciammo ad avere la certezza che quella fosse tutta un’avventura quando vedemmo nostro padre puntare una rivoltella contro il capotreno che pretendeva di farci scendere a una stazioncina di legno nel cuore della prateria del Nord Dakota. Sulla banchina di Minneapolis c’erano ad aspettarci delle barelle, una sedia a rotelle, facchini, funzionari agitati e più in là, in mezzo alla folla, la faccia rosea del nonno – col suo sigaro e il suo bastone – e il cappello piumato della nonna, che conferivano una nota festosa a quel quadro strano e confuso e diedero a noi bambini la certezza che la nostra malattia fosse l’inizio di una deliziosa vacanza.
Ci destammo qualche settimana dopo nella «stanza del cucito», in un’atmosfera fatta di olio di ricino, termometri rettali, infermiere contrariate e generale efficienza, e sebbene fossimo stati tenuti all’oscuro di quanto era accaduto così vicino a noi, appena fuori dalla portata delle nostre orecchie – uno scandalo della specie più grave, un andirivieni di sacerdoti e impresari di pompe funebri e casse da morto (ci era stato detto che mamma e papà erano andati a guarire in ospedale) – quando ci ridestammo dalla lunga febbre ci rendemmo conto che tutto, noi compresi, era cambiato. Ci eravamo, per così dire, ritirati e scoloriti, come i pigiamini di flanella che indossavamo e che in quelle poche settimane erano diventati, senza dubbio per effetto del disinfettante nel quale venivano lavati, miseramente logori e malridotti. Il comportamento delle persone che ci circondavano, brusco, sbrigativo e distratto, ci fece comprendere senza tante cerimonie che la nostra importanza era diminuita. Il nostro valore si era ridotto, e una nuova immagine di noi stessi – l’immagine, se l’avessimo potuta concepire, dell’orfano – ci si andava già formando in mente. Non avevamo mai saputo di essere dei bambini viziati, ma ora questa parola, che per la prima volta entrava nel nostro vocabolario, serviva a definire il cambiamento avvenuto e ad annunciare l’avvento del nuovo ordine. Prima di ammalarci eravamo viziati: ecco qual era il problema, adesso, e tutto ciò che non riuscivamo a capire, tutto ciò che ci appariva inconsueto e sgradevole, acquistava una certa plausibilità se messo in rapporto con questo nuovo concetto. Non ci eravamo mai resi conto di che cosa significasse vederci buttare i vassoi sul letto sbrigativamente, non avere zucchero né crema sui fiocchi di avena, bere la medicina in un sorso solo perché nessuno poteva prendersi il disturbo di aspettare i nostri comodi, sentirci infilare bruscamente le braccia nelle maniche dei vestiti e passare altrettanto bruscamente il pettine nei capelli, avere qualcuno che ci faceva fare il bagno con impazienza, ricevere l’ordine di alzarci a sedere o tornare a stenderci immediatamente (e niente capricci!), vedere le nostre domande rimanere senza risposta, le nostre richieste non esaudite, e starcene per ore e ore stesi a letto, da soli, in attesa della visita del medico; ma tutto questo era dovuto, così pareva, alla trascuratezza con cui eravamo stati educati, e la nonna e la sua servitù si dedicavano ostinatamente a rimediare a tale difetto.
Le loro intenzioni erano senza dubbio ottime; effettivamente, era ora che imparassimo che il mondo non era più ai nostri piedi. La vita felice che avevamo vissuto – i cestelli di maggio, i regalini, i picnic nel cortile e l’elaboratissimo pupazzo di neve – era stata, a dire il vero, una preparazione del tutto inadatta al futuro che ora ci si apriva dinanzi. Nei nuovi educatori non si poteva biasimare una certa insofferenza verso i nostri genitori, che erano stati così poco previdenti. Era, decisamente, nell’interesse di tutti che noi dimenticassimo il passato – prima ci riuscivamo, meglio era – e una costante deplorazione delle nostre antiche abitudini («Tè e cioccolata, figuriamoci, e tutte quelle torte glassate! Non c’è da meravigliarsi che la povera Tess fosse sempre alla caccia di un medico!») e le lodi che stabilivano sempre un severo confronto col passato («Non avete idea di quanto siano migliorati questi bambini!») lusingavano l’amor proprio di chi parlava e preparavano noi ad accettare una perdita che era, in ogni caso, irreparabile. Come tutti i bambini eravamo desiderosi di conformarci, e sapere che il nostro comportamento di prima era stato per qualche motivo ridicolo e sconveniente ne rendeva più instabile il ricordo, come una poesia recitata alla presenza di estranei. Non chiedevamo più ciò che ci era dovuto, e il desiderio di rivedere i nostri genitori si andava insensibilmente attenuando. Ben presto cessammo di parlarne e così, senza lacrime o capricci, arrivammo a capire che erano morti.
Perché mai nessuno – tantomeno la nonna, al cui repertorio l’argomento sarebbe stato così congeniale – si sia preso il disturbo di dircelo, è ormai impossibile saperlo. Non è difficile immaginare la nonna che comunica la notizia, almeno a quelli tra noi che erano abbastanza grandi per intenderla, durante uno di quei colloqui ufficiali in cui la sua natura pareva periodicamente tumefarsi, diventare pesante e turgida come il suo seno imponente, come le peonie, il suo fiore preferito, o come il manichino della sarta, enfatica immagine di lei, che, semiavvolta in un lenzuolo per pudore, conferiva una solennità da museo alla «stanza del cucito» e stimolava le nostre prime curiosità sessuali. All’orecchio della fantasia sembra di sentire le sue frasi, ma in realtà la nonna non parlò: difficile dire se per ragioni igieniche (tenere sempre la mente sgombra e l’intestino pulito) oppure per una malintesa bontà d’animo. Forse aveva davvero paura delle nostre lacrime, che sarebbero potute piovere su di lei come rimproveri, poiché a quel tempo la strategia familiare si reggeva sull’assioma della nostra virtuale insensibilità: preconcetto che permetteva ai parenti di comportarsi con noi come fossimo stati dei mobili. Senza spiegazioni né moine, non appena poterono alzarsi dal letto senza rischi, i miei tre fratelli furono spediti nell’altra casa; erano troppo piccoli per «capire», udii bisbigliare dagli adulti, e non si sarebbero neppure accorti del cambiamento, «se Myers e Margaret fossero stati attenti». Nel mio caso, invece, probabilmente si fecero venire qualche dubbio. Avevo sei anni: ero dunque abbastanza grande per «ricordare», e questo mi dava diritto, agli occhi della famiglia, a maggiori riguardi, quasi che la mia memoria fosse un avvocato difensore che mi rappresentava in tribunale. Per rispetto, dunque, alla mia età e alle mie presunte capacità di critica e di confronto, mi fecero restare ancora un po’ in casa dei nonni, a vagare pallida per le stanze della nonna: creatura sospesa, in transizione, come un girino in procinto di trasformarsi in rana, mentre i miei fratelli, poveri polipetti, erano già bene inseriti nella struttura della nostra nuova esistenza. Io non mi chiedevo cosa ne fosse stato di loro. Pensavo, probabilmente, che fossero morti, ma non ero particolarmente preoccupata del loro destino: il mio cuore si era fatto insensibile. Mi consideravo intelligente per avere intuito da sola la verità sul conto dei miei genitori, così come un bimbo è orgoglioso di aver scoperto che Babbo Natale non esiste; però di questa mia consapevolezza non parlavo, e nemmeno vi reagivo interiormente, perché non volevo averci nulla a che fare; non avevo intenzione di collaborare al lutto. Quelle settimane in casa della nonna ritornano oscure alla mia memoria, bordate di nero come una partecipazione funebre: la buia tromba delle scale, dove mi pare di aver ciondolato in eterno, in attesa di vedere la mamma di ritorno dall’ospedale, e poi di aver ciondolato e basta, senza più alcuno scopo; l’aula della prima classe della scuola sconosciuta a cui mi avevano iscritta, illuminata dalla luce fioca dell’inverno; la squallida stanza delle terapie, nello studio del medico, dove ogni sabato urlavo e supplicavo su un lettino mentre mi somministravano scosse elettriche, non so immaginare a che scopo. Ma non mi si poteva concedere in eterno questo trattamento preferenziale; era tempo che anch’io trovassi il mio posto. «È venuto qualcuno a trovarti»: un pomeriggio la cameriera si presentò con questo annuncio, e un sorriso per metà curioso e per metà saccente. Ebbi un tuffo al cuore; mi veniva quasi da vomitare (chi altro poteva essere, dopotutto?), e la domestica dovette darmi una spinta per farmi muovere. Ma l’uomo e la donna che mi esaminarono nel soggiorno, insieme alla nonna, erano due estranei, persone di mezza età dall’aria antipatica – una prozia e suo marito, a quanto mi sembrò di capire – a cui mi venne ordinato di dare la mano e di sorridere, perché, come spiegò la nonna, Myers e Margaret erano venuti a prendermi per portarmi, quello stesso pomeriggio, a vivere da loro, e non dovevo fare cattiva impressione.
Quando la nuova famiglia entrò in funzione, la morte dei nostri genitori fu ufficialmente riconosciuta e al sentimento venne lasciato lo spazio dovuto. ...