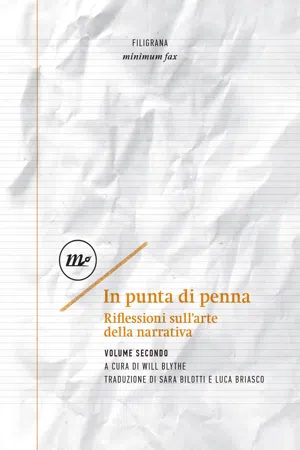1
LA MIA VERSIONE:
Ho sempre odiato le lezioni di nuoto. Eravamo a Weed Beach (Darien, Connecticut), nel canale di Long Island. Nei miei ricordi, Weed Beach è oleosa, sovraffollata, accerchiata simbolicamente dalla sua prossimità con la baia di New York e dalle masse provenienti da Rowayton e Darien che cercavano rifugio proprio lì. Avevo preso dal padre di mamma, F.M. Flynn – editore del New York Daily News – per alcuni aspetti: il mancinismo, i capelli rossi, la tendenza a scottarmi al sole. Perciò, in spiaggia, ero sempre cosparso di vari solventi per evitare di ustionarmi, e mi scottavo lo stesso, per poi spellarmi. Mio fratello mi aveva soprannominato «Fabbrica della colla».
Ma la parte peggiore di quelle giornate in spiaggia erano le lezioni di nuoto. Mia sorella e mio fratello, rispettivamente più grande e più piccolo di me, erano abili nuotatori e trascorrevano ore intere nella calma piatta del canale, tuffandosi e pagaiando. Ma io ero diverso. Durante la mia penultima lezione (o così la ricostruisco a distanza di anni), fui affidato a un ragazzo in vacanza, membro di una squadra di nuoto di un collegio o di un’università della Ivy League, e venne deciso che era arrivata l’ora di imparare a stare a galla. Io però ero abbastanza intelligente da sapere che i sassi affondano, che ci sono navi incagliate nelle buie profondità dei sette mari, che solo la negromanzia o il possesso di poteri soprannaturali possono consentire a una persona di attraversare la superficie delle acque. Inoltre, la basilare fiducia umana necessaria per questa come per altre operazioni acquatiche era, a mio giudizio, malriposta.
Ciononostante, l’istruttore biondo mi persuase a distendermi tra le sue braccia, come se fossi un’offerta a Poseidone, e poi, facendo appello a una sua segreta saggezza, cominciò a togliere le grandi mani, un centimetro dopo l’altro, dichiarando che se avessi trattenuto il fiato sarei riuscito a galleggiare tra quelle onde pigre. Avrei ondeggiato anch’io.
Tutto questo era ridicolo. Ed era totalmente contraddetto dalle mie personali indagini sulla fisica degli ambienti suburbani, sulla fisica delle palle da tennis, dei mucchi di foglie e dei cani da riporto più abili e aggressivi, per fare solo qualche esempio, quindi cominciai a gridare, attaccandomi all’istruttore come un naufrago del Titanic, benché l’acqua mi arrivasse sì e no alla vita. Tornai al mio asciugamano e non provai più a nuotare per cinque anni abbondanti, chiunque fosse a chiedermelo.
Prima di compiere dieci anni, mi ammalavo spesso. Non ricordo molto di quel periodo, tranne la sensazione di avere un’infezione a entrambe le orecchie in contemporanea (non è facile scordarsi una cosa simile) e di aver passato il weekend di Pasqua a letto, dopo una tonsillectomia.
In generale, non sapevo comportarmi bene con gli estranei. Evitavo gli eventi sociali. I miei genitori studiavano degli esercizi allo scopo di temprarmi. Per esempio, mia madre mi mandò a una lavanderia in città per ritirare le camicie di mio padre. Le implicazioni simboliche sono particolarmente ricche: responsabile dell’uniforme che scandiva l’impresa capitalista di Papà. Senza contare che ho sempre amato l’odore chimico dei prodotti da lavanderia. Come pure la naftalina negli enormi armadi di mia nonna (si era già confinata in camera sua quando fui abbastanza grande per fare la sua conoscenza), sistemati negli antichi corridoi dove erano conservate le sue cose, nella casa che divideva con mio nonno. Comunque, entrai nella lavanderia, e mi trovai davanti una foresta di abiti sigillati: uno spettacolo dal quale ho sempre tratto ispirazione. Mi sentivo pieno di speranze finché non vidi il gestore in persona – un uomo anziano, con la tipica uniforme ovviamente inamidata dei primi anni Sessanta – circondato da una folla di donne ricche dai modi sbrigativi, che chiedevano un risarcimento per macchie che non erano venute via, o vestiti mal stirati.
Ero paralizzato, incapace di procedere alla mia importantissima missione. Immagino che il mio problema specifico avesse a che fare con la necessità di rendere note le mie esigenze a questo proprietario dall’aria benevola, vale a dire, assicurarmi che le camicie di mio padre fossero inamidate al punto giusto, porgergli i miei dieci dollari, farmi dare il resto. Ma circondato da tutte quelle casalinghe schiamazzanti, per me era impossibile farlo. Scivolai fuori fino alla macchina, mi inventai la prima scusa che mi venne in mente e fui sgridato da mia madre e costretto a rientrare nel negozio, in lacrime, insieme a lei, attendere in piedi, con pazienza, che il processo di scambio (valuta corrente in cambio delle camicie, piegate e avvolte in carta da pacchi marrone) avesse luogo, scandito da una serie di galanterie al limite del virtuosismo, delle quali non sarei mai stato capace. Visto quanto è facile?
(Questa fobia è riapparsa poco dopo i miei vent’anni, quando, a Hoboken, l’unica lavanderia nei dintorni di casa era tutto un susseguirsi di battute scherzose, con un sottofondo adulatorio. Supplicavo la mia ragazza di allora perché andasse lei al mio posto, ero assolutamente intrattabile, e in questo modo precipitai nuovamente in una delle mie tante ansie da romanziere: la paura delle lavanderie.)
Nel frattempo, divoravo le opere di F.W. Dixon. The Hardy Boys and the Sunken Treasure, ecc. Mi piaceva anche Encyclopedia Brown, che, come i suoi coetanei, gli Hardy, trascorreva i giorni della pubertà risolvendo i misteri del suo quartiere. Non riuscivo mai a scoprire il colpevole in quei gialli, e in realtà non mi fregava un fico secco di chi fosse, ma ammiravo l’inventiva dietro i crimini. Ovviamente avrei voluto essere Encyclopedia Brown, ma in realtà a scuola andavo maluccio. Presi uno zero spaccato nel compito di storia, in quarta elementare, e Miss Rydell, la maestra, mi fece capire che quel voto lo aveva usato solo per me, vista la qualità infima del mio elaborato. Le mie ambizioni scolastiche consistevano perlopiù nell’evitare l’ira dei miei insegnanti, e di conseguenza quella dei miei genitori. Miss Rydell però veniva dal Texas, e le sue esplosioni di rabbia (che aveva già riservato a mia sorella prima di me) raggiungevano temperature da fusione nucleare.
Amavo la televisione. Guardavo tutto il giorno le repliche di vecchie commedie, ed ero anche particolarmente attratto dagli sceneggiati di fantascienza più anemici, come Lost in Space e Star Trek. Ero occupato a guardare la televisione anche mentre i miei genitori divorziavano. Non ricordo nulla della loro separazione – tranne il triste spettacolo della porta del soggiorno chiusa, una sera, e uno scambio di battute particolarmente velenose sulla barca a vela di mio padre – e immagino che il motivo stia nella sua ridondanza (che io ricordassi, i miei genitori non si erano mai abbracciati davanti a me). Inoltre, non seppi mai nulla della divisione delle loro proprietà, e delle procedure legali messicane, perché ero preoccupato dalla novità ben più traumatica che sarebbe derivata da quest’evento calamitoso: ci saremmo dovuti trasferire.
Era una notizia straziante non solo perché l’idea di entrare in un’aula scolastica piena di estranei mi dava la nausea, ma anche perché avevo appena cominciato a fare coppia fissa con Susan Ward. A dimostrazione di ciò, avevo baciato la manica del suo giubbetto di jeans, e la sua consistenza piena di macchie e muffa si era registrata per l’eternità sulla pergamena delle mie eterne infatuazioni. Giocavamo ai quattro cantoni insieme. Ci scambiavamo parole goffe e frettolose all’ombra delle querce. Alla fine, come un innamorato tubercolotico del diciannovesimo secolo, le rivelai che tra breve sarei andato via da Darien per non farvi più ritorno, convinto così di rendere immortale il nostro legame. In realtà, Susan non si scompose più di tanto. Nel mio immenso dolore, fui lieto di scoprire che James Taylor aveva scritto la sua cupa «Fire and Rain» proprio per lei: Suzanne, che le piante possano darti fine. Non capivo cosa significasse questo enigma botanico ed escatologico, ovviamente, e il nome dell’amata di James Taylor era solo un’approssimazione di quello della mia angelica Susan Ward, eppure tanto mi bastò per convincermi che la mia perdita e la mia dislocazione fossero grandi come la hit parade di Billboard.
Fui iscritto a una nuova scuola. E poi, l’anno successivo, a un’altra. E ci trasferimmo. Ci trasferimmo di nuovo. E ancora. E ancora. Alla fine di quella lunga sequela di indirizzi suburbani, quando ormai le file di furgoni della Allied Vane e i loro scatoloni di cartone erano diventati parte della routine, ero così disorientato che programmavo i miei rapporti basandomi sull’ineluttabilità di un nuovo addio. In terza media, all’infernale Saxe di New Canaan, un caposaldo di repressione sociale e conformismo, arrivai addirittura a tenere un calendario nel quale contavo i giorni che mi separavano da un nuovo trasloco. Cominciavo da cento, barrando le giornate fino ad arrivare a zero.
Smisi di provare a parlare con le persone. Smisi di tentare di spiegare, nei miei discorsi, quale fosse stato il momento in cui la mia malinconia di bambino – che fosse congenita o figlia di specifiche situazioni – aveva preso forma, fino a diventare una bolla impenetrabile. Immagino che tutto questo indichi una sorta di predestinazione nella scelta tra il flusso verbale e la scrittura, tra la parole e la langue. Avevo diverse fobie. Le conversazioni mi terrorizzavano. Le consideravo alla stregua di luoghi in cui ognuno poteva affondare il suo coltellino tascabile. Mi fidavo di ben poca gente. Tenevo la bocca chiusa. E mi esercitavo nella scrittura, che mi assicurava tempi languidi e insolitamente pigri, rilassamento e torpore, silenzi meditativi, immobilità e musica – come la musica di mia madre, nella nostra casa quasi sempre deserta in Valley Road, a New Canaan, quando si lanciava nel triste movimento di apertura della Sonata al chiaro di luna, seduta davanti a un vecchio pianoforte verticale.
Una delle ultime cose che la mia famiglia fece insieme fu andare a vedere 2001: Odissea nello spazio. Dev’essere accaduto al cinema di Darien (come l’avevano presa, gli altri spettatori?). A otto anni, quel film era così al di là della mia comprensione, così disturbante, così barocco nella sua esposizione di idee complesse, che creò quasi da solo in me l’ambizione di utilizzare la mia immaginazione: la lotta di HAL contro gli astronauti, i tizi con i mutandoni da uomini di Cro-Magnon che giocano con i femori di qualche animale, il satellite lunare della Pan Am. Sulla via di casa tormentai i miei genitori con un mucchio di domande: Se l’universo ha un confine, cosa c’è oltre quel confine? Se c’è stato un momento in cui l’universo è stato creato, cosa c’era prima di quel momento? Gli altri ragazzini nella contea di Fairfield avevano la Chiesa presbiteriana, o la Chiesa della Pop Warner Football League, ma io ero stato battezzato alla fonte torbida dell’immaginazione, e sono grato di questo. Una volta completati i miei primi esperimenti con il film di Kubrick, l’Odissea, Alice nel paese delle meraviglie, era ovvio che non avrei mai frequentato giurisprudenza. Ed ecco un estratto autentico dei miei sforzi giovanili, in un quaderno a righe Banana Flair, datato ottobre 1971 o giù di lì: «Penso davvero spesso ai dinosauri. Ne conosco milioni di specie diverse. Alcuni alti più di quindici metri. E mi chiedo se sono io la macchina più grande sulla terra, una macchina di curiosità che non si esauriscono mai» (corsivo in originale).
Terrorizzato dagli estranei, terrorizzato dai telefoni, terrorizzato dagli estranei al telefono, a disagio sugli aerei, in mezzo alla folla, terrorizzato all’idea di dover parlare in pubblico, terrorizzato dagli spazi aperti, da quelli chiusi, dalle donne, dalla luce del sole, dall’altitudine, dalla gente, e così via. Terrorizzato.
Sono diventato uno scrittore, quindi, perché ero troppo timido per raccontare le mie storie davanti a un pubblico, perché la vertiginosa libertà dell’immaginazione (filtrata dal linguaggio) era molto più praticabile in solitudine, lontano dalle tempeste e dalle sbruffonate dei compagni di scuola. Mi sono chiesto più volte perché fossi fatto così, quando per molti altri l’esatto contrario sembrava la norma, ed è stato su questo interrogativo che, inizialmente, ho concentrato le mie energie, perché capita spesso che la scrittura si focalizzi su questioni innominabili (il termine è di Donald Barthelme), cose che, all’interno del campo da baseball della vita quotidiana, non possono essere veramente dette, o vengono ignorate per il genere di responsabilità che comportano, proprio come la semplice frase Ti voglio bene è difficilissima da pronunciare (e per esempio non l’ho mai rivolta quanto avrei dovuto alla persona che sta scrivendo sulla colonna accanto alla mia), finché il processo che consiste nel prendere in considerazione certi interrogativi diviene sufficiente a se stesso e ben distinto dalla trappola delle risposte – e si lascia dietro, grazie alla semplice musica delle domande, in medias res, come dice Montaigne, «una certa idea delle mie abitudini e delle mie opinioni».
2
LA VERSIONE DI MIA MADRE:
Trentacinque anni dopo i fatti, il periodo in cui hai cominciato a parlare mi sembra un vortice confuso nel quale ridipingevamo case e le vendevamo, sono rimasta incinta di tuo fratello, i tuoi nonni paterni si sono trasferiti da Boston e tuo padre si è beccato la mononucleosi. Cercare di essere una «brava» moglie e madre di tre figli a ventisei anni, una brava sorella, una brava figlia (e nuora), era decisamente faticoso.
Una prima parola possibile che mi viene in mente è no: quando avevi diciannove mesi e io mettevo a bollire ogni giorno la biancheria di tutti quanti (Dwight aveva contratto un’infezione da staffilococco, perciò dovevamo usare un sapone speciale OGNI giorno e fare l’impossibile per evitare ulteriori infezioni... il tutto con un unico bagno in casa), l’imposizione di una routine rigorosa era una fonte costante di stress. Durante quel periodo ti prendesti la prima di una lunga serie di faringiti, e verso le due del mattino avevi la febbre a 40. Il dottore mi suggerì di farti delle spugnature con l’alcol, visto che vomitavi anche l’aspirina liquida. Non mi sono mai sentita più simile a una torturatrice, mentre tu piangevi disperato e gridavi «basta, basta!»
È stato chiaro quasi subito che i libri esercitavano un’enorme attrattiva su di te, e io mi sedevo con Meredith da una parte e te dall’altra, e il più delle volte vi leggevo un passo da un’antologia di filastrocche e di fiabe (posso mostrartela, se vuoi). Tua sorella si stufava dopo un quarto d’ora, ma tu restavi seduto ad ascoltare finché avevo il tempo di proseguire.
A un certo punto, durante l’asilo, ti divertisti a fingere di essere un altro bambino, con un nome diverso (il nome non lo ricordo). In questo periodo (e per diversi anni) obbedivi a Meredith quasi su tutto. Quando tua sorella passava le giornate a scuola ero felice, perché ti dava modo di essere libero per qualche ora dalla sua presenza autoritaria.
Poiché abitavamo molto vicini al canale di Long Island, l’estate andavamo spesso in spiaggia. Crescendo, giocavi sul bagnasciuga ma non avevi alcun interesse a immergerti o a imparare a nuotare. Eri molto magro e diventavi blu dal freddo... Che gusto c’era a importelo? In seguito, però, quando andare in barca divenne un’abitudine, io e tuo padre decidemmo di comune accordo che era assolutamente vitale che tu imparassi a nuotare. Avevo la sensazione che fossi tu il primo a volerlo, ma che la paura rappresentasse un ostacolo troppo grande; dopo la morte di tuo zio Jack andammo tutti a Fort Lauderdale con mio padre, a febbraio, per una vacanza di dieci giorni... Avevi quattro anni e mezzo; forse ricordi il volo, su un jet privato. Credo che tuo padre fosse mortificato all’idea che l’acqua ti facesse così paura. Perfino tuo nonno non riusciva a trattenerti in piscina per più di cinque minuti.
Quando avevi cinque anni e ci trasferimmo in Ironwood Lane, conoscemmo dei vicini di casa con una figlia che dava lezioni di nuoto. Iscrivemmo sia te che Dwight, per due ore la settimana. Fu un’estate piuttosto fredda, con diverse giornate di pioggia. Le lezioni non si svolgevano con costanza (e a dirla tutta, non credo che quella ragazza fosse granché, come istruttrice). Dwight fece comunque molti progressi, ma la ragazza ci disse che non riusciva in nessun modo ad aggirare il senso di panico dal quale eri colto ogni volta che ti chiedeva di restare a galla senza tavola. Quando ne parlammo con te protestasti nel modo tipico dei bambini, guardando nel vuoto e battendo i piedi...
Era tutto molto triste, ma tuo padre non ti permise di mollare finché, un giorno, non venimmo insieme ad assistere a una delle tue lezioni. Entrasti in acqua, facesti qualche vago tentativo di seguire le istruzioni, poi avesti una vera e propria crisi isterica. Credo di essere stata io a tirarti fuori dall’acqua e ad avvolgerti in un asciugamano, dopodiché dichiarammo che la lezione era finita, e tuo padre disse che non saresti più tornato. Me lo ricordo di umore nero, in macchina, sulla via di casa, che diceva: «Che spreco di soldi!»
Sembrava anche che tu prendessi al volo ogni tipo di germe, e gradualmente divenne sempre più chiaro che le...