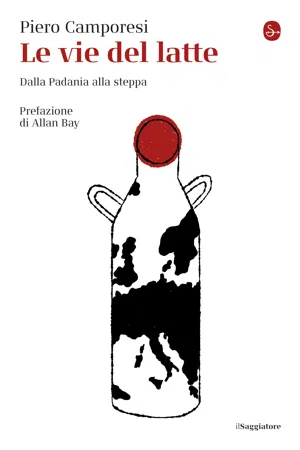![]()
Il padano Petrarca
Lasciata Mantova in un tardo pomeriggio di giugno, costeggiando il Po gonfio per le nevi che sulle Alpi stavano sciogliendosi sotto il soffio di venti sciroccali all’inizio difficile di una estate umida e ritardata, dopo aver faticosamente galoppato per piste fangose assediate da un mare di melma («omnia circum limo obsita», Fam., ix, 10), finalmente, al cader della notte, Francesco Petrarca riuscì ad arrivare a Luzzara dove avrebbe sostato per proseguire il giorno dopo, diretto a Parma e a Selvapiana. A Luzzara, in una signorile dimora, lo attendeva una sontuosa cena. Aveva scelto a malincuore il cavallo perché la navigazione su canali e fiumi lombardi, da lui sempre preferita («sieno rese grazie ai nostri fiumi, il Po ed il Ticino» scriverà nel 1368 a Giovanni da Mandello «e a quel canale che è stato con ingente fatica di manuale opera scavato»), era divenuta impossibile in quei giorni di piena.
Tutto, in quell’umida serata del 1350, fu gradevole: la cena splendida («apparata opipare cena»), le vivande ricercate («peregrine epule»), i vini scelti che venivano da lontano («externa vina»), ossequiosi e premurosi gli anfitrioni che erano stati preavvertiti dai Gonzaga, simpatiche e allegre le facce dei commensali («leti vultus»). Ogni cosa fu perfetta tranne il luogo dove si svolgeva la cena, del quale (osservava Petrarca) si poteva avere un’idea quale fosse d’inverno vedendo quello che vi succedeva in estate. Quel palazzo era una vera e propria casa delle mosche e delle zanzare («muscarum domus et culicum»). Il minaccioso, sibilante ronzio di quest’ultime preavvertì tutti che non era il caso di ritardare ancora il levarsi da tavola («quorum murmur admonuit maturius e convivio fugiendum»). Le sorprese spiacevoli non erano però terminate: all’imminente pericolo delle zanzare si era aggiunta la sgradevole invasione di rane che, sbucate in massa dai sotterranei e dalle cantine, si affollavano, come in un brulicante mercato, saltando e gracidando sul pavimento della sala («inter cenam e caveis ingressas et per cenaculum nundinantes cerneres»).
Mantova, la città da cui Petrarca era partito, il dantesco «loco ch’era forte / per lo pantan ch’avea da tutte parti», posto in mezzo a una «lama / ne la qual si distende e la ’mpaluda», non era propriamente un paradiso climatico; ma anche a Luzzara stava sopraggiungendo l’estate greve della bassa, stagione contraria alla sua complessione tanto calda da dover ricorrere a generosi salassi ogni primavera e ogni autunno e incompatibile col suo temperamento umorale («nature mee infesta estas»). Le insopportabili zanzare di Luzzara insieme all’invasione dei batraci lo fecero fuggire frettolosamente nella camera da letto. Nonostante i disagi del clima, le estati soffocanti e gli inverni glaciali (rigidissimo fu quello del 1358-59, quando si scatenò un «tempus intractabile sine exemplo… nunquam enim in memoria hominum inter Alpes et Appenninum tanta vis nivium incubuit… nichil algentius, nichil hiementius videbatur»), il dafneo e solare poeta, dopo aver abbandonato per sempre Valchiusa e il Midi gallo-provenzale, evitò l’antica paterna Etruria, non lasciando più le terre padane. Le stagioni lombarde lo videro salire e scendere da cavallo, imbarcarsi su chiatte e barconi, respirare l’immobile nebbia autunnale, scuotersi dalla pelliccia il ghiaccio, la neve, la galaverna, inzupparsi di sudore nei torpidi giorni canicolari. Lo tormentava spesso un dolore alla tibia sinistra, postumo d’una rovinosa caduta da cavallo, una vecchia ferita solita a riacutizzarsi, una piaga inciprignita dal cavalcare. Ma in barca o a cavallo, questo coriaceo oratore-poeta innamorato dell’Italia, delle sue genti e ancor più della bellezza del suo paesaggio che non finiva mai di riempirlo d’ammirazione («italice telluris aspectu satiari nequeo» confessava nel 1362 al suo grande amico Giovanni Boccaccio in una lettera senile, i, 5), era infaticabile nel percorrere le fertili pianure («ditia rura») bagnate dal grande maestoso fiume «Rex padus ingenti spumans intersecat amne». Inafferrabile e irrequieto, curava le sue ansie con la medicina del viaggio («locorum mutatione»), rompendo la monotonia sedentaria con la varietà del movimento («quotiens identitas, taedii mater, offenderit, aderit optima fastidii medicina varietas»). Dissipava così la malinconia e l’acedia che tanto frequentemente lo possedevano: «unde omnis tristitia quam longissime relegata est». Poteva viaggiare in lungo e in largo l’Italia e l’Europa senza problemi economici: chierico illustre, letterato squisito, signore della penna, maestro dell’oratoria, diplomatico e ambasciatore di sommo prestigio presso principi, papi, imperatori, poteva anche disporre delle rendite sostanziose di quattro benefici ecclesiastici. Anche quando fu avanti negli anni, il vecchio «scolasticus» innamorato dei recessi ombrosi e delle selve («silvicola») continuò la sua padana errance di vagabondo solitario («solivagus»), sempre di passaggio, «peregrinus ubique», da Verona a Pavia, dal Ticino all’Adige. Era entrato in quasi tutte le città grandi e piccole del Nord e in non poche aveva trascorso lunghi periodi: da Bologna, «studiorum nutrix», nella quale aveva passato tre anni, quando in gioventù vi aveva studiato diritto civile («Bononie triennium expendi»), a Parma, a Pavia, «longobardorum olim sedes augustissima», dal «territorio ubertoso cui accrescono amenità il Po e il Ticino», a Genova, catturato anche dal fascino del suo golfo («incredibiliter delector Tyrreni maris anfractus»), all’unica Venezia («miraculosissima civitas»), a Milano («terrestrium decus urbium») dove sostò per quasi dieci anni all’ombra della «maledetta serpe» (come inveivano i fiorentini, timorosi della sua potenza), intrinseco del «mostro» Giovanni Visconti e poi del nuovo Polifemo, il ferocissimo Bernabò, tenerissimo con i cani quanto spietato con gli uomini; aveva apprezzato l’amena e fresca Treviso, ricca di acque, «aestivis deliciis et fluminibus civitas insignis et fontibus» e soprattutto la gloriosa Padova, «in regione Vallis Cispadanae nec minus idonea sedes est, ubi non parva portio felicitatis nostrae fuerit». Aveva trovato nel signore della città, Francesco da Carrara, non solo un ammiratore del magnifico ambasciatore visconteo ma anche un amico fedele e generoso (gli donerà la terra sulla quale edificherà ad Arquà la sua ultima dimora), quasi un discepolo desideroso d’imparare da lui l’arte di ben governare. L’autorevole «filosofo» l’esortò, fra le altre cose, a intraprendere senza indugio le necessarie opere di bonifica per accrescere «il pregio del bellissimo paese e raddoppiare la fertilità de’ famosi Colli Euganei ricchi del frutto di Minerva e di Bacco, ma dalle acque soverchie che vi ristagnano negati a quello di Cerere» (Senili, xiv, 1). Città «splendida e gloriosa» per lo Studio e i suoi luoghi santi, degradata purtroppo dai troppi maiali in libertà che scorrazzavano, insozzandole, per le vie, dei quali non sopportava «la turpe vista e l’ingrato suono», ridotta a un sudicio villaggio, «quasi rozza ed incolta campagna bruttamente percorsa ed ingombra da greggi di porci che da tutti i lati odi turpemente grugnire e vedi col grivo scavare in tutti i luoghi la terra». Il buon governo della cosa pubblica si realizzava anche nella tutela del «decoro» della nobilissima città, curandone il «pubblico ornato» affinché «gli occhi abbian pur essi di che trovarsi contenti, i cittadini si piacciano dell’aspetto urbano ridotto a forma più bella, e gli stranieri mettendovi il piede si avveggano di essere entrati in una città, non in una fattoria». Preoccupazione tuttavia troppo moderna per quei tempi quando tutte le città d’Italia, anzi d’Europa, convivevano con maiali, capre, muli, cavalli in un’unica grande stalla urbana. Né meglio stava la papale Avignone percorsa – ricordava Petrarca con disprezzo – da luride schiere di mendicanti straccioni in compagnia di schifosi maiali e di rabbiosi cani randagi.
Infaticabile mediatore di pace rispettato da tutti, poteva navigare tranquillo sul Po anche quando sulle sue rive scorrazzavano infide schiere di minacciose soldataglie e sulle sue acque incrociavano navigli armati che terrorizzavano i marinai e facevano tremare i suoi servi. Così fu nel viaggio per via fluviale intrapreso nel 1368 mentre ardeva la guerra fra l’imperatore Carlo iv di Boemia e i Visconti. Salito sopra un barcone, mentre «nessuno avrebbe osato inoltrarsi senza certezza di essere o preso, o ucciso, o almeno spogliato» raccontava al segretario papale Francesco Bruni (Senili, xi, 2) «io vidi colmarmisi la barca di bottiglie, di cacciagione, di poma, d’ogni specie di regali, per guisa che non alcun’angheria, ma solo la cortese liberalità di quelle soldatesche mi fece andar più lento in quel pacifico mio viaggio». Amava profondamente «questo gran fiume, sulle cui rive molto scrissi da giovane, molto meditai» e sul quale, mentre lo risaliva nel 1367 seduto «in una piccola nave» che lo portava da Venezia a Pavia, aveva vergato la più scintillante delle sue invettive, il De sui ipsius et multorum ignorantia.
Aretino, figlio di un proscritto fiorentino amico di Dante, dopo avere abbandonata l’«avara Babilonia», la nefanda Avignone dei papi francigeni dimentichi di Roma, lasciato alle sue spalle il tenebroso, labirintico palazzo papale che, nuova Babele, si ergeva «tristis» «in rupe horrida», detto addio al rabbioso Rodano, alla rovinosa Durenza, lasciato in custodia al suo intendente l’alpestre rifugio di Valchiusa sulla Sorga, lontano finalmente dai fiumi di Francia, divenuto allobrogo a tal punto da evitare in tutti i modi di rimettere piede in Toscana (tranne una rapida puntata nell’alto Casentino, alla Verna e a Camaldoli), stando sempre alla larga dalla città sull’Arno, la Firenze dei rissosi mercanti ch’egli, figlio di un refugié, non vide mai, trovò nell’Italia gallica la sua nuova, definitiva terra. Italiano orgoglioso, veemente difensore dell’antico primato romano, polemista spietato contro ogni vanto dei detestati barbari domati e castigati nella loro protervia dagli eroi del Lazio antico, del Po e di quel lungo paese che dal grande fiume prende il nome, divenne di questi il primo autorevole interprete, il primo ammirato descrittore.
Indimenticabile per l’ispirata eloquenza è la pagina lenta e sinuosa, costruita a spirale come i tortuosi meandri fluviali, con cui tratteggia l’Occidente padano, l’Insubria subalpina e il viaggio del suo maestoso re delle acque, nel De oboedientia ac fide uxoria, mirabile, libero rifacimento in latino dell’ultima novella del Decamerone mandata in dono a Boccaccio nel giugno del 1373 insieme a una lunga missiva che fu anche l’ultima delle sue lettere.
Est in Italiae latus occiduum Vesulus ex Appennini iugis, mons unus altissimus, qui vertice nubila superans, liquido sese ingerit aetheri, mons suapte nobilis natura, sed Padi ortu nobilissimus, qui eius e latere fonte lapsus, exiguo orientem contra solem fertur, mirisque mox tumidus incrementis, brevi spacio decursu, non tantum maximorum unus amnium, sed fluviorum a Vergilio rex dictus. Liguriam gurgite violentus intersecat, dehinc Aemiliam atque Flaminiam, Venetiamque discriminans, multis ad ultimum et ingentibus ostiis, in Adriaticum mare descendit. Caeterum pars illa terrarum, de qua primum dixi, quae et grata planitie et interiectis collibus ac montibus circunflexis, aprica pariter ac iucunda est, atque ab eorum quibus subiacet Pedemontium nomen tenet, et civitates aliquot et oppida habet egregia.
Quando nel 1350 raggiunse, in compagnia del cardinale Gui Boulogne, le rive del Benaco («Venetiae nobilissimum lacum»), salito sopra un colle, i suoi occhi affamati di bello intravidero in lontananza le Alpi ancora nevose a metà dell’estate: si girò poi a contemplare di fronte a sé la distesa delle acque del lago profondissimo e infine la sua vista calò sulla grande pianura sottostante, ferace e ridente, «uberem letamque planitiem». Ai suoi piedi, la piana sconfinata: lo stesso enorme catino verde che lo sguardo del predatore longobardo Alboino aveva divorato da lontano quando, arrivando dalla Pannonia con una caterva di alti guerrieri incolti nelle chiome e dalla lunga barba, adoratori della biscia accompagnati da una mandria di bufali riottosi, era salito sulla cima più elevata delle Alpi Orientali quasi ad assaporare il piacere della grande battuta di caccia ai Romani e il gusto dell’imminente conquista. «Rex Alboin cum ad extremum Italiae fines pervenisset» ricordava Paolo Diacono nella Historia Langobardorum «montem qui in eisdem locis prominet ascendit, indeque, prout conspicere potuit, partem Italiae contemplatus est».
Erano passati da allora molti secoli ma la stessa florida bellezza dei campi e lo splendore delle città accendevano l’ingordigia del nuovo barbaro che da Occidente si accingeva a depredarla, eccitavano la brama di possederla e di assaporarla nel cuore avido del «rabidus lupus» transalpino, rabbiosa belva in agguato.
Veggio sopra di te di negro nembo
Coprirsi il cielo, ed oscurarsi il sole,
E giù dall’Alpi un diluvio raccolto
Per innondar i nostri dolci campi
Scendere, e il fior delle bellezze tue
Correre ad isfiorar. Cittadi e regni
(Ché regni sono l’ampie tue provincie),
Terre e castella tante e sì diverse
Altere moli in cui fêr senno ed arte
L’estrema prova sì che l’alte cime
Nascondon fra le nubi e il ciel minacciano.
I marmorei palagi e le colonne,
I vasti porti e l’uno e l’altro mare
Mira dall’Alpe, ed in cuor suo ne gode
Il fero Gallo, e più e più studia il passo.
Se non che meraviglia ad or ad ora
L’arresta quando tremolar nel campo
Vede le biade, e de’ bei colli mira
In sulla china le incurvate viti
Cui fan sostegno gli olmi amati, e i lieti
Pascui, e greggi ed armenti, e in più serena
Aura gli augelli batter l’ale intorno;
Chiare fresche dolci acque in rivoletti
Ristrette rallegrar le verdi piagge,
Fonti salubri, pelaghetti puri,
Correnti fiumi, solitari spechi,
Ombrose valli ed odorati boschi
D’alberi da’ suoi frutti quasi occulti,
...