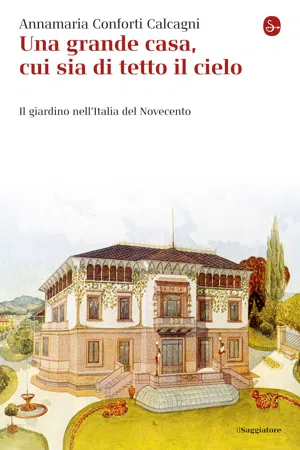1. La ripresa del giardino formale
L’apporto anglosassone alla rivalutazione del giardino formale
Non è corretto ammassare in pochi acri di terreno tutte le sfumature emotive della Natura, dalla luminosità alla serenità, al pittoresco, al melanconico, al tragico, al terribile, al sublime, né è lecito riempire il parco di abbazie, e di romitaggi, di templi greci e di castelli medievali incoerenti tra di loro e che, per la necessaria limitatezza delle dimensioni e la povertà dei materiali, non riescono a ingannare la vista ma al massimo a urtarla. È questo, del resto, l’esito inevitabile del giardino paesaggistico: esso fa appello a molte emozioni ma ne suscita una soltanto, una forma particolare di scoramento […]. Sarebbe ora che il mondo abbandonasse queste follie decadenti, che si volgesse nuovamente, per trarne ispirazione, ai «giardini tra gli alti muri, verdi e antichi» di un’età più felice […] che volgesse infine le spalle a Kent, a Capability Brown e a Horace Walpole e cercasse di imparare la lezione di Leon Battista Alberti, Michelozzo, Bramante, Vignola, Raffaello e Michelangelo, ossia i veri principi dell’arte di costruire i giardini.
E inoltre:
Non potete sperare di convincerci che la Natura abbia costruito la casa, e quindi perché insultare la nostra intelligenza facendo finta che la Natura abbia costruito il giardino? […] Hegel ha fatto notare che […] simulare disordine e la naturale solitudine primordiale di una scena realizzata artificialmente, deliberatamente progettata, rappresenta una di quelle contraddizioni primarie che nessuna abilità di giardiniere riesce ad attenuare o a nascondere.
Tutto questo (e molto altro ancora) si legge in An Essay on the Making of Gardens uscito a Londra nel 1909, intensa e meditatissima opera di Sir George Sitwell,1 un gentiluomo inglese molto colto e un po’ bizzarro che, per aver dedicato la cura più attenta (nonché interi anni della sua vita) alle più diverse e squisite sfumature che la vasta gamma dei giardini italiani gli poteva offrire, ne era via via diventato non solo un conoscitore assolutamente eccezionale ma anche un grande, appassionatissimo innamorato. Per cui il suo biasimo vibrante non si rivolge soltanto ai responsabili del loro declino, vale a dire ai giardini del suo paese, ma alle cause che di questi ultimi determinarono la nascita e il successo: un successo che egli individua, come del resto i suoi conterranei, negli eccessi del giardino francese, specie di André Le Nôtre, il quale «rubò bensì a Roma e a Firenze la formula della costruzione dei giardini, dimenticando però di rubarne la poesia».
Scortato da un cameriere che, provvisto di una cesta di vimini col solito pranzo, ne vegliava a debita distanza la silenziosa meditazione, Sir George Sitwell aveva così passato ore e ore ad ascoltare l’argenteo zampillare della fontanella di un giardino; a osservare la stupefacente brillantezza di un ritaglio di cielo sulla quieta superficie di una peschiera; a valutare il sempre diverso legame che ogni giardino sapeva intessere con il paesaggio circostante; a scoprirne il punto culminante e a indagarne il rapporto delle sue parti con il tutto; a osservare come la «lenta marea» dei licheni avesse via via rivestito di un morbido abito damascato il biancore delle sue statue…
Con vigile attenzione, costanza pervicace (e l’immancabile sporta di vimini a tacita distanza), Sir George dunque visitò, scrutò, assaporò ogni angolo del nostro paese, fino a stilare l’elenco completo e dettagliatissimo di tutti quei giardini che avevano avuto la buona (quanto eccezionale) sorte di passare indenni attraverso quella distruzione generalizzata che i loro proprietari, per essere à la page (peraltro con svariati decenni di ritardo rispetto all’Oltremanica), avevano loro inflitto, trasformandoli alla bell’e meglio «all’inglese». Spesso in modo raffazzonato e assolutamente incongruo.
Ma quel libretto prezioso di un britannico tanto amante dello storico giardino formale non fu tuttavia la prima pubblicazione che, dopo lunghi decenni di critiche sprezzanti, ne voleva invece (e a gran voce) la più completa rivalutazione. Tanto per darne un’idea, basterà qui ricordare che un rinnovato interesse per quella sua antica struttura era trapelato nell’ormai lontanissimo 1809, quando Charles Percier e Pierre Fontaine avevano pubblicato a Parigi un ben documentato saggio (Choix des plus célèbres maisons de plaisance de Rome et de ses environs) sui giardini laziali; o quando nel 1822 era arrivata, nientemeno che da Londra (J.C. Loudon, Encyclopedia of Gardening), un’esplicita ammirazione nei loro confronti; o quando ancora, nel meno lontano 1884, era uscito a Berlino il nutritissimo volume di W.P. Tuckermann (Die Gartenkunst der italienischen Renaissance-Zeit) sui nostri giardini del Rinascimento. Un incondizionato apprezzamento del giardino formale era poi arrivato, e ancora da Londra, quando nel 1892 era uscita l’opera dirompente di Reginald Bloomfield (The Formal Gardens in England), dove, suscitando polemiche roventi, l’autore aveva esaltato, a totale detrimento del giardino «all’inglese», la straordinaria bellezza, varietà, armonia di quello impostato sulle leggi della geometria e dell’architettura. E l’elenco può continuare: nel 1901 una giovane inglese, Janet Ross, aveva pubblicato un volume dedicato alle Florentine Villas (e ai loro giardini) e nel 1904 Edith Wharton, l’agguerrita scrittrice statunitense che dei giardini di casa nostra era profonda intenditrice, aveva dato alle stampe un’opera di grande rilevanza come Italian Villas and Their Gardens,2 a cui aveva fatto seguito, nel 1906, The Art of Garden in Italy dell’architetto inglese Harry Inigo Triggs. Né vanno dimenticate le pubblicazioni che nel frattempo erano uscite Oltreoceano: come Italian Garden di Charles Platt che già nel 1893 (ed era stato il primo studio in lingua inglese specificamente dedicato all’arte del nostro giardino) presentava numerose opere italiane corredate di accurati disegni e di belle fotografie; o come il diffusissimo periodico American Architect and Building News che dal 1897 aveva cominciato a diffondere le immagini dei nostri giardini. Per non dire, infine, della romana, neonata (su modello francese) American Academy, da cui già uscivano e avrebbero continuato a uscire numerose e qualificate opere sull’argomento. Questo per citare solo alcune delle pubblicazioni europee e americane sul giardino «all’italiana» (come ai primi del Novecento lo si cominciò a chiamare) edite fino ad allora.3
E dall’Italia, dalla terra stessa che quelle opere aveva pur saputo produrre, cosa sortì? Nulla. Perché, a differenza dei francesi, dei tedeschi, degli inglesi o degli americani, gli italiani tacquero. O quasi. L’unica eccezione in tanto silenzio venne da una donna, Maria Pasolini Ponti che, anche se sulla scorta degli autori inglesi, nel 1915 pubblicherà un libricino dal titolo Il giardino italiano, destinato a restare, ancora a lungo, l’unico testo sull’argomento.
Ebbene: se a tanti anni di distanza ci è ancora difficile comprendere il perché di tanta disaffezione, comincia tuttavia a diventare chiaro che a quella mancanza inspiegabile e deleteria comunque risale l’ignoranza generalizzata che, come avremo modo di dire, sarà certamente gravida di pesanti conseguenze.
In ogni caso, vuoi per il naturale evolversi del gusto, vuoi per un diffuso senso di saturazione che, come si è accennato, la trasformazione di piccoli ed equilibrati giardini formali in improponibili opere paesaggistiche aveva portato con sé, quella generalizzata e acritica moda d’Oltremanica aveva finalmente chiuso il suo ciclo e la rivalutazione del giardino formale cominciò, anche da noi, a farsi strada: se non dal punto di vista teorico (gli studi continuavano a mancare), certamente da quello pratico. Fattuale. Anche perché il connaturato rapporto con la residenza, che questo tipo di giardino aveva sempre manifestato, si confaceva assai meglio alla società urbana e borghese che si andava via via affermando e che grandi spazi, assolutamente necessari al giardino paesaggistico, non si poteva certo permettere. A marcare la distanza dal secolo precedente, bisogna infatti osservare che, almeno fino all’Unità d’Italia, il timido affermarsi dell’industrializzazione non aveva affatto scalfito la primaria importanza dell’agricoltura e che, pertanto, la stessa valenza economica del possedimento «di villa» aveva continuato a restare pressoché inalterata.4 E anche se, specie per l’avvento napoleonico, l’antica aristocrazia, che di quei beni era stata per secoli detentrice, aveva sovente dovuto cederli all’avanzare gagliardo della classe borghese,5 va comunque detto che nemmeno con quest’ultima il rapporto villa-giardino aveva registrato cambiamenti radicali. Se è infatti vero che, una volta in possesso di quei beni, la borghesia aveva voluto marcare la sua comparsa sulla scena politica e sociale adottando il «nuovo» giardino d’Oltremanica, bisogna anche dire che essa non aveva poi minimamente inteso ridurre (anzi!) l’importanza che l’appena distrutto giardino formale aveva da sempre conferito alla domus dominica. E fino a ben oltre la metà del secolo il giardino, sia pure «all’inglese» (e sia pure «borghese»), aveva finito con il mantenere, nelle sue ragguardevoli dimensioni (nonché nel prestigio che da esse derivava), una sua qualche «aristocratica» prerogativa. Non diversa, nella sostanza, da quella di sempre.
Ma ora le cose cambiavano. Cambiavano veramente. Anche se, per capirne le ragioni, dovremo allargare il discorso e accennare alla situazione assolutamente nuova in cui l’intero paese veniva ora a trovarsi. A cominciare dal sistema produttivo che ormai si andava affermando.
Infatti, nonostante lo sforzo immane di portare a unità un territorio nazionale a cui fin dall’invasione dei longobardi era toccata in sorte la più diversificata delle frammentazioni, nonostante la mancanza di un sistema ferroviario in grado di collegarne gli opposti estremi geografici (la tratta più lunga era costituita dalla «Ferdinandea» che da metà Ottocento collegava le due capitali del Lombardo-Veneto),6 nonostante l’inesistenza di una rete stradale che fosse minimamente degna di tale nome, si poté tuttavia assistere a un certo generale miglioramento della situazione. E anche se di un miracolo evidentemente non si trattò, già alla fine degli anni ottanta dell’Ottocento l’economia italiana aveva comunque dimostrato di poter reggere l’aumento della popolazione che, così come in ogni regione d’Europa, aveva pure toccato il nostro neonato paese; e di aver registrato il nascere di un processo di industrializzazione che, se pure in dimensioni ancora circoscritte, era comunque in grado di competere con quello europeo.7 Alla fine dell’Ottocento si era insomma avviata quell’evoluzione economica ormai irreversibile che, con l’industria ora protagonista, stava radicalmente modificando l’intero assetto del territorio nazionale: a partire dalle città che cominciavano a esercitare una vistosa forza centripeta; dai loro nuovi quartieri extra moenia e dalla connotazione di questi ultimi; nonché dal rapporto con lo spazio esterno che le loro architetture andavano ora a ricercare. Le quali stavano risentendo quasi dovunque del nuovo linguaggio «moderno» (o «modernista», come lo si preferì chiamare) che ormai, sia pure con accenti diversi e differenti denominazioni, stava comunque affascinando l’Europa intera. In Italia lo si chiamò Liberty e trovò realizzazioni di grande pregio.
Il Liberty e i suoi principali protagonisti
L’ambiziosa e vasta rassegna, che nel 1902 Torino aveva dedicato alle arti decorative di tutta Europa, diventa una sorta di spartiacque e l’imprescindibile punto di partenza di una nuova cultura che andrà direttamente a incidere sul rapporto tra architettura e spazio esterno e che diventerà, di conseguenza, molto significativa anche per l’argomento che stiamo trattando. Oltre ai raffinatissimi oggetti provenienti da Germania, Belgio, Danimarca, Inghilterra, Svezia, Olanda… a Torino era stato possibile infatti constatare, e in Italia si trattava di un fatto del tutto nuovo, che le stesse architetture destinate a ospitarli avevano decisamente cambiato registro. Loro autore era stato soprattutto l’architetto friulano Raimondo D’Aronco (Gemona del Friuli 1857-Sanremo 1932) che lì, infatti, non rivela più quell’appartenenza alla cultura dell’Eclettismo fino ad allora dominante, ma una concezione del tutto nuova (fig. 1). E i volumi di quelle sue opere (e non solo delle sue), la loro struttura e le loro forme, variamente articolate nello spazio, trovavano negli elementi tratti dalla natura una sorta di veicolo unificante: sia nella loro configurazione esterna (nelle facciate, nelle inquadrature di porte e finestre, nelle cornici marcapiano, nei balconi, nelle tettoie, nelle grondaie…), sia anche, varcata la soglia, nelle sale, negli androni, nei corridoi, nelle scale che variamente ne articolavano le suddivisioni interne.
Villa Igiea e il suo giardino sul mare in una fotografia degli anni trenta del Novecento.
Si trattava, insomma, di un’architettura organicamente intesa, il cui agente generatore diventava di volta in volta il fiore, il tralcio, la foglia, il racemo… Vale a dire l’elemento vegetale tout court, che è proprio del giardino, da cui sembra essere direttamente estrapolato.
Tuttavia, quando nel 1902 la mostra torinese aveva aperto i battenti, erano stati ben pochi a credere nella qualità e nell’aggiornamento culturale delle opere che l’Italia vi avrebbe potuto esibire: specie se si pensa che appena due anni prima, nell’Esposizione di Parigi del 1900 appunto, il padiglione del nostro paese non aveva presentato che «una caterva di rifacimenti dell’antico»8 ancora ben lontani dal nuovo gusto. Ma furono invece molti a stupirsi. Tra essi il critico parigino Roger Marx che, nella Gazette des beaux arts del dicembre di quell’anno, aveva fortemente apprezzato la nuova qualità della produzione italiana e, in special modo, gli arredi di Ernesto Basile9 (Palermo 1857-1932), l’architetto-designer destinato a diventare ben presto l’esponente di spicco di quella nuova concezione estetica, di cui, specie nel bellissimo ingresso per l’esposizione agraria tenutasi nella sua città proprio in quell’anno, già aveva dato ragguardevole prova. A differenza di Raimondo D’Aronco, che avrebbe lavorato prevalentemente in Turchia e la cui attività come architetto liberty in Italia si riduce a pochi esempi,10 Basile operò invece a lungo nel nostro paese, e ovviamente anche in Sicilia dove (e appunto negli anni di inizio secolo) la vivacità di una classe borghese, attiva, imprenditrice e aperta al nuovo offriva il milieu più idoneo alle sue opere straordinarie. Tra queste, e già prima della mostra, la realizzazione a Palermo del grande a...