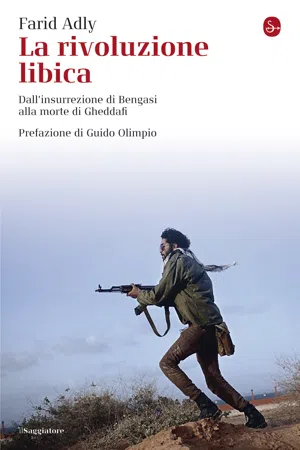1. La caduta del velo della paura
In ogni città araba liberata si dovrebbe fare un monumento a Mohamed Abu Azizi, il giovane avvocato tunisino, di mestiere venditore ambulante, del villaggio di Sidi Bouzid, che si è dato fuoco dopo che la polizia gli ha sequestrato la mercanzia. Mohamed è il simbolo della disperazione della gioventù araba vittima della corruzione e delle sbagliate scelte economiche liberiste delle classi dirigenti, politiche e imprenditoriali dei paesi arabi.
Il suo disperato gesto è stato la dimostrazione concreta, in campo sociale, della non linearità dei sistemi complessi, il cosiddetto butterfly effect del fisico Edward Lorenz. I dieci giorni che hanno sconvolto la Tunisia (dal 4 gennaio 2011, giorno della morte del giovane Mohamed, al 14 gennaio 2011, giorno della fuga del presidente tunisino Ben Ali) hanno portato in tutto il mondo arabo una nuova aria, un «vento della rivoluzione e della speranza», che sta spazzando via, una dopo l’altra, le cariatidi dei vari poteri dittatoriali.
L’esperienza tunisina si è collocata su un percorso in crescendo di mobilitazioni e rivendicazioni mirate, grazie alla presenza di un’opposizione democratica, di sinistra e islamista, determinata e organizzata, e grazie anche al radicamento sociale del sindacato. L’apparente neutralità degli alti gradi dell’esercito, già marginalizzati dal clan benalista, ha dato respiro alla protesta popolare che, malgrado la repressione, non è stata soffocata. L’epilogo della vicenda tunisina è stato reso possibile dalle divergenti opzioni delle potenze internazionali, Stati Uniti e Francia in primis. Nonostante la sua presenza massiccia in termini di investimenti, l’Italia ha contato poco nel disegnare la svolta, per via del sodalizio tra Silvio Berlusconi e Ben Ali, e della brutta figura provocata dalle dichiarazioni del ministro Franco Frattini: l’elogio al dittatore poco prima della sua fuga.
Molte altre realtà arabe si sono incamminate lungo questo percorso. Oltre all’Egitto anche Algeria, Yemen, Giordania, Sudan, Libia, Marocco, Siria, Bahrein hanno mostrato e mostrano condizioni simili, e hanno vissuto mobilitazioni popolari di una certa importanza. In Giordania è stato cambiato più di una volta in pochi mesi il governo; in Yemen si è proceduto a una riforma costituzionale che dovrebbe impedire la trasmissione ereditaria del potere e il presidente Ali Abdullah Saleh, dopo lunghi mesi di abbarbicamento alla poltrona, sostenuto dalle monarchie del Golfo, ha dovuto mollare i remi con la garanzia di una immunità totale per lui e politica per i suoi.
In tutti i paesi della regione sono stati avviati, da parte dei vari governi, provvedimenti a sostegno di salari e stipendi, mirati a ridurre l’inflazione e ad attenuare, anche se soltanto momentaneamente, i disagi di una popolazione sempre più povera e senza prospettive.
La situazione egiziana si presenta tra le più complesse, anche se molte sono le somiglianze con quella tunisina: povertà, dittatura e corruzione. L’Egitto ha una posizione strategica e una storia peculiari, oltre al peso demografico dei suoi quasi ottantacinque milioni di abitanti; è il baricentro della politica mediorientale e il centro principale della cultura che lega tutti i parlanti di lingua araba, senza voler sminuire le peculiarità delle altre realtà nazionali. Il Cairo dà la direzione al processo in corso e il grado di riuscita della sollevazione egiziana sarà fondamentale per misurare quello delle altre rivoluzioni.
In Egitto la miccia della rivoluzione è stata accesa da un gruppo di giovani delle classi medie, culturalmente preparati e fortemente impegnati nei nuovi mezzi di comunicazione: il loro movimento è nato con una pagina di Facebook. L’orientamento della maggior parte di questi giovani è genericamente liberal o di sinistra (appartengono a Giovani per il Cambiamento, Kefaya, Giovani 6 Aprile, Kulluna Khaled Said); non hanno un programma politico o una struttura organizzativa ben definita; alcuni sono legati alle lotte operaie e hanno riferimenti chiari al socialismo; quelli vicini alla fede islamica non hanno nessun legame con i fondamentalisti Fratelli musulmani, ma sono portatori di idee illuminate e laiche. La spontaneità del movimento non ha impedito, dopo i primi giorni di smarrimento dinanzi all’inaspettata grande risposta di popolo, la formazione di un coordinamento allo scopo di definire obiettivi che andassero oltre la richiesta di democrazia politica e diritti civili, nonché i mezzi per realizzarli.
Un’organizzazione inizialmente rudimentale che ha permesso al potere, nella prima fase, di escludere questi giovani dal dialogo trattando invece con i partiti legali (il liberale Wafd e Tagammu, di sinistra) e con i Fratelli musulmani, non riconosciuti ufficialmente. Le parole d’ordine della prima manifestazione, quella del 25 gennaio 2011 – democrazia, libertà e giustizia sociale – si sono così trasformate in richieste chiare, concrete e immediate: l’abdicazione di Mubarak e la fine del regime, processi per i crimini e la restituzione al popolo del maltolto dalla corruzione. È questa posizione che ha portato dapprima al fallimento del tentativo di mediazione tra il regime e i partiti tradizionali, e poi alla cacciata di Mubarak.
La dura repressione, che ha portato alla morte di circa trecento persone inermi e a oltre mille arresti nel solo primo giorno di mobilitazione, ha scosso le basi del potere e portato al collasso le famigerate forze di sicurezza, un apparato di trecentocinquantamila agenti aventi la massima libertà di azione repressiva, anche quella di uccidere sotto tortura in commissariato (come era avvenuto ad Alessandria d’Egitto al giovane Khaled Said, il 7 giugno 2010). Il tentativo di un giro di vite contro l’informazione (con gli arresti di giornalisti stranieri, l’oscuramento delle tv satellitari, la chiusura di Internet e delle reti di telefonia cellulare) e l’uso dei baltajieh (sicari privati) contro i manifestanti hanno dimostrato la debolezza del regime e lo hanno ampiamente screditato di fronte alla gente semplice come alle diplomazie internazionali. Le immagini atroci delle esecuzioni in piazza da parte della polizia hanno tolto ogni fiducia nelle promesse di «cambiamento nella continuità». Il tappo è saltato e l’onda della protesta è diventata incontenibile. È stato così subito scardinato il sistema ereditario che la famiglia Mubarak aveva sapientemente congegnato e che doveva portare a «eleggere» il figlio Jamal a successore del vecchio e malato «monarca».
Il ruolo dell’esercito è stato determinante nell’evitare che il Venerdì della collera (28 gennaio 2011) finisse in un bagno di sangue. Ma non è stata un’azione gratuita. Gli alti gradi dell’esercito non avevano mai caldeggiato la successione del figlio Jamal Mubarak e lo avevano detto chiaramente al padre, chiedendo a lui di presentarsi alle elezioni allora programmate per l’autunno 2011, nonostante l’avanzata età (ottantaquattro anni portati male). Lo scenario che si presentava il 28 gennaio era quello di uno scardinamento totale dello Stato, con forti pericoli di derive di tipo iracheno: una minaccia alla sicurezza nazionale e, di conseguenza, la perdita dei privilegi riservati alla gerarchia militare, garantiti dagli aiuti statunitensi.
Per contenere la rivolta sono stati messi in atto piani elaborati in lunghe telefonate tra Washington, Tel Aviv, Riad e Il Cairo. Il minimo dei cedimenti con il massimo della disponibilità verbale. Mentre le diplomazie internazionali si riempivano la bocca di parole come democrazia e passaggio ordinato dei poteri, Israele forniva alla polizia egiziana, secondo attendibili rivelazioni della stampa indipendente del Cairo, moderne armi con sistema di puntamento laser per gli omicidi mirati e raccomandava ai suoi diplomatici di spiegare ai governi che contano l’importanza di Mubarak, per la «pax israeliana» in Medio Oriente. L’Arabia Saudita avvisava gli Usa che, in caso di blocco degli aiuti militari all’Egitto, il regno avrebbe provveduto a compensarli. Per salvare il monarca sono stati evocati impegni internazionali (gli accordi di Camp David) e la necessità di contenimento dell’Iran. Tutti pretesti che non avevano messo in conto le sofferenze di ottantacinque milioni di egiziani che, malgrado le potenzialità del paese, vivevano in grandi difficoltà e senza speranze, e soprattutto non era stata presa in considerazione la determinazione della gioventù egiziana a non continuare a subire.
La caduta di Mubarak si è resa possibile quando gli alti comandi militari, suoi compagni d’armi e suoi complici in tutte le nefandezze tra corruzione e privilegi, si sono accorti che l’arroganza del loro presidente li avrebbe portati al bivio, insostenibile, tra l’uso della forza contro le masse, provocando stragi e infangando il buon nome dell’esercito nazionale, e il rimanere travolti e perdere ogni privilegio.
La rivoluzione egiziana, anche se è scoppiata in forme spontanee, ha le sue radici nella povertà dilagante. Secondo il settimanale di sinistra Al Ahali cento famiglie egiziane detengono il 90% della ricchezza del paese. I trent’anni di liberismo sotto Mubarak sono stati anni di rapina delle risorse statali. La ricchezza della sola famiglia Mubarak è valutata dall’organo del Wafd in 275 miliardi di sterline egiziane (che sono cinquanta miliardi di dollari): frutto di commissioni sulle armi e di operazioni immobiliari e turistiche. Malgrado il tasso di sviluppo del Pil nel 2009 e nel 2010 sia stato del 4,7 e del 5,3%, nel paese rimangono oltre ventuno milioni di disoccupati (un quarto della popolazione). Nel solo 2010 il prezzo del pane, principale alimento della popolazione, è balzato da cinque piastre a venti (+ 300%).
La repressione politica, la soppressione delle libertà di parola e di organizzazione, le violazioni dei diritti umani si sono unite alla povertà diffusa e all’allargamento della forbice tra la condizione dei pochi grandi ricchi e quella di grandi masse ridotte alla fame. Il crescendo di mobilitazioni di piazza, avvenuto in tutto il paese, raggiungendo anche i piccoli centri e le zone rurali, ha portato al coinvolgimento dei lavoratori, che dopo la prima settimana si sono uniti al movimento con scioperi e blocchi stradali. Questo sviluppo ha rappresentato un salto di qualità: ha dato al movimento anche un carattere di classe, fecondo di importanti prospettive. Anzi già subito dopo la caduta del monarca le rivendicazioni dei lavoratori hanno registrato una maggiore determinazione, nella consapevolezza del cambio di registro da parte del potere. La scoperta delle dimensioni spropositate della ricchezza accumulata dalla cricca capeggiata dal presidente e dal figlio ha portato tutti a vedere il re nudo. Soltanto se si riuscirà a unire la lotta per la democrazia e le rivendicazioni dei lavoratori e degli strati poveri della popolazione, e a far tornare i militari alle loro caserme potrà aprirsi un reale orizzonte di cambiamento.
Il vulcano sul quale erano seduti Mubarak e Ben Ali, a garanzia della stabilità degli interessi dei paesi industrializzati in Medio Oriente e nella zona del Golfo, è ancora in piena eruzione. A metà dicembre 2010, tutto questo non era previsto né dalle analisi specialistiche né dalle centrali dell’intelligence, malgrado i dati disponibili sulla situazione economica e occupazionale, sulla profonda corruzione che lacerava quelle società e sulla soppressione di ogni forma di libertà sostanziale. Tre elementi che i ripetuti rapporti degli organismi Onu sullo sviluppo hanno sviscerato e reso espliciti a chiunque, indicando anche alcune soluzioni a lungo termine per evitare il collasso. Nessun politico lungimirante si è accorto del baratro verso il quale stava andando tutto il sistema marcio di questi regimi. Tutti hanno contato sull’ancestrale disposizione delle masse arabe alla rassegnazione e alla sottomissione al potere costituito. A nessuno è balenato nella mente il dubbio che la pazienza della gente potesse esaurirsi. Si deve dare il merito all’attuale presidente tunisino Moncef Marzouki di aver preconizzato, in un confronto televisivo, nella primavera del 2010 e cioè un anno prima delle rivolte in corso, la caduta di questi regimi per mano di una spallata popolare. «La gente non ce la fa più. Questi regimi finiranno nella pattumiera della Storia!» aveva gridato in faccia al suo interlocutore, uno squallido giornalista fanatico di Ben Ali.
Ci si chiede il perché di questo sviluppo straordinario proprio in questa fase. Molti hanno enfatizzato il ruolo di Internet e dei social network. Non sono d’accordo. Sicuramente la comunicazione diretta, spontanea e immediata che questi mezzi hanno offerto alle nuove generazioni ha avuto un ruolo nell’accelerare il processo, ma non è il fattore determinante. Da una parte perché gli strati sociali raggiunti da questi mezzi sono ancora numericamente marginali in tutti i paesi arabi (in Libia sono addirittura esigui) e dall’altra, poiché le rivoluzioni delle tante piazze Tahrir sono continuate anche nel momento delle ritorsioni dei regimi con l’oscuramento di Internet e il blocco delle comunicazioni della telefonia cellulare. Ricordo con simpatia un cartello di un manifestante egiziano con la scritta NASSBOOK per dire che questa è la rivoluzione della gente (nass). Era caduto il muro della paura. La gente che era scesa in piazza in difesa della propria dignità non aveva nulla da perdere e aveva interiorizzato non solo che la misura era colma, ma anche che il potere tirannico si alimentava e traeva linfa dal silenzio di molti. Il punto di unione tra l’esperienza di piccole avanguardie organizzate e sperimentate in decenni di repressione e le larghe masse di diseredati è stato proprio questa consapevolezza, per dirla con le parole del grande timoniere non più ascoltato neanche nella sua Cina: il potere è una tigre di carta. La morte di Abu Azizi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Dopo il 14 gennaio (Tunisia) e l’11 febbraio (Egitto) nulla sarà come prima, malgrado i risultati elettorali deludenti per i giovani che hanno avviato e organizzato la mobilitazione, sopraffatti alle urne da partiti collaudati da un’esperienza decennale e da disponibilità finanziarie e mezzi di comunicazione non indifferenti. «È la Democrazia, bellezza!»