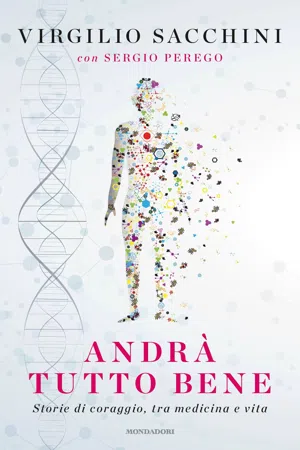«Devo fare di più, e meglio.» È la promessa che, trentaquattro anni fa, mentre lo accompagnavo nel suo ultimo viaggio, avevo fatto a Giovanni, del quale ero diventato buon amico. Alto e robusto, Gio, come lo chiamavano tutti, era un ragazzone simpatico, entrato in ospedale per un melanoma. Che non gli avrebbe lasciato scampo. Ancora oggi questo genere di tumori è tra i più difficili da controllare nel loro sviluppo; e da guarire. Dopo le prime cure, la situazione di Giovanni era peggiorata. Neolaureato, avevo solo ventisei anni e quel giovane emiliano sarebbe stato il primo paziente che avrei visto morire. Uno choc. Stessa musica, interessi simili, nei mesi in cui rimase in ospedale eravamo spesso insieme.
Ricordo i tentativi dell’équipe medica alla quale ero stato affidato di fermare il devastante avanzare della malattia. Anch’io, che pure avevo scelto una specializzazione diversa, con una tesi sui tumori tiroidei, nella speranza di poterlo aiutare avevo approfondito la letteratura sulle neoplasie della pelle. È in quei momenti, quando ti senti impotente nonostante gli sforzi, quando non puoi opporti all’inevitabile, che devi trovare la forza, il coraggio per continuare a fare il medico.
Coraggio non è una parola esasperata. Per chi ha scelto questa professione, gli insuccessi significano, per fortuna non sempre, la perdita di una vita. Sono i giorni più difficili, durante i quali ti guardi alle spalle, rivolgi il pensiero agli studi che hai da poco concluso. È in quei frangenti, quando tutto ti sembra insufficiente, addirittura inutile, che devi cercare e trovare il modo per andare oltre.
Dopo la morte di Giovanni, chiesi subito di entrare in un gruppo di ricerca. In medicina, le scoperte per migliorare la cura delle malattie non finiranno mai. Ci sarà sempre e comunque la possibilità di «fare di più». Se credi in quello che hai scelto di fare e che stai facendo, è nelle circostanze più critiche che puoi decidere di dare ancora più forza al tuo impegno.
Il team con il quale lavoravo all’Istituto dei Tumori di Milano mi inserì in un progetto di ricerca sui tumori pancreatici. Mi diedero il compito di verificare la sopravvivenza dei pazienti colpiti da questa forma aggressiva di neoplasia. Fu un disastro. Per ricavare certi dati, devi disporre delle cartelle cliniche. Rappresentano la storia dettagliata di una malattia. Senza, non puoi fare nulla. Archiviate nei sotterranei, qua e là ricoperte di polvere, le cartelle erano quasi introvabili. Per conoscere le notizie fondamentali, nascita, vita, cause della morte, provai con gli uffici anagrafici del comune di residenza dei pazienti. Mettendo insieme i documenti raccolti, scoprii ben presto che il tumore al pancreas era un vero killer. Adesso la situazione è migliorata, ma per essere sconfitto questo tipo di cancro avrà ancora bisogno di un enorme e attento lavoro da parte dei ricercatori. Subito dopo mi affidarono una nuova ricerca, questa volta sui tumori tiroidei. Un sollievo. Conoscevo la situazione perché avevo già lavorato su questa patologia. Sapevo, infatti, che in questo campo i progressi non erano mancati e che a salvarsi era la quasi totalità dei malati.
Leggendo le cartelle, scoprivo, come dico ogni giorno ai miei studenti della Cornell University, e dallo scorso novembre anche della Statale di Milano, che ogni tumore è diverso, e ogni persona è diversa. La ricerca, che non può non trovare la sintesi con protocolli in qualche misura standardizzati, deve comunque lasciare sempre quello che io definisco «un ulteriore margine di interpretazione». È in questo spazio che medico e ammalato s’incontrano e costruiscono il loro rapporto personalizzato, ogni volta unico. Insostituibile.
Ricordo che di fronte ai momenti più deprimenti, i medici più anziani cercavano di sostenermi, di aiutarmi a superare le difficoltà, a vincere la depressione degli insuccessi, che per un medico, ripeto, significano una cosa sola: non essere riusciti a salvare una vita. Con il tempo – dicevo tra me e me – mi sarei costruito una corazza di protezione. «Con gli anni ci arriverai» aggiungevano i miei colleghi più esperti e navigati, quando, alla fine di una lunga lotta contro la malattia dalla quale uscivamo sconfitti, non potevamo che arrenderci. Dopo oltre trent’anni di ambulatorio, corsia e sala operatoria, per me quel momento non è ancora arrivato. Ancora oggi, quando devo cedere all’inevitabile, vincere lo sconforto non è mai facile.
La passione, direi il fascino, di salvare una vita umana. Che cosa ci può essere di più importante? Ricordo ancora, in particolare, la soddisfazione che provai da medico ancora giovane nell’affrontare e risolvere alcuni casi particolarmente insidiosi. In altre parole, mi capitò di salvare la vita di due persone grazie alla diagnosi che ero stato in grado di fare. Senza conoscere, dopotutto, chissà quali dati anamnestici del paziente che avevo di fronte. Quando ero impegnato nelle guardie mediche notturne, infatti, a ogni chiamata che ricevevo non mi limitavo ai consigli telefonici. Salivo in macchina e raggiungevo l’ammalato. Una notte, per esempio, visitai un paziente che mi apparve subito in condizioni particolarmente gravi. Non rispondeva già più alle domande. Stava morendo. Non riuscivo però a capire la causa, che cosa avesse potuto provocare quello stato di coma. Fu quasi per caso che osservai il tavolo del salotto, sopra il quale la moglie dell’uomo – che poco prima mi aveva aperto la porta di casa sconvolta e in lacrime –, teneva i medicinali. Tra le tante scatole, ne riconobbi una di antidiabetici. «Ma è una forma leggera» mi rispose la donna quando le chiesi da quanto tempo il marito soffrisse di questa patologia. Ricominciai a visitarlo. Nessuna reazione alla pressione sulle dita, mentre la carta di determinazione del glucosio indicava trentacinque, un numero preoccupante, al limite di compatibilità con la vita. La signora mi spiegò che, quale conseguenza di un’influenza intestinale, il marito non mangiava da tre giorni, ma non aveva mai sospeso la terapia antidiabetica. Feci due fiale di glucosio endovena e dopo qualche minuto il miglioramento fu subito evidente. Se in quel momento, grazie agli studi, non avessi capito quella che per i medici dovrebbe essere quasi una banalità, quel signore sarebbe morto. Non smetterò mai di esortare i giovani medici impegnati nelle guardie mediche a non limitarsi a rispondere al telefono. Prendete l’auto, uscite. Solo così potrete capire.
Negli USA, per rispondere a questo genere d’interventi, caratteristici del pronto soccorso, vengono chiamati medici specializzati. Che, per diventare tali, dopo la laurea devono studiare altri cinque anni. In Italia, finora, accanto al primario o a qualche medico di esperienza, al pronto soccorso di un ospedale vengono assegnati giovani dottori freschi di laurea. È un errore. È proprio in quelle circostanze che devi mettere in campo la tua esperienza. Sempre negli Stati Uniti, e io sono d’accordo, ci sono medici specializzati in emergenza. Adesso anche nel nostro paese qualcosa sta cambiando. Nell’estate del 2014 i primi ottantadue specialisti in medicina d’urgenza sono entrati in corsia o nelle sale dei pronto soccorso. Avviato nel 2009, questo genere di specializzazione ha visto partecipare venticinque atenei italiani. Qui i futuri medici che tanto assomigliano al ruolo interpretato da George Clooney nella fortunata serie televista «E.R.-Medici in prima linea», hanno studiato e fatto pratica. Sono medici che devono conoscere un po’ tutte le discipline, per essere in grado di affrontare ogni genere di urgenza. Una goccia nel mare, viste le necessità, ma aver aperto la strada significa già molto.
Non dimenticherò mai quel signore che, di turno alla guardia medica, raggiunsi nella sua abitazione. Aveva trentanove anni. Tremante, sudava freddo. Il respiro era affannoso e la pressione troppo bassa. La moglie mi spiegò che era stato colpito da influenza. Il quadro complessivo mi sembrava preoccupante. La mia esperienza era quella di un giovane medico da poco laureato. Sulla base degli studi di semiotica medica, che avevo superato con qualche risultato, decisi di accompagnarlo subito in ospedale. La diagnosi del cardiologo fu: infarto coronarico. Un’ora in più e quell’uomo sarebbe morto. Quando leggo di pazienti dimessi dal pronto soccorso e morti qualche ora dopo non ho dubbi: spesso si tratta di un errore medico.
Non dimentichiamolo mai. Di fronte alla perdita di una vita umana, se non abbiamo fatto tutto il possibile perché ciò non accadesse, la responsabilità è sempre e comunque nostra, dei medici.
«Dottore, lei a me dovrà dire sempre la verità, anche quando questa sarà la più difficile da ascoltare.» Irritata più di quanto non fosse ogni volta che a New York la incontravo per visitarla, Oriana Fallaci mi punzecchiava così quando, sul tumore che l’aveva colpita, giudicava non abbastanza chiare le spiegazioni che le fornivo. «Io voglio sapere, sempre, come stanno le cose» mi sollecitava, invitandomi con durezza a non essere titubante.
La sua vita, quello che ha raccontato sui giornali e nei tanti libri di successo – alcuni me li aveva nel frattempo regalati –, testimoniano in che misura le parole con le quali mi invitava a «non nasconderle nulla» fossero autentiche. Urgenti. Vere. In Vietnam o nei teatri di altri sanguinosi conflitti che l’avevano vista protagonista in qualità di inviata di guerra, tra le penne più conosciute del giornalismo internazionale, anche lei, intendo, avrà certamente vissuto, momenti, ore o giorni di angoscia e paura. Com’è giusto e umano che sia. Questa consapevolezza, tuttavia, non le toglieva il coraggio di manifestare in maniera così energica e ruvida le proprie idee. Di riflettere e dire con schiettezza, tutta toscana, ciò che pensava a proposito dei gravi problemi che la società stava attraversando.
Quando scriveva i suoi pezzi creava sempre un dibattito molto acceso, spesso esasperato. Anche perché era lei la prima a esasperare i toni, a premere sull’acceleratore della vis polemica. Indimenticabili rimangono gli articoli pubblicati sul «Corriere della Sera», nei quali stigmatizzava quella che definiva – anche quando la incontravo a New York – «l’invasione dei musulmani in Occidente». Oriana è stata comunque un esempio di grande intraprendenza; prima di tutto nel dire sempre quella che per lei era la verità. Come tutti sanno, tre mesi dopo la tragedia dell’11 settembre 2001, aveva pubblicato La rabbia e l’orgoglio. Per quel libro, in particolare, i seguaci più radicali dell’Islam l’avevano minacciata di morte. Ammalata, viveva in solitudine, in una casa che dall’esterno sembrava disabitata, rinsecchiti gli alberi e i cespugli del piccolo giardino che la circondava. Di questo isolamento, forse necessario per la sua incolumità, Oriana era insoddisfatta.
La faceva tremendamente arrabbiare, in particolare, il fatto che il presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, non avesse organizzato la sua protezione. La casa in cui Oriana viveva non era sorvegliata. Circostanza che, quando il console italiano mi aveva accompagnato al primo incontro con lei, mi aveva meravigliato. «Forse pensano che le mie posizioni siano troppo radicali» diceva lei, «proteggermi non sarebbe stato politically correct. Così mi lasciano sola.»
L’insegnamento che questa grande donna ha lasciato al mondo, dunque anche a me, è quello di non avere paura. Conoscerla da vicino e per un periodo relativamente lungo non mi ha lasciato indifferente. Anzi. L’incontro con Oriana ha cambiato, almeno in parte, il mio modo di esprimermi. Viviamo in una società in cui prevale l’autocensura. In Italia, più che negli USA, la chiarezza non è considerata un valore. Al contrario, se dici quello che pensi, vieni subito giudicato. Il più delle volte, negativamente. Esprimere il proprio punto di vista, anche se estremo, dovrebbe invece essere sempre auspicabile. Perché di questo è fatta la democrazia, una società che voglia dirsi civile, aperta, tollerante. Quella con cui ognuno di noi si confronta ogni giorno, uscendo di casa, interagendo con gli altri, parlando, discutendo. Nello stesso momento in cui avvertiamo il timore di esprimere ciò che pensiamo, perché ne temiamo le conseguenze, stiamo attribuendo al nostro interlocutore (sia esso un amico, un estraneo, un’istituzione) un potere di cui non dispone. Lo consideriamo, a torto, più degno di noi. Al contrario, sono dell’avviso che una comunicazione diretta, trasparente, che tenga conto, certo, anche delle ragioni dell’altro, costituisca un’evoluzione del pensiero. Un punto di vista diverso, autonomo, aumenta l’autostima di chi ne è protagonista.
A New York, alla Scuola italiana Guglielmo Marconi, dove mia figlia ha frequentato parte del liceo, l’organizzazione dell’istituto è cambiata. Rispetto allo stesso ordine di studi che io avevo sperimentato in Italia, a Monza, decenni fa, sembra che il nozionismo si sia ridimensionato. Agli studenti si cerca di insegnare la tolleranza, vengono educati al dialogo. Si fa il possibile per evitare lo scontro. Studiano la sociologia dei popoli. Approfondiscono i problemi relativi all’immigrazione. Si discute di contesti globali e dei relativi scontri politici, come quelli vissuti in Europa, negli USA o in Medio Oriente. Questo nuovo approccio, che definirei di educazione al dialogo, mi piace.
Quando discuto con i miei specializzandi, cerco di applicare lo stesso percorso. Dico loro: «Se qualcuno ci riesce, buon per lui, ma non è necessario sapere sempre tutto di ogni cosa o situazione. Nel rapporto con il paziente è invece necessario, direi indispensabile, costruire con lui un confronto che lo metta però a proprio agio, dove chi si mette nelle nostre mani si senta libero e ben disposto nel raccontarsi. Quante volte dalle storie degli ammalati sono emersi aspetti determinanti per la cura della malattia… Sono strade che rendono meno duro, anche se comunque difficile, pronunciare parole, ovvero diagnosi, che ogni volta non vorremmo dover dire».
Oriana invece era diretta. Non amava le incertezze. Sulla sua malattia non chiedeva indulgenza ma chiarezza. Era di un coraggio ammirevole. Non voleva sconti, soltanto conoscere. Quando cercavo di attenuare la gravità di quanto stava affrontando, la reazione era rabbiosa e furibonda. Visite, esami, code, anche se si spazientiva e si arrabbiava con medici e infermiere, in ospedale non aveva corsie preferenziali.
Conoscere Oriana Fallaci mi ha aiutato ad avere ancora più fiducia nel percorso che ho sempre considerato l’unico da praticare. Se vuoi affrontare in modo giusto la malattia, al paziente devi dire la verità. Certo, per farlo, devi essere aiutato. Al Memorial ci sono équipe di psicologi, sociologi, religiosi e assistenti sociali che intervengono nei momenti difficili. Che arrivano per tutti: chirurgo, oncologo, paziente, parenti, figli. Loro si prendono cura di te. Quando affronto casi complessi, che mi obbligano a far capire a chi sto curando o alla sua famiglia che quelli che seguiranno saranno mesi o anni dolorosi e difficili, mi rivolgo all’équipe. Senza questo supporto, i medici, da soli intendo, non potrebbero affrontare il dolore o lo stress che incontrano ogni giorno, e che non possono evitare. In teoria, per comunicare diagnosi inclementi avremmo bisogno almeno di un po’ di tempo, che però non è mai sufficiente. Se nel tuo ambulatorio hai decine di pazienti che aspettano di essere visitati, oppure sei stanco per un intervento chirurgico che si è rivelato più lungo e impegnativo del previsto, diventare brusco cercando di accorciare i tempi ti verrà quasi «naturale».
Anche quando di fronte a te c’è qualcuno che ha bisogno di essere ascoltato, che si aspetta delle rassicurazioni. E chi dovrebbe dargliele, se non il chirurgo al quale si è affidato? Ecco allora che il tempo che non hai, la fretta che il paziente avverte nelle tue parole, i modi sbrigativi con i quali leggi la sua cartella, rischiano di avere un effetto devastante; per quell’ammalato non sarai più il diretto interlocutore. Hai perso la sua stima. Dirò adesso qualcosa che deluderà molti, ma l’onestà di chi fa il medico richiede che si dicano anche cose sgradevoli. Anche se inconsciamente, credo che a volte il medico, con il proprio comportamento, coltivi la speranza che il paziente complicato «fugga», che cambi dottore.
So bene che tutto ciò è contrario al criterio etico in onore del quale abbiamo scelto questo tipo di lavoro. Con il giuramento di Ippocrate ci siamo proposti di fare, sempre, l’opposto. Se un paziente con una malattia grave richiede tempo e parecchie energie, quando ti avrà lasciato ti sentirai sollevato. Sarà un fardello che passa in carico ad altri. Ecco perché, per essere chiari e per affrontare momenti difficili, avrai bisogno di essere aiutato.
Sono da sempre convinto che, insieme alla biologia, alle tecniche chirurgiche e alle altre decine di materie, nella formazione dei medici l’insegnamento della psicologia dovrebbe trovare spazi ben più ampi. Ho letto che in Italia qualcosa si sta smuovendo, che sta cominciando a diventare realtà, ma è necessario che tutto questo venga inserito nei piani di studio dei nuovi medici. In una delle ultime visite che mi è capitato di fare, una paziente mi comunicava di aver cambiato medico di base. Le avevo chiesto di spiegarmi il motivo della sua decisione. «Con il dottore che avevo, non riuscivo a raccontare quello che sentivo. Adesso sono con un medico che mi sembra normale e mi sembra di parlare con un amico.»
Normale e amico. Gli aggettivi con i quali la donna ha descritto il suo nuovo «interlocutore» testimoniano una cosa soltanto: che ha trovato un bravo dottore. A noi viene chiesto solo questo.