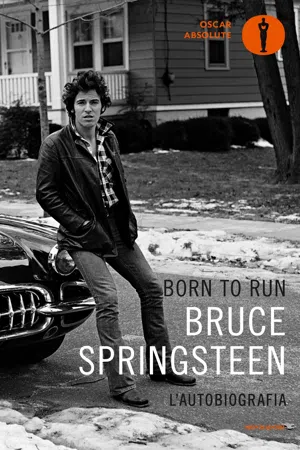Le crepe e le irregolarità del vecchio marciapiede di Randolph Street, la mia via, non hanno segreti per me. Ho dieci anni, e il pomeriggio divento Annibale che valica le Alpi, una squadra di soldati impegnati in un micidiale combattimento in quota, innumerevoli eroi del Far West che battono i sentieri rocciosi della Sierra Nevada. A pancia in giù, tra i minuscoli formicai che spuntano come vulcani dove terra e cemento s’incontrano, il mio mondo si allarga all’infinito. O meglio, fino alla casa di Peter McDermott all’incrocio tra la Lincoln e la Randolph, un isolato più in là.
Per queste strade mi spingevano con il passeggino, ed è qui che ho imparato a camminare, che mio nonno mi ha insegnato ad andare in bici e che ho mollato i miei primi cazzotti per poi darmela a gambe. Qui ho conosciuto l’intensità e il calore della vera amicizia, ho scoperto i miei pruriti sessuali e, le sere d’estate prima dell’avvento dell’aria condizionata, ho visto la gente radunarsi nelle verande per chiacchierare al riparo dalla canicola.
In epici tornei di bowling con palline di gomma rosa, ho colpito almeno cento volte l’elegante cordolo del marciapiede. Ho scalato le montagnole di neve sporca modellate dagli spazzaneve a mezzanotte, da un angolo all’altro, come un Edmund Hillary del New Jersey. Sbirciando dentro l’enorme portone in legno della chiesa, io e mia sorella abbiamo osservato a bocca aperta l’ininterrotta sequela di battesimi, matrimoni e funerali. Ho seguito mio nonno, un uomo attraente, dotato di un suo ruvido fascino, mentre faceva il giro dell’isolato sulle gambe malferme, la sua «rieducazione» dopo un ictus che gli aveva paralizzato contro il petto il braccio sinistro e dal quale non si sarebbe più ripreso.
Il nostro cortile, a pochi metri dalla veranda, vanta l’albero più grande della città, un imponente faggio rosso. Basterebbe un fulmine ben piazzato per schiacciarci come lumache sotto il mignolo di Dio. Nelle notti di pioggia, quando i tuoni rombano e le saette tingono di blu cobalto la camera in cui dormiamo tutti insieme, vedo le braccia del faggio muoversi e prendere vita nel vento tra i lampi bianchi. Preoccupato per il mio amico mostro là fuori, non riesco a chiudere occhio. Nei giorni di sole, le radici sono un fortino per i miei soldati, un recinto per i miei cavalli, la mia seconda casa. Sono il primo bambino dell’isolato a essersi arrampicato fino in cima, e ne vado fiero. Lassù c’è il mio rifugio: passo ore a spostarmi da un ramo all’altro, ascoltando le voci lontane dei miei amici sul marciapiede che valutano i miei progressi. Sotto i rami sonnolenti, nelle pigre serate estive ce ne stiamo seduti come cavalieri all’imbrunire, in attesa della campanella del gelataio e dell’ora di andare a letto. L’ultimo suono della lunga giornata è la voce della nonna che mi chiama: io salgo sulla veranda, varco la pesante porta d’ingresso e per un’ora o giù di lì mi siedo di fronte alla stufa a cherosene accanto al nonno in poltrona. Il piccolo televisore in bianco e nero illumina la stanza, proiettando i suoi fantasmi su pareti e soffitto. Piano piano mi addormento nel rifugio più grande e triste che abbia mai conosciuto, la casa dei nonni.
Abito qui con mia sorella Virginia, nata un anno dopo di me, i miei genitori Adele e Douglas Springsteen, i nonni Fred e Alice e il nostro cane Saddle. Viviamo letteralmente nel grembo della Chiesa cattolica: la canonica, il convento delle suore, la chiesa e la scuola elementare di St Rose of Lima sono tutti a una pallonata di distanza, al di là di un prato incolto.
Benché domini su tutti noi, qui Dio è circondato dagli uomini, o meglio dai folli. La mia famiglia occupa cinque case che insieme formano una «L», sul cui angolo sorge la chiesa in mattoni rossi. Quattro sono abitate da irlandesi della vecchia guardia, la gente che mi ha cresciuto: i McNicholas, gli O’Hagan, i Farrell. Di fronte, il solitario avamposto degli italiani che hanno reso la mia infanzia più colorita: i Sorrentino e gli Zerilli, arrivati da Sorrento passando per Ellis Island e Brooklyn. Lì abitano la mia nonna materna, Adelina Rosa Zerilli, e la sorella maggiore di mia madre, Dora, con il marito Warren (naturalmente irlandese) e la figlia Margaret, mia cugina, che è più grande di me. Margaret e Frank, l’altro cugino, ballano il jitterbug e sono talmente bravi che vincono concorsi e trofei in tutta la Jersey Shore.
Non che i due clan non vadano d’accordo, però è raro che attraversino la strada per passare del tempo insieme.
La casa in cui vivo con i nonni è di proprietà di «Nana» McNicholas, la mia bisnonna, una vecchietta arzilla che abita poco più avanti. Mi hanno raccontato che la prima messa e il primo funerale della città furono celebrati nel nostro soggiorno. A vegliare su di noi dall’alto provvede zia Virginia, la sorella maggiore di mio padre, investita da un camion a cinque anni di fianco al distributore di benzina mentre andava in triciclo. Appesa alla parete, la sua effigie infonde un’atmosfera spettrale alla stanza, un tragico promemoria del suo destino infausto durante le riunioni di famiglia.
Il serioso ritratto color seppia mostra una bambina agghindata con un abito in lino bianco d’altri tempi. Lo sguardo appare benevolo, ma alla luce di quanto accaduto sembra dire tutt’altro: «All’erta! Il mondo è un posto pericoloso e spietato che un bel giorno ti scaraventa giù dal triciclo e ti fa precipitare nel nero mistero della morte, e solo queste povere anime incaute e sventurate si ricorderanno di te». Un messaggio che sua madre, mia nonna, sentì forte e chiaro: dopo la morte della figlia rimase infatti due anni a letto, costringendo mio padre, un bambino rachitico, a trasferirsi fuori città a casa di alcuni parenti mentre lei si riprendeva.
Passarono gli anni. Quando ne aveva sedici, mio padre abbandonò la scuola e fu assunto come tuttofare alla Karagheusian, una fabbrica di tappeti piena di telai e macchinari assordanti che si allungava su entrambi i lati di Center Street, in un quartiere noto come «Texas». A diciott’anni andò in guerra, salpando da New York con la Queen Mary. Autista di camion durante l’offensiva delle Ardenne, vide quel poco di mondo che era destinato a vedere e tornò a casa, dove giocava a biliardo, e molto bene, per guadagnare qualche soldo. Conobbe mia madre, se ne innamorò e le promise che se lo avesse sposato si sarebbe trovato un lavoro vero (allarme rosso!). Insieme a suo cugino David «Dim» Cashion, si fece assumere alla catena di montaggio dello stabilimento Ford a Edison. E poi arrivai io.
Per mia nonna, ero il primogenito del suo unico figlio e il primo bambino in casa dopo la morte di Virginia. La mia nascita le aveva ridato una ragione per vivere, ecco perché si dedicò a me anima e corpo: la sua missione era proteggermi dal mondo interno ed esterno. Purtroppo, la sua devozione cieca e assoluta sarebbe diventata fonte di attrito fra lei e mio padre e di un’enorme confusione famigliare, con conseguenze nefaste per tutti noi.
Quando piove, l’aria umida trasporta l’odore di fondi di caffè bagnati proveniente dalla fabbrica della Nescafé al confine orientale della città. Il caffè non mi piace, ma quell’aroma sì: è rassicurante, unisce le persone del posto in un’esperienza sensoriale collettiva e rappresenta un esempio di industrializzazione positiva, come il fragore della fabbrica di tappeti che ci riempie le orecchie e ci dà lavoro, un segno della vitalità cittadina. Lo senti e lo fiuti: qui la gente vive, soffre, si gode i piccoli piaceri, gioca a baseball, muore, fa l’amore, ha figli, si ubriaca le sere di primavera e fa del proprio meglio per tenere alla larga i demoni che vogliono distruggerci insieme alle nostre case, alle nostre famiglie, alla nostra città.
È qui che abitiamo, all’ombra del campanile, dove la sacra pallina di gomma incontra la strada, benedetti dalla misericordia di Dio alla nostra maniera truffaldina. Un posto emozionante, dove calano i pantaloni e scoppiano sommosse razziali, dove l’originalità è detestata e noi ci sconvolgiamo l’anima, dove facciamo l’amore e facciamo paura, dove ci spezziamo il cuore... la città di Freehold, nel New Jersey.
Che la funzione abbia inizio.
È giovedì sera, la sera dell’immondizia. Siamo pronti a entrare in azione. Pigiati nella berlina anni Quaranta del nonno, stiamo per setacciare i mucchi di rifiuti che ingombrano tutti i marciapiedi della città. La prima tappa è Brinckerhoff Avenue, dove abitano i ricconi. Siamo a caccia di radio, di qualsiasi tipo e in qualsiasi condizione. Dopo averle recuperate dalla spazzatura, le gettiamo nel bagagliaio e le portiamo nell’«officina» del nonno, un cubicolo di legno non riscaldato di due metri per due. Inverno o estate che sia, qui accadono magie. Nella «stanza» piena di fili elettrici e canaline, me ne sto seduto a osservarlo con la massima attenzione. Mentre lui è impegnato a collegare, saldare e sostituire i circuiti rovinati, aspettiamo l’attimo in cui il soffio vitale, il meraviglioso ronzio sommesso delle interferenze e il caldo bagliore dell’elettricità riprenderanno a scorrere negli scheletri degli apparecchi che abbiamo salvato dall’estinzione.
Qui sul banco di lavoro, la resurrezione è qualcosa che si tocca con mano. Il silenzio si riempie delle voci remote e crepitanti dei predicatori domenicali, delle tirate degli imbonitori, della musica delle big band e del primo rock’n’roll, dei radiodrammi a puntate. Sono i suoni del mondo esterno che viene a cercarci nella nostra cittadina e nell’universo ermeticamente sigillato dell’87 di Randolph Street. Una volta riportati in vita, gli apparecchi vengono venduti per cinque dollari negli accampamenti dei migranti che d’estate spuntano come funghi nei campi agricoli al confine del quartiere. «L’uomo delle radio»: così è chiamato mio nonno fra la popolazione perlopiù di colore che ogni anno arriva in pullman dagli Stati del Sud per mietere i campi della contea rurale di Monmouth. Sulle stradine sterrate che portano alle baracche dove le condizioni di vita sono ancora quelle della Dust Bowl degli anni Trenta,1 mia madre accompagna il nonno menomato dall’ictus a fare affari con i «neri» negli «accampamenti di Topolino». Una volta ci sono andato anch’io e, in mezzo a tutti quei volti scuri ed esausti all’imbrunire, per poco non me la sono fatta sotto. I rapporti interrazziali non sono mai stati idilliaci a Freehold, ma fra dieci anni la tensione degenererà in sommosse e sparatorie. Per il momento, regna una quiete ininterrotta e preoccupante. Quanto a me, sono solo il nipotino privilegiato dell’«uomo delle radio», circondato dai clienti con i quali la mia famiglia tenta di sbarcare il lunario.
Benché io non ci pensassi mai, eravamo quasi poveri. Avevamo vestiti, cibo in tavola e un letto, e io avevo amici bianchi e neri che se la passavano ancora peggio. I miei lavoravano, mia madre come assistente in uno studio legale, mio padre alla Ford. Casa nostra era vecchia e destinata a diventare visibilmente decrepita. L’unica fonte di riscaldamento era una stufa a cherosene in soggiorno. Le mattine d’inverno, al risveglio nella camera al primo piano, si creavano le nuvolette di vapore con il fiato. Uno dei miei primi ricordi è l’odore del cherosene mentre il nonno caricava la stufa. Per cucinare ne usavamo un’altra a carbone. Da bambino spruzzavo la superficie rovente con la pistola ad acqua per guardare gli sbuffi di fumo. La cenere la ammucchiavamo dietro casa, ogni giorno andavo a giocarci e rientravo grigio di fuliggine. Avevamo una piccola ghiacciaia e uno dei primi televisori della città. Da giovane, prima che io nascessi, mio nonno era il proprietario dello Springsteen Brothers Electrical Shop: ecco perché, quando iniziarono a diffondersi le tv, eravamo stati fra i primi a possederne una. Mia madre mi raccontava che veniva gente da tutto l’isolato ad ammirare il nuovo miracolo: Milton Berle, Kate Smith, «Your Hit Parade», gli incontri di wrestling fra lottatori come Bruno Sammartino e Haystacks Calhoun. A sei anni sapevo a memoria When the Moon Comes Over the Mountain, il grande successo di Kate Smith.
In virtù dell’ordine di nascita e delle circostanze, in casa ero signore, padrone e messia. La nonna si era aggrappata al suo primo nipotino in quanto surrogato della piccola Virginia, la zia morta bambina. Non mi era proibito nulla: per un ragazzino era una libertà spaventosa, e io ne approfittavo a piene mani. A cinque, sei anni andavo a letto alle tre del mattino e mi svegliavo alle tre del pomeriggio. Guardavo la tv fino al termine dei programmi e rimanevo da solo a fissare il monoscopio. Mangiavo ciò che volevo, quando volevo. Io e i miei genitori eravamo diventati parenti alla lontana: nella sua confusione e nel desiderio di non turbare la quiete, mia madre mi affidava completamente all’autorità della nonna. Come un piccolo tiranno in miniatura, non tardai a convincermi che le regole fossero destinate agli altri, quanto meno finché papà non tornava a casa. A quel punto diventava lui il burbero signore della cucina, un monarca deposto dal suo stesso primogenito istigato dalla madre. Il rudere in cui abitavamo, le mie stravaganze e il potere che detenevo in età così tenera erano per me fonte di vergogna e imbarazzo. Il resto del mondo scorreva su binari diversi, me ne rendevo conto, e gli amici del quartiere mi prendevano in giro senza pietà per le mie abitudini. Adoravo la mia posizione, ma sapevo che non era giusto.
Quando dovetti andare a scuola, l’obbligo di rispettare una rigida tabella di marcia mi riempì di una rabbia che mi avrebbe accompagnato per quasi tutti gli anni di studio. Mia madre sapeva che era giunta l’ora della resa dei conti, e le va dato atto di aver provato in ogni modo a riaffermare il suo ruolo. Io e lei ci trasferimmo in metà di una shotgun house2 al 39½ di Institute Street: niente acqua calda, quattro stanze minuscole a quattro isolati dai nonni. Mamma tentò di stabilire delle regole normali, ma era troppo tardi. Quei quattro isolati mi sembravano un milione di chilometri. Ribollivo di rabbia e nostalgia e non perdevo occasione di tornare dai nonni: la mia vera casa era quella, quelli i miei veri genitori. Non potevo e non volevo lasciarli.
L’unico locale decoroso era il soggiorno, il resto era abbandonato e cadeva a pezzi. Per fare i bisogni c’era un unico gabinetto gelido e pieno di spifferi, e niente vasca da bagno funzionante. I nonni vivevano in uno stato di sporcizia e trascuratezza che oggi mi farebbe inorridire. Ricordo ancora quanto mi spaventava e mi imbarazzava la biancheria intima macchiata stesa dietro casa, simbolo di un’impropria intimità fisica ed emotiva che rendeva la casa dei nonni un luogo disorientante quanto irresistibile. Eppure li adoravo, loro e quella casa. La nonna dormiva su un vecchio divano a molle, io rannicchiato di fianco a lei, il nonno su una brandina dall’altra parte della stanza. Tutto qui: a tanto si riduceva la mia infanzia sfrenata. Era tra quelle mura che mi sentivo al mio posto, amato e al sicuro.
La potenza lancinante e ipnotica di quel luogo disastrato e di quella coppia di persone non mi avrebbe più abbandonato. Ancora oggi la rivivo regolarmente nei sogni, e la nostalgia mi attanaglia. La casa dei nonni mi donava un senso di sicurezza assoluta, di libertà sconfinata e di un amore malato quanto indimenticabile. Fu la mia rovina, ma anche la mia fortuna. La mia rovina, perché avrei dedicato il resto della vita a stabilire dei limiti che mi permettessero di condurre un’esistenza e intrattenere relazioni sufficientemente normali. La mia fortuna, perché avrei dedicato il resto della vita a cercare un posto tutto mio, uno sfogo per la rabbia che mi covava dentro, trovandolo nella musica: un tentativo disperato e ininterrotto di ricostruire il mio tempio sicuro sulle ceneri della memoria e del rimpianto.
Per amore della nonna avrei abbandonato i miei genitori, mia sorella e gran parte del mondo, finché quel mondo non mi crollò addosso. I nonni si ammalarono, e l’intera famiglia tornò a vivere insieme, questa volta al 68 di South Street, di nuovo una metà casa. Di lì a poco nacque mia sorella Pam, il nonno morì e la nonna contrasse il cancro. Il futuro della mia casa, del mio cortile, del mio albero, della mia polvere, della mia terra e del mio santuario era segnato: il terreno fu venduto per costruirvi un parcheggio per la chiesa di St Rose of Lima.
Tra i nostri percorsi in bicicletta ce n’era uno che ci portava attorno alla chiesa e alla canonica, per poi tornare indietro fiancheggiando il convento delle suore con il suo splendido vialetto in ardesia azzurra, i cui bordi leggermente rialzati imprimevano al manubrio una vibrazione che batteva a ritmo sotto le dita: bump-ump-ump-ump... Poi ricominciava il cemento, e via con un altro giro. Quanti sonnolenti pomeriggi passavamo a entrare e uscire dal perimetro della St Rose, ascoltando le suore che ci gridavano di tornare a casa e facendo lo slalom tra i gatti randagi che vagavano fra il seminterrato della chiesa e il mio soggiorno. Non avendo più molto da fare, il nonno ammazzava il tempo cercando pazientemente di attirare quelle creature selvagge nel cortile. Riusciva ad avvicinarsi a felini rabbiosi che si tenevano alla larga da qualsiasi altro essere umano, ma a volte la pagava. Una sera rincasò con un taglio di trenta centimetri sul braccio: glielo aveva procurato un micetto che non era pronto a ricambiare le sue attenzioni.
I gatti facevano la spola tra casa mia e la chiesa, proprio come noi la facevamo tra la scuola, casa, la messa e di nuovo la scuola: le nostre vite erano inestricabilmente legate a quella della chiesa. Nei primi anni preti e suore non erano che volti gentili, sorridenti e piacevolmente misteriosi che ti osservavano nel passeggino, ma con l’inizio della scuola cominciai a frequentare le buie sale della comunione: l’incenso, i crocifissi, il dogma memorizzato fino alla nausea, la Via Crucis del venerdì (i compiti in classe!), uomini e donne in abito talare nero, la tendina del confessionale, lo sportello scorrevole, il volto del sacerdote nell’ombra e l’enumerazione dei peccati infantili. Se ripenso alle ore trascorse a comporre un elenco di trasgressioni da recitare a comando... Trasgressioni abbastanza gravi da essere credibili... ma non troppo, il meglio doveva ancora arrivare! Quanti peccati potevi aver commesso in seconda elementare? L’obbligo di confessarmi dal lunedì alla domenica nella chiesa di St Rose of Lima non tardò a stufarmi e mi mise addosso un desiderio irrefrenabile di andare via. Già, ma dove? Non c’è nessun «via», io abito...