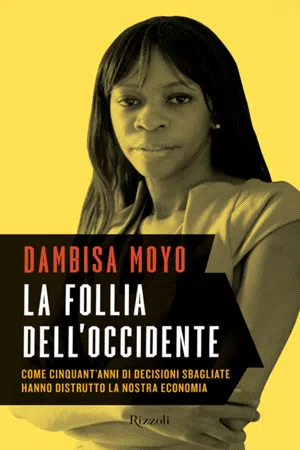![]()
PRIMA PARTE
Il mondo di una volta
![]()
1
C’era una volta l’Occidente
C’è stato un tempo in cui l’Occidente aveva tutto: il denaro, l’intelligenza politica, la potenza militare. Sapeva che cosa voleva e aveva la forza per ottenerlo. Che il primato spettasse di volta in volta al Portogallo, alla Spagna, ai Paesi Bassi o all’Inghilterra, le cose sono andate così per cinquecento anni. La storia del predominio occidentale nella seconda metà del XX secolo, in compenso, è la storia degli Stati Uniti d’America.1
Si può pensare alle truppe statunitensi che si riversano sulle coste della Normandia al fianco delle forze alleate, o all’Enola Gay che sgancia la bomba su Hiroshima: sta di fatto che alla fine della Seconda guerra mondiale lo scettro del potere globale (economico, politico e militare) passa dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti. Da allora, a dispetto di una Guerra fredda destinata a durare quasi cinquant’anni, gli Stati Uniti manterranno quasi ininterrottamente una posizione di assoluta preminenza, e l’alba del XXI secolo li vede ancora protagonisti.
Nella fase che prelude alla Seconda guerra mondiale, come è noto, gli Stati Uniti avevano subito il contraccolpo della Grande depressione del 1929 (nel 1933 il valore dei titoli scambiati nella Borsa di New York era inferiore al 20% dei massimi registrati nel 1929, e la disoccupazione era salita al 25%), senza parlare del trauma e delle vittime della Grande Guerra. Il New Deal patrocinato dal presidente Roosevelt, pur non mettendo fine alla crisi degli anni Trenta, rappresentò un tentativo per ricostruire il capitalismo americano e dare un ruolo nuovo e più dinamico alla mano invisibile (ma non troppo) del governo. Nel suo intimo l’America continuava a credere nella libera impresa, ma l’idea era di assegnare al governo un ruolo chiave nell’orchestrazione, nella supervisione e nella direzione di un’economia barcollante: il governo avrebbe dovuto guidare l’impresa privata, non adeguarsi a essa, e gestire nuovi progetti di larghissimo respiro. Queste misure avrebbero preparato l’America ad affrontare la guerra che avrebbe stroncato l’Europa occidentale, consentendole perfino di trarne grandi vantaggi.2
Fu così che allo scoppio della Seconda guerra mondiale, a dispetto di alcune debolezze residue, l’America si trovò nella posizione migliore per coordinare i settori industriali, militari e manifatturieri in vista del massimo utile economico. Da questo punto di vista il conflitto non fu visto soltanto come una necessità politica e militare, ma anche come un’opportunità economica che il Paese era pronto a cogliere.
Nel 1941, per esempio, il presidente Roosevelt promulgava la legge Affitti e prestiti, che regolamentava la vendita, lo scambio, la locazione e il prestito di tutto l’equipaggiamento militare che gli alleati dell’America avrebbero ritenuto necessario. Sotto gli auspici di questo programma, tra il 1941 e il 1945 gli Stati Uniti trasportarono oltreoceano a beneficio dei loro alleati sotto assedio materiale bellico per 50 miliardi di dollari (equivalenti a 700 miliardi di dollari del 2007): navi da guerra, mitragliatrici, torpediniere, sottomarini e perfino stivali. Con la legge Affitti e prestiti l’Europa si sobbarcava un impegno gravoso in termini di risarcimenti futuri (la Gran Bretagna ha versato l’ultima rata del suo debito complessivo di 83,83 miliardi di dollari soltanto il 31 dicembre 2006, a cinquant’anni di distanza), e nel Dopoguerra, soprattutto negli anni Cinquanta, l’economia Americana era ai suoi massimi storici. Grazie alla legge Affitti e prestiti (il piano Marshall, naturalmente, fu un’operazione del tutto indipendente) gli Stati Uniti avevano conquistato il primo posto nella produzione industriale.3
Le misure adottate dall’America conciliavano abilmente imperativi politici e accortezza economica. La fabbricazione di merci destinate all’Europa non fu soltanto un gesto politico a sostegno degli Alleati, ma contribuì inoltre a far ripartire l’economia del Paese. Di fatto i risultati del «grande intervento americano» furono strabilianti sotto quasi tutti i punti di vista. Grazie alla domanda mondiale di prodotti statunitensi l’economia stagnante degli Stati Uniti si trasformò in un’instancabile fucina di merci.
Negli ultimi mesi del 1944 il tasso di disoccupazione si era ridotto al 1,2% della forza lavoro civile, un minimo storico che non è mai più stato raggiunto (nei giorni più bui della Grande depressione più di 15 milioni di americani, pari a un quarto della forza lavoro del Paese, si trovavano senza lavoro). Il Pil degli Stati Uniti passò dagli 88,6 miliardi di dollari del 1939 a 135 miliardi di dollari nel 1944: un tasso composto di crescita dell’8,8% annuo nell’arco di soli cinque anni! Questo significa che tutte le risorse erano investite nella produzione industriale, e anche le trasformazioni scientifiche e tecnologiche si intensificarono. Alla fine della guerra il resto del mondo era sull’orlo del tracollo: il Giappone versava in condizioni disperate, l’Europa era in bancarotta e la Gran Bretagna si ritrovava al verde. Restava l’America, che si poneva in modo indiscutibile come la potenza economica per eccellenza.
Detto brutalmente, l’unica cosa che l’America ha perso nella Seconda guerra mondiale sono state le vite dei suoi soldati. E anche da questo punto di vista, in confronto agli altri Paesi belligeranti, le perdite risultano contenute. Su un totale di 72 milioni di vite stroncate dal conflitto, le vittime americane furono soltanto 416.800, pari allo 0,32% della popolazione. Sul piano politico, militare ed economico, in compenso, la vittoria degli Stati Uniti è stata schiacciante.4 Da questo punto di vista la guerra fu, perversamente, un colossale successo.
L’America uscì dal conflitto mondiale con le casse traboccanti di denaro. Come osserva lo storico economico Alan Milward: «Nel 1945 gli Stati Uniti conquistano una posizione economica infinitamente più forte rispetto al 1941. […] Nel 1945 erano ormai gettate le basi per un predominio statunitense che sarebbe durato per i venticinque anni a venire. […] Dal punto di vista del Dopoguerra è forse questa la conseguenza più duratura del Secondo conflitto mondiale».
Intorno alla metà degli anni Cinquanta, tra le altre cose, era l’America a finanziare la ricostruzione dell’Europa prostrata dalla guerra, mentre al tempo stesso si affermava come principale Paese esportatore di norme culturali e know-how tecnologico. Il Novecento sembrava annunciarsi come il secolo americano, e così è stato.
Non solo il territorio statunitense era rimasto immune dai danni collaterali legati al conflitto (facendo così risparmiare al Paese i miliardi di dollari che la ricostruzione delle infrastrutture avrebbe richiesto), ma il fatto che l’America fosse stata in grado di vincere il conflitto, finanziare i suoi alleati in tempo di guerra e avviare il piano Marshall (un programma di aiuti all’Europa che prevedeva lo stanziamento dell’equivalente di 100 miliardi di dollari odierni, pari al 5% circa del Pil statunitense nel 1948) è una prova di quanto immensamente ricco fosse diventato il Paese.
Christopher Tassava ha scritto: «Forti di un’economia potenziata dall’espansione industriale innescata dal conflitto […], un’economia senza rivali nel mondo per dimensioni e ricchezza, gli uomini alla testa dell’America decisero di fare degli Stati Uniti il fulcro dell’economia mondiale del dopoguerra». La Guerra fredda sarebbe proseguita per altri cinquant’anni, ma in ultima analisi fu proprio questa strategia a prevalere. Uscita pressoché intatta dalla Seconda guerra mondiale, favolosamente ricca, l’America surclassava largamente ogni altro Paese. Il mondo era nelle sue mani.
L’ascesa che l’America conosce in questa fase si riflette a tutti i livelli della società. La sua forza, la sua determinazione e la sua energia erano tali da permeare e impregnare di sé ogni sfera dell’attività umana nel mondo che faceva capo all’Occidente. I decenni successivi, gli anni Cinquanta e Sessanta, ne sono la dimostrazione lampante. In ambito politico si apre l’era della consapevolezza sociale e del movimento per i diritti civili, sul piano culturale si assiste a rivoluzioni nel campo della musica, della letteratura e dell’arte, e le innovazioni venute dall’America dominano la scienza e la tecnologia, che si tratti di mandare un essere umano sulla luna o di perfezionare la bomba atomica.
Il successo del progetto Manhattan e le innovazioni prodotte dalla corsa agli armamenti nucleari annunciavano un’epoca segnata dal primato indiscutibile dell’America in campo scientifico e tecnologico. Il volume di esportazioni degli Stati Uniti sale da 9993 milioni di dollari nel 1950 a 19.626 milioni nel 1960. Tale espansione, verificatasi nell’arco di un solo decennio, era sostenuta da un incremento della formazione del capitale fisso lordo, che da 58 miliardi di dollari nel 1950 sale a 104 miliardi di dollari nel 1960.
Nel trentennio che va dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta l’America esercita la sua influenza in ogni settore. I simboli della potenza americana sono dovunque, in patria come all’estero, dai grandi complessi industriali come General Motors, Ford Motor Company, Mobil Oil, International Business Machines, United Fruit Company e Dow Chemicals all’industria cinematografica hollywoodiana e all’industria discografica, simboleggiata dall’etichetta Motown. E il mondo degli affari era solo un aspetto tra i tanti.
Per il tramite dei Peace Corps fondati nel 1961 l’America impone al mondo il marchio della sua autorità morale, servendosi di giovani volontari come di canali per l’esportazione dei propri valori in tutti i Paesi che gli americani giudicavano troppo diversi. La missione, sulla carta, era «promuovere la pace e l’amicizia nel mondo per mezzo di corpi di pace che metteranno a disposizione dei Paesi e dei territori interessati uomini e donne di nazionalità statunitense specificamente addestrati a servire all’estero e decisi ad aiutare questi Paesi, se necessario anche nelle condizioni più dure, a soddisfare il loro fabbisogno di forza lavoro specializzata». I Peace Corps, tuttavia, non sono certo l’unico canale per cui passa l’esportazione dei valori americani. Gli Stati Uniti hanno invaso militarmente la Corea, e la guerra in Vietnam resta ancora oggi una macchia indelebile sulla coscienza americana. È indubbio, tuttavia, che l’America si stava facendo sempre più sicura di sé, esercitando un potere senza rivali al di là dei suoi confini.
Tra luci e ombre, questa è l’epoca di quella che il giornalista americano Tom Brokaw ha chiamato «la più grande delle generazioni»: la generazione degli americani che avevano combattuto nella Seconda guerra mondiale ed erano poi rientrati in patria per fare dell’America il più grande Paese del mondo. Per mezzo secolo sembrò trattarsi di un successo senza ombre: l’America era il simbolo della ricchezza, del potere e del predominio culturale, e la sua influenza tentacolare raggiungeva gli angoli più remoti del mondo. Il resto dell’Occidente era saldamente installato nell’orbita degli Stati Uniti: come avrebbe mai potuto sottrarsi alla loro presa, sfuggire all’effetto ipnotico della loro potenza e del loro splendore? L’America era il sole intorno al quale ruotavano tutti gli altri Paesi.
Le stagioni difficili si alternavano a quelle prospere, ma l’America restava impassibile. Dalla crisi petrolifera degli anni Settanta all’indebitamento o al crollo della Borsa di Wall Street negli anni Ottanta, senza parlare della caduta del comunismo negli anni Novanta, con la quale irrompevano sulla scena i suoi più agguerriti avversari economici, l’America sembrava inespugnabile. Una situazione che l’America stessa aveva deliberatamente costruito mettendo a frutto la sua potenza militare, la sua capacità industriale, coadiuvata da un capitalismo votato al libero mercato, e il suo monopolio culturale: un’intera epoca porta il marchio «made in America».
Facciamo ora un salto in avanti e torniamo ai giorni nostri: come sono cambiate le cose! I Paesi occidentali barcollano sull’orlo di una catastrofe economica dalle proporzioni incalcolabili, la popolazione invecchia e ha sempre meno risorse sulle quali contare, molte riforme indispensabili restano politicamente impopolari e la supremazia economica dell’Occidente è messa a repentaglio dalle sfide lanciate dal resto del mondo, e in una misura impensabile fino a pochi anni fa.
Anche in passato non sono mancati i momenti difficili, come la crisi dei risparmi e dei mutui negli anni Ottanta e Novanta, ma la recente crisi finanziaria e le politiche che gli Stati Uniti continuano imperterriti a praticare sono la prova incontrovertibile del fatto che l’America sta rapidamente perdendo la sua presa sul resto del mondo. Nel corso del primo decennio del XXI secolo si è andata trasformando in un’area finanziariamente debole ed economicamente vulnerabile, tanto da contagiare come sangue infetto il resto della collettività politica occidentale, trasformando inevitabilmente il proprio declino in quello dell’Occidente di fronte ai Paesi di recente sviluppo e in rapida ascesa. Ciononostante, continuano a esserci buone ragioni per scommettere sugli Stati Uniti tra tutti i Paesi del blocco occidentale, e per ritenere che negli anni a venire l’America sarà economicamente più forte delle sue controparti europee.
Quali sono però, in termini economici, le forze che alimentano la crescita?
Le colonne portanti della crescita
Si è tanto parlato del declino economico dell’Occidente industrializzato, in particolare degli Stati Uniti, cui si contrappone l’«ascesa dell’Oriente», Cina in testa: un fenomeno che a molti appare inevitabile. Il dibattito si è imperniato perlopiù sulle grandi tendenze storiche dell’imperialismo, e su considerazioni di natura strategica e militare, eppure anche i modelli canonici usati per la descrizione della crescita economica forniscono un quadro efficace per evidenziare come l’Occidente continui ancora oggi a sfruttare in modo sbagliato gli ingredienti chiave di un successo e di una crescita economica sostenibili sul lungo periodo, con suo grave danno.
L’evoluzione della teoria economica della crescita è un fenomeno affascinante, e sarebbe impossibile darne conto in modo adeguato in queste poche pagine. Una sua prima incarnazione nella letteratura specialistica si è avuta con il pensiero di Harrod-Domar, che faceva della crescita una funzione esclusiva di un unico input: il capitale.
Nel 1956 un americano, Robert Solow, docente al Massachusetts Institute of Technology, ha ulteriormente elaborato questo modello fondato su un solo input dimostrando che anche il fattore lavoro aveva un ruolo determinante e specifico nella crescita economica. Nel 1987 Solow ha ricevuto il Nobel per l’economia per «il suo contributo alla teoria della crescita economica», e per molti anni il modello da lui messo a punto, secondo il quale la crescita è determinata dal capitale e dal lavoro, ha costituito la spina dorsale della letteratura sulla crescita in macroeconomia.
Quale non fu la sorpresa degli esperti, tuttavia, quando una serie di verifiche empiriche dimostrarono che questa teoria della crescita, in apparenza tanto logica, bastava al massimo a spiegare il 40% della prosperità di un Paese. Mancava qualcosa, e questo elemento mancante era tutt’altro che trascurabile. Il fattore ancora sconosciuto – responsabile dell’altro 60% – è oggi noto come «produttività totale dei fattori», una nozione molto ampia che abbraccia lo sviluppo tecnologico e tutta una serie di elementi non riducibili al capitale e al lavoro, come la cultura e le istituzioni. I modelli economici standard, insomma, designano tre ingredienti fondamentali per la crescita economica: il capitale, il lavoro e la produttività totale dei fattori.5 Sono questi i pistoni che scorrono nei cilindri della crescita economica. Se opportunamente calibrati e indotti a lavorare di concerto, alimentano un motore dalla potenza pressoché infinita.
L’esempio migliore della forza portentosa e delle potenzialità sprigionate dalla combinazione di queste tre elementi è probabilmente lo sbarco americano sulla Luna del luglio 1969. Nessuna sfida poteva essere più ambiziosa di quella lanciata dal presidente Kennedy, che nel 1961 si era impegnato a mandare un uomo sulla Luna entro la fine del decennio. Pungolato dai risultati a prima vista superiori del programma spaziale sovietico – il primo oggetto inviato nello spazio, lo Sputnik I (1957), poi la prima creatura vivente, la cagnetta Laika (1957) e naturalmente il primo uomo, Yuri Gagarin (1961) – Kennedy catturava lo spirito dei tempi con le sue celebri parole: «Se tra molti altri progetti abbiamo deciso di andare sulla Luna entro la fine del decennio non è perché sia facile, ma perché è difficile».
La storia del programma Apollo, i personaggi che a questo hanno legato il proprio nome, lo spirito di avventura che lo animava restano uno dei momenti più gloriosi della storia americana (e mondiale), e per valide ragioni.6 Al tempo stesso, però, essa è un esempio insuperabile di confluenza virtuosa di capitale, lavoro e tecnologia, tutti e tre al massimo delle loro potenzialità e operanti in perfetta armonia. L’America aveva a disposizione il capitale, la forza lavoro e soprattutto la tecnologia. I dati e le cifre sono quanto di più eloquente.
In termini di capitale i costi del progetto Apollo sono astronomici. Il budget annuo della Nasa fu portato da 500 milioni di dollari nel 1960 a un massimo di 5,2 miliardi nel 1965, una cifra pari al 5,3% del bilancio federale di quell’anno (in valuta odierna il 5% del bilancio americano di oggi sarebbe qualcosa come 125 miliardi di dollari). Per fare un confronto, si calcola che la guerra in Vietnam sia costata nel complesso 111 miliardi di dollari (equivalenti a 686 miliardi di dollari del 2008). A conti fatti, il costo totale del progetto Apollo si è aggirato tra i 20 e i 25 miliardi di dollari del 1969 (circa 135 miliardi di dollari del 2005).
Il denaro, tuttavia, è solo un aspetto della sfida lanciata con il progetto Apollo. Per raggiungere l’obbiettivo l’America doveva attingere ad altre due risorse essenziali: il lavoro e la tecnologia. Fortunatamente per lei, era in grado di farlo.
Fu ingaggiato un autentico esercito. Nel 1966 il personale civile della Nasa era salito dai 10.000 dipendenti impiegati nel 1960 a 36.000. Il programma spaziale esigeva inoltre il ricorso a migliaia e migliaia di tecnici e scienziati esterni. Tra il 1960 e il 1965 il numero di individui al lavoro sul programma spaziale della Nasa è più che decuplicato, passando da 36.000 unità a uno strabiliante picco di 376.000.
Il punto cruciale, tuttavia, non è il fatto che la Nasa avesse bisogno di coinvolgere un volume di talento così impressionante, ma piuttosto che abbia potuto farlo. Dove non ce n’era a sufficienza, la Nasa provvedeva a crearlo. Il nuovo personale proveniva per la maggior parte da industrie private, istituti di ricerca e università.
Fu questa forza lavoro a inventare e mettere a punto la tecnologia che avrebbe catapultato gli Stati Uniti in testa alla corsa allo spazio, portando Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna, un’impresa ricordata ancora oggi come il più grande successo tecnologico nella storia dell’umanità.
Le prodezze tecnologiche dispiegate dal programma Apollo erano davvero qualcosa di impressionante. Circa un quinto della popolazione mondiale seguì con il fiato sospeso la trasmissione in diretta del primo allunaggio, anche se i retroscena del progetto, come la brillante tecnologia che aveva reso possibile l’impresa, erano in gran parte al di là della loro comprensione.
Prima di divenire realtà l’idea di uno sbarco sulla Luna era passata per anni di prove, prototipi e non pochi fallimenti. Dagli enormi razzi Saturn, talmente potenti che avrebbero potuto proiettare nello spazio un cacciatorpediniere americano, al modulo Lem che permise a due uomini di 75 chili ciascuno di allunare, senza dimenticare le centinaia di migliaia di componenti e parti che richiesero ricerche, progetti, prototipi e test, la vastità e la complessità dell’apparato dispiegato dal progetto Apollo erano tali da mozzare il fiato.
La cosa non finisce qui, però, perché il programma stimolò l’innovazione in molte aree tecnologiche indirettamente afferenti all’ingegneria aerospaziale e all’astronautica, come per esempio l’avionica, le telecomunicazioni e l’informatica, oltre che nel campo dell’ingegneria, dei metodi statistici, della meccanica e dell’elettronica. In tutto questo si vede all’opera il potere delle idee. Al di là della messa a punto di macchine o congegni determinati, il vero progresso tecnologico è nell’effetto a macchia d’olio. E dal momento che un’idea, una volta resa pubblica, può venire utilizzata da chiunque in qualunque luogo, il costo marginale di un’idea è pari a zero.
Nessun altro Paese, anche se l’...