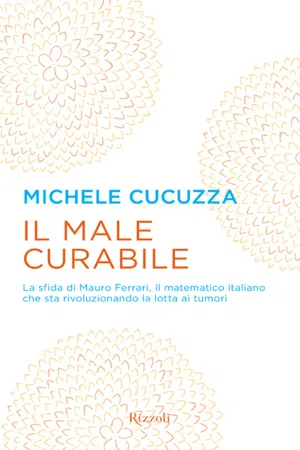![]()
1
L’ultima frontiera
Le nanotecnologie che aiutano a sconfiggere il cancro
Dall’oblò dell’aereo, Houston appare immensa e singolare. Tre fungaie di grattacieli separate da vastissime aree verdi popolate da migliaia di villette, quasi tutte con la piscina. Immancabili, e comunque sorprendenti, le reti di autostrade, gigantesche, che scorrono intrecciate a quattro-cinque corsie per senso di marcia, fino al cuore della città. Sindaco donna (Annise Parker, gay dichiarata), Houston è la quarta metropoli degli States per numero di abitanti (sei milioni) e la più popolosa del ricchissimo Stato petrolifero del Texas, il più esteso, dopo l’Alaska, e l’unico a mantenere un forte orgoglio nazionale (chi vive da queste parti dice di sé «noi texani», non «noi americani»).
Il caldo di agosto non perdona, l’umidità è altissima. Non si fa fatica a immaginare frequenza e dimensioni degli incendi che anche quest’estate tormenteranno il Lone Star State. Puntiamo verso una delle tre skyline di torri, evitando, per ora, sia il downtown, la city finanziaria, impreziosita da musei e teatri, sia l’uptown, dove accanto ai consolati sorge la Galleria, uno dei più vasti e sofisticati centri commerciali d’America. Sarà certamente vero, come è solito dire il professor Ferrari, che a Houston non c’è un fiume né una collina che abbelliscano il paesaggio, e l’oceano è pure lontano, tuttavia, così ricca di alberi e con i suoi quartieri ben ordinati, la città non è priva di fascino.
Attraversato l’Hermann Park, con il suo laghetto e lo zoo, e il vastissimo campus della Rice University, una delle più prestigiose d’America, che possiede pure uno stadio da centomila posti, addentrandoci lungo Main Street e poi sulla parallela Fannin, percorsa da jumbotram ultramoderni, ci ritroviamo nel cuore del Texas Medical Center, il più grande agglomerato sanitario d’America, probabilmente del mondo.
Cinquantuno tra grattacieli e palazzoni, altri sette in costruzione, strutture avveniristiche, alcune collegate tra loro da panoramici passaggi pedonali sopraelevati: facciate in vetro e metallo, oltre alle più classiche strutture in cemento. Fuori, cascatelle d’acqua, verde e statue di bronzo dappertutto. Dentro, sale spaziosissime, desk e immense lobby d’accoglienza. Non sono grandi hotel di lusso, ma il Texas Children’s, uno dei primi tre ospedali pediatrici degli Stati Uniti, il Baylor College of Medicine, una delle più quotate scuole di specializzazione americane, il John McGovern, il Jan & Dan Duncan Neurological Research, il Saint Luke Episcopal Hospital, l’UN Dental Branch e molti altri ancora, alcuni nosocomi, altre istituzioni accademiche o per la formazione. Tutte strutture sanitarie non-for-profit, non a scopo di lucro, statali e private. Qui, duecentomila persone tra medici, ricercatori, tecnici e infermieri – l’equivalente dell’intera popolazione di una città come Brescia – accolgono ogni anno più di sei milioni di pazienti, tra i quali decine di migliaia di stranieri. Al Texas Medical Center, ogni anno si spende, per la sola ricerca, la sbalorditiva cifra di sei miliardi di dollari, l’equivalente del budget complessivo del nostro Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche. Qui, c’è l’ospedale con il più grande istituto di studi sul cancro al mondo, l’MD Anderson Cancer Center, dell’Università del Texas, che sul suo logo ha sbarrato con un tratto rosso la parola «cancro», un auspicio che è un inno alla speranza ma anche al proprio impegno incessante nella ricerca e nella cura.
In questa zona di Houston, Michael DeBakey e Denton Cooley eseguirono decine di trapianti di cuori umani, rivaleggiando tra loro e con Christian Barnard, alla fine degli anni Sessanta. Più recentemente, qui è tornata in buone condizioni Gabrielle Giffords, la parlamentare democratica gravemente sfigurata in viso nella strage di Tucson, costata la vita a sei persone, nel gennaio 2011. Tutto questo, nel quinto Stato al mondo, dopo gli Usa nel loro insieme, il Giappone, la Germania e la Gran Bretagna, per gli investimenti nella lotta al cancro e dove, a differenza che negli altri Stati americani, in cui si è risaliti solo da poco all’8,3 per cento di disoccupazione, sono stati creati migliaia di nuovi posti di lavoro: eppure, sempre qui, per un incredibile paradosso, c’è il record nazionale di cittadini privi di assistenza sanitaria. Il governatore Rick Perry, 235 condanne a morte autorizzate, ritiratosi nel gennaio 2012 dalla corsa alla nomination repubblicana per sfidare Obama, abrogherebbe subito, «con un decreto presidenziale esecutivo», la riforma dell’assistenza pubblica faticosamente avviata dal presidente, ma ha nel frattempo promosso la vaccinazione a tappeto delle adolescenti contro il Papilloma virus.
In questa straordinaria città della medicina, al 6670 della Bertner Avenue, si staglia l’imponente vetrata azzurrina e parabolica (quasi un sipario al nuovissimo edificio bianco dell’ospedale alle sue spalle) dei dodici piani del Methodist Hospital Research Institute, inaugurato il 1° ottobre 2010 e sorto in due anni dove prima c’era un parcheggio: è il centro di ricerca di cui Mauro Ferrari è presidente e amministratore delegato.
«Il nostro obiettivo è cambiare il futuro della medicina»: lo ritrovo in camice bianco sopra la giacca e la cravatta, sorridente, l’aria professionale ma distesa, più «ufficiale» che nei giorni di Gagliato, al podio con la scritta «President and Ceo», in una grande aula con i banchi a emiciclo, una parete semisommersa di trolley. Sono quelli della cinquantina di studenti, tra i diciotto e i ventidue anni, che lo stanno ascoltando: venti arrivano dal Messico, dalla più grande università tecnologica di quel paese, la Monterrey Tech, altri dall’Ucla (University of California, Los Angeles), altri ancora dalla stessa Università di Houston e da un’altra decina di campus. Partecipano a una giornata speciale sulla ricerca dedicata a loro, a conclusione di un programma di sei settimane, la Summer Student Retreat. Componenti organiche nel respiro, diagnostiche per monitorare la resistenza all’insulina, comportamenti da adottare a casa dopo un ricovero in ospedale: questi – tra gli altri – gli argomenti che hanno approfondito nei loro college. Il confronto continuo con i più giovani, lo abbiamo già visto in Calabria, è per Ferrari un tratto essenziale del modo di vivere la sua professione. «Questo è un posto dove possono succedere cose strane» prosegue il professore nel suo discorso di benvenuto. I ragazzi ridono, ma subito annuiscono: «È dalle cose inusuali che possono nascere eventi di portata straordinaria» sottolinea Ferrari.
Quattrocentoquarantamila metri quadrati, centocinquanta banchi per la ricerca, più di mille tra medici e ricercatori, promotori di settecento sperimentazioni già in corso, insieme a novanta principal investigators, «cacciatori» di progetti scientifici finanziati da enti e università. La carta d’identità del Methodist, come tutti lo chiamano a Houston, non ci fa troppo sorprendere di un’altra entusiastica rassicurazione rivolta da Ferrari agli studenti: «Qui non ci sono valli della morte, dove idee belle e nuove non riescono a diventare realtà». Specializzato nella ricerca sui cancri già in metastasi, le malattie cardiovascolari e infettive, il diabete e le disfunzioni del metabolismo, la medicina rigenerativa, la ricerca sulle proteine e, ovviamente, la nanomedicina, il Methodist è immediatamente adiacente all’ospedale che porta lo stesso nome, un’istituzione fondata un secolo fa dalla Chiesa Metodista in un’area dove altro non c’era se non una fabbrica di cotone e prateria sconfinata. Un modo concreto per far del bene alla gente, per tradurre in azione la filantropia richiesta ai più ricchi dal credo protestante. Naturalmente, oggi non c’è nessun obbligo di praticare una religione in particolare: sono rappresentate tutte, e i medici, gli infermieri, i pazienti possono essere credenti o atei.
Facilmente spiegabile il fatto che questo complesso d’eccellenza, che ha come punta di diamante le nanomedicine, si trovi proprio a Houston, una delle culle della nanotecnologia: i primi tre premi Nobel, in questa materia, sono stati vinti proprio qui, compreso quello conseguito da Richard Smalley, considerato il capostipite del settore.
Il Methodist è un nosocomio privato, il numero uno della città e uno dei primi dieci degli Stati Uniti. Presieduto da Marc Boom, un medico internista, recentemente succeduto a Ron Girotto, di lontane origini torinesi, è governato da un doppio consiglio di amministrazione, uno per l’ospedale, l’altro per l’Istituto di Ferrari, composto da businessman, come gli amministratori delegati della Continental Airlines e della Shell, petrolieri, industriali, grossi avvocati. Come nelle altre strutture sanitarie non-for-profit americane, neanche al Methodist si possono accumulare soldi: dopo aver coperto i costi del personale, limitati per statuto, tutto va reinvestito in attrezzature, nuove tecnologie, nuovi edifici ospedalieri. C’è anche l’obbligo di fare beneficenza offrendo alla comunità i propri servigi. Ogni anno, il Methodist eroga più di centoventi milioni di dollari in cure gratuite alle persone indigenti, che si tratti di cittadini americani come di immigrati clandestini. Le donazioni dei benefattori privati, per consuetudine molto consistenti, a volte anche di cento milioni di dollari ciascuna, sono una componente importante del bilancio, insieme ai finanziamenti dello Stato federale, del Texas e delle fondazioni private, denaro interamente destinato a specifici progetti di ricerca (i grant) che devono essere regolarmente portati a termine.
Quasi appoggiato ai dodici piani di futuristiche strutture in vetro e metallo del centro di ricerca, l’ospedale presenta all’ingresso, a pianterreno, un’immensa sala di accoglienza: pareti bianche, luci soffuse, divanetti, ascensori; un bar con i tavolini per le consumazioni, la zona living. Tutto è ordinato, i pavimenti di marmo, pulitissimi, riflettono l’ambiente. Altre zone sono coperte di moquette e dappertutto piante, molto alte, in alcuni casi autentici alberi. C’è anche una fontana con la statua di un bambino a cavallo di un delfino, vetrate colorate a cielo aperto all’altezza del soffitto, persino un pianoforte a coda: ogni tanto qualcuno, liberamente, suona i suoi brani preferiti. Accanto alla cappella, la Weiss Memorial Chapel, un busto di Gesù realizzato da Willy Wang, artista filippino piuttosto noto in America; poco lontano, l’effige bronzea di DeBakey, ritratto con le braccia conserte, il camice e il berretto da chirurgo: uno dei pionieri dei trapianti cardiaci, come si diceva, e – anche – «padre nobile» di questo ospedale. Ferrari racconta scherzosamente di come capiti, ogni tanto, che qualcuno, uscito dalla cappella, si segni anche davanti a lui, oltre che di fronte al busto di Cristo.
Direttore dei servizi sanitari delle forze armate durante la Seconda guerra mondiale, gigante e apripista della cardiochirurgia americana, DeBakey è morto a pochi giorni dal suo centesimo compleanno: era stato colpito da un aneurisma, molto vicino al cuore. Nessuno voleva operarlo, nel timore di essere ricordato come il responsabile della morte del chirurgo che proprio a quello specifico intervento, ancora oggi praticato secondo la sua tecnica, doveva la propria fama. Ha dovuto aspettare due anni per convincere un medico a metterlo sotto i ferri in un ospedale che porta il suo nome, e che appartiene alla Difesa americana, il Veteran Administration DeBakey Hospital. L’intervento è durato tredici ore: il paziente è rimasto in terapia intensiva per due mesi. Quando si è ripreso, è uscito sulla sedia a rotelle e in una conferenza stampa ha dichiarato: «A novantasette anni, ricomincio a lavorare». È morto due anni dopo. Ogni tanto le sue due anziane sorelle passano dal Methodist e salutano dirigenti e medici. Sono loro stesse professoresse di medicina, al Baylor.
Alle pareti dell’ospedale, ampi striscioni verticali ne ricordano l’eccellenza, rimarcata da riviste specializzate come «Us News and World Report», che lo definiscono uno dei migliori ospedali che l’America abbia avuto negli ultimi diciotto anni, grazie ai successi ottenuti nella cura dei tumori, nella chirurgia cardiaca, in pediatria, neurologia, oftalmologia. Per sei anni di fila, «Fortune» ha designato il Methodist come una delle cento migliori aziende dove lavorare in America. Per la qualità del reparto neonatale, il Methodist è valutato come un Magnet Hospital (una vera e propria calamita per le partorienti). Anche la mensa, al piano terra, è estremamente efficiente: fai la fila a seconda del tipo di cibo che desideri: sushi, piuttosto che pasta italiana, bolliti, affumicati e pure fritti. In comodi tavoli a quattro posti, mangiano insieme medici, infermieri con i loro immancabili camici azzurri, ricercatori, visitatori e i pazienti che possono, qualcuno anche sulla sedia a rotelle. I tovaglioli beige sono di carta rigorosamente riciclata.
Accanto all’area dove si pranza, c’è anche un piccolo market. Una volta a settimana mette in vendita vestiti, bigiotteria, borse e occhiali: il ricavato va in beneficenza. In un luogo di sofferenza come un ospedale, tutta questa attenzione all’accoglienza è concepita come conforto: se giri per i corridoi, non passano tre minuti che qualcuno, puntualmente, ti chiede se hai bisogno di qualcosa. È il loro modo di intendere il ricovero: nessuno è solo, c’è sempre qualcuno che si occupa di lui. L’ospedale non deve essere un ghetto: anche quando non stai bene e devi startene in pigiama, puoi girare un po’ e, se ne hai voglia, comprarti un vestito, tagliarti i capelli. Non è solo questione di budget molto ampi, l’ospedale è aperto a tutti: agli indigenti, ai pazienti coperti dai programmi di previdenza sanitaria (Medicare e Medicaid, che non rimborsano le spese mediche nella loro interezza, e quindi creano passivi al bilancio degli enti sanitari), a coloro che fruiscono di assicurazioni fornite dalle aziende, e ai privati che pagano di tasca propria e che vengono qui da ogni parte del mondo. Non è una clinica svizzera per ricconi: è certamente una struttura privata, ma l’accesso è pubblico.
«Qui» mi suggerisce Ferrari, che nel frattempo mi ha raggiunto approfittando di una pausa della Summer Student Retreat, «non si butta via un dollaro. Chi gestisce male un ospedale è cacciato via. Devi essere un bravo manager, fare in modo che i servizi siano buoni, anzi eccellenti, e che i pazienti siano soddisfatti, oltre che ben trattati e ben curati. Le persone che purtroppo sono ammalate e soffrono, volendo giustamente essere trattate al meglio, si fanno curare nell’ospedale che considerano migliore: in questo modo, il nosocomio incassa cifre maggiori, che in gran parte vengono destinate agli investimenti e alla beneficenza. I manager che hanno fatto crescere il volume degli introiti sono premiati con incentivi: anche nelle strutture non-for-profit, la meritocrazia è il sistema più efficiente.
«Non vorrei apparire poco sensibile» continua il professore mentre mi guida tra i piani dell’ospedale, «ma in un centro dove la ricerca è a livelli d’eccellenza e i servizi ospedalieri sono tra i migliori al mondo, a fare la differenza è anche la capacità di attenersi al principio secondo il quale gli ospedali devono fare affari, avere bilanci sempre in positivo nel più classico stile capitalistico, e non possono perdere miliardi, come purtroppo succede altrove.
«È importante che la gente si trovi bene, si senta a suo agio: a occuparsi dei pazienti ci sono i dipendenti, ma anche tanti volontari. E tutto avviene nell’ottica che non sono i pazienti a essere al nostro servizio, ma che è vero il contrario. In Italia, spesso il medico ti fa la cortesia di visitarti: qui da noi è l’opposto. Sai cos’è questo?» mi chiede Ferrari quando ormai siamo quasi in cima all’edificio. «È il nostro Day Hospital: qui puoi fare anche la chemioterapia. È un altro mondo, questo ospedale: c’è la banca, ci sono le poste, per chi lavora qui c’è il consulente alimentare, puoi farti fare i massaggi o l’agopuntura, sperimentare sistemi antistress. Un dipendente contento è un dipendente che lavora meglio e che è meno tentato di andarsene altrove. C’è anche una piccola palestra, io vengo qui a correre, la sera: ho davanti uno spettacolo magnifico, tutta Houston con i suoi tre centri e lo stadio immenso della Rice University. Adesso scusami» mi congeda Ferrari, «devo battere il mio record: provare a fare sedici chilometri in un’ora e ventuno, sarebbe un grosso passo in avanti per la mia preparazione da vecchietto con ancora addosso la voglia di maratone.» Preparazione invidiabile, la sua: lo scorso luglio Ferrari ha affrontato la Maratona di Brixen, sulle Dolomiti, tutta in salita, con quasi 2400 metri di dislivello complessivo, da Bressanone al Rifugio Plose. E ha regolarmente completato la gara.
Lascio il professore alla sua corsa. Per prepararmi all’incontro con i collaboratori di Ferrari, nel loro luogo di lavoro, ho cercato di documentarmi. Secondo il rapporto diffuso nel 2010 dall’Airtum (Associazione italiana dei registri tumori), sono due milioni e 250.000 gli italiani che vivono con una diagnosi di tumore (il 4 per cento dell’intera popolazione). La maggior parte sono donne (un milione e 250.000) e anziani. Rispetto al 1992, il numero di persone viventi malate di tumore è quasi raddoppiato, grazie alla diagnosi precoce, allo sviluppo della ricerca, alla prevenzione, e si è nettamente elevato il livello della qualità di vita di chi sopravvive alla malattia. Negli Stati Uniti, secondo un report del «Journal of the National Cancer Institute», tra il 2003 e il 2007 la mortalità complessiva per tumori è stata in continua diminuzione, parallelamente al calo di nuove diagnosi, pari all’1 per cento all’anno. Come si sa, le statistiche sono praticamente infinite, c’è sempre il rischio di essere imprecisi. Una cosa è certa, però: il cancro rimane la malattia a più alta mortalità nel mondo. In Occidente, soprattutto quello al polmone, al colon, al seno e alla prostata, in Asia quello allo stomaco e al fegato.
Il tumore è l’esito di un’iperproduzione cellulare che il nostro organismo non è in grado di fermare. Per anni, le pratiche generalmente adottate per contrastarlo – chirurgia a parte – sono state sostanzialmente due, talvolta attuate in simultanea: la radioterapia e la chemioterapia. La prima bersaglia le cellule cancerogene con diversi tipi di radiazioni, dai raggi X ai fasci di elettroni, allo scopo di colpirne il Dna e, dunque, causare loro un danno letale. Purtroppo, però, questo tipo di trattamento può provocare gravi effetti collaterali, dal calo dei leucociti al danneggiamento dei tessuti epiteliali, dalle fibrosi (l’accrescersi irregolare di tessuto connettivo) all’infertilità, tutte conseguenze che si cerca sempre più di prevenire e che sono comunque meno lesive di quelle indotte dalla chemioterapia. Essendo basata sulla somministrazione di farmaci che colpiscono principalmente le cellule in fase di divisione per impedirne la moltiplicazione, la chemio è particolarmente tossica per tutte le cellule che si replicano a ritmi elevati: le tumorali, ma anche le sane, come quelle del midollo osseo o i follicoli dei capelli. Ecco perché chi fa la chemioterapia molto spesso perde i capelli e rischia leucemie secondarie. Come rischia, d’altronde, problemi cardiaci dovuti al danneggiamento delle cellule che regolano il battito cardiaco, e disfunzioni all’apparato riproduttivo. Non a caso, dopo la chemio, ai pazienti viene somministrato un disintossicante, come il Tad.
Da qualche anno, grazie agli sviluppi della ricerca, è stato possibile introdurre nuovi farmaci biotecnologici (o biofarmaci), detti anche «terapie target», prodotti, attraverso delicate e costose tecniche di ingegneria genetica, da cellule viventi anziché da processi di sintesi chimica. Si tratta soprattutto di proteine che vengono fatte reagire, per la loro riproduzione, con cellule in coltura. Danno vita, per esempio nel trattamento dei tumori al polmone, ad anticorpi identici tra loro, chiamati «monoclonali», capaci di riconoscere e colpire le proteine (cosiddette «bersaglio») presenti nelle cellule malate, in modo da annullarne lo stimolo alla crescita. Tra i biofarmaci correntemente utilizzati, uno dei più noti è il bevacizumab, un anticorpo che, impedendo la crescita dei vasi sanguigni che alimentano le cellule tumorali, ferma la metastasi.
Dal 1994, sono entrati in uso nelle cliniche oncologiche anche i nanofarmaci, vettori di dimensioni infinitesimali creati grazie alla tecnologia, in grado di trasportare le medicine direttamente al loro bersaglio. Iniettando nel sangue un farmaco chemioterapico, infatti, soltanto una su molte migliaia delle sue molecole arriverà al tumore: le altre, circolando liberamente nel reticolo sanguigno, danneggeranno inevitabilmente l’organismo. Lo scopo delle nanomedicine è triplice: eliminare la tossicità verso gli organi sani, rendere la terapia più efficace, consentire – grazie alla costruzione di speciali nanocapsule fisiologicamente degradabili da inviare nella zona malata – di rilasciare simultaneamente, o in modo cadenzato, anche molteplici molecole di farmaci, i «cocktail» eventualmente necessari a ogni singolo paziente. Il meccanismo è semplice: vengono rilasciati prima i farmaci i cui contenitori si degradano più velocemente, poi gli altri. In questo modo, si può ottenere una terapia basata su farmaci diversi e diversi tempi di rilascio, evitando di sottoporre il paziente a cicli ripetuti di cura, spesso pesanti anche dal punto di vista psicologico.
Meglio, a questo punto, lasciare la parola a Mauro Ferrari, uscito dalla palestra a record personale puntualmente battuto e che, nel frattempo, ha pensato bene – a conferma della sua cordiale ospitalità – di assegnarmi nel suo Research Institute un piccolo ma efficientissimo ufficio, con tanto di computer, schermi, telefoni, stampanti. Dalla grande vetrata vedo i profili di un paio d’altri ospedali, il Texas Urgencies e il Texas Heart Institute, l’istituzione storica del dottor Denton Cooley. Mi assistono addirittura due segretarie, Freddie, una signora di colore che il capo chiama confidenzialmente Dee, che si alterna con un’altra simpatica collega, Brenda, disponibile e cordiale quanto lei. In realtà, sono le più strette collaboratrici personali del presidente e amministratore dele...