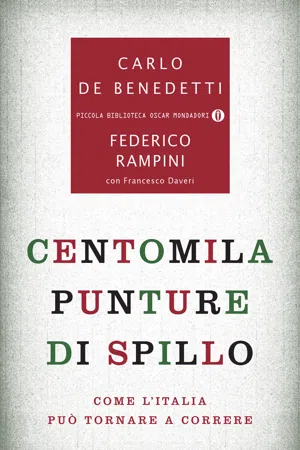Non bastava l’euro a turbare il quieto mondo di Pantalone e a ricordare l’urgenza di ritrovare uno spazio strategico per l’economia italiana. Negli ultimi quindici anni sono arrivati anche internet, Google e Skype. Tutte le scrivanie del mondo sono in rete, tutte le informazioni codificabili sono accessibili da ogni scrivania, e il costo della comunicazione si è azzerato. La rivoluzione digitale ha consentito e perfezionato la globalizzazione, rendendo il mondo più piccolo e integrato. Però i suoi benefici – prima di tutto, la riduzione delle inefficienze indotta dall’accresciuta concorrenza – sono il risultato di un processo tutt’altro che pacifico. La dura selezione in atto nell’economia mondiale è particolarmente difficile da accettare in un momento in cui la finanza globale sembra far sprofondare tutto l’Occidente in una brutta crisi: è un periodo in cui la distruzione sembra prevalere sulla creazione di ricchezza. Infine, è certamente un processo agevolato anche dalla fiducia nella possibilità di formulare progetti individuali e collettivi, ma la globalizzazione, di volta in volta, o ne consente la realizzazione o li distrugge inesorabilmente. Riadattando una frase di Ernest Hemingway, si potrebbe dire che i muscoli della globalizzazione («della guerra», nel testo di Hemingway) sono cinque: uomini, denaro, multinazionali («materiali», in Hemingway), cibo e fiducia. Sono, in lingua inglese, le cinque M della economia globalizzata: Men, Money, Multinationals, Maintenance (food) and Morale.
Nel mondo delle cinque M di Hemingway, i problemi irrisolti dell’economia italiana appaiono più evidenti che in passato. Diventa quindi ancora più importante affrontarli. In un mondo in cui ciò che conta è essere i primi nella propria area di specializzazione, la competizione tra i paesi è più serrata e il rischio di uscirne perdenti, con danni seri per il proprio benessere e il proprio modello di sviluppo, non è insignificante.
Dopo trent’anni di rinvii e scelte a metà, l’Italia è ora davanti a un bivio. La prima opzione è quella di chiudersi, con i «viveri» rimasti, dentro alla fortezza assediata dei nostri diritti oggi acquisiti, ma non per questo automaticamente garantiti in futuro. Sarebbe la risposta che tutta l’Europa, e forse il mondo, si aspetta dalla solita Italietta di Pantalone. Costituirebbe la consueta strategia di un paese che non sa rispettare i propri vincoli e tenta di eluderli. Ma c’è un’altra possibilità: attrezzarsi per approfittare dei grandi cambiamenti che, ben al di là dell’avvento dell’euro, stanno avvenendo nell’economia globale. Sapendo però che la globalizzazione – come disse Mao a proposito della rivoluzione rossa – «non è un pranzo di gala».
Men (uomini), la prima M della globalizzazione
Chi vince e chi perde nel mondo globale
Nel mondo globale di internet, nei settori hi-tech gli scambi di servizi avvengono attraverso mercati virtuali, grazie al flusso ininterrotto di byte e informazioni e ad applicazioni sempre più sofisticate del software. Ormai tutte le decisioni quotidiane relative a consumo e produzione sono piene di elettronica, e noi nemmeno ce ne accorgiamo. Della diffusione dell’elettronica e delle sue applicazioni beneficia il mondo del business globale più ancora degli stessi innovatori. Nella lista degli uomini più ricchi del mondo nel 2008, secondo la rivista «Forbes», tra gli innovatori troviamo al primo posto Bill Gates. Larry Ellison di Oracle è solo decimo, e Sergej Brin e Larry Page, i fondatori di Google, inseguono collocandosi intorno al venticinquesimo posto. A completare il terzetto degli uomini più ricchi del mondo sono invece Warren Buffett, l’ultimo vero guru di Wall Street, e il messicano Carlos Slim, che controlla circa tre quarti del traffico telefonico dell’America Latina attraverso le compagnie Telmex, Telcel e America Movil. Scendendo un po’ nella lista troviamo i manager a capo delle società della grande distribuzione, come la svedese Ikea, la tedesca Aldì, e l’americana Wal-Mart – società che hanno saputo utilizzare al meglio le tecnologie della rivoluzione digitale e manageriale – o di multinazionali del lusso e della moda, come Lvmh (Louis Vuitton), L’Oreal, Inditex (Zara) e H&M, che hanno perfezionato l’arte della creazione e della continua difesa dei marchi di successo, anche in questa società multimediale. Nella lista non mancano top manager del manifatturiero più «solido», come gli indiani Lakshmi Mittal – re dell’acciaio famoso anche in Europa dopo la fusione con la francese Arcelor – e i meno noti Mukesh e Anil Ambani, impegnati nel settore petrolifero, chimico e tessile.
Significativamente, però, i big del manifatturiero non vengono dal Nord ma dal Sud del mondo. In ogni caso, anche i paesi come il nostro – quelli che se la sono presa comoda con le nuove tecnologie – sono stati traghettati, volenti o nolenti, nel Nuovo Mondo globale e nella sua vorticosa creazione di nuove disuguaglianze. I dati della società di consulenza Hay Group dicono che la media dei compensi totali percepiti dagli amministratori delegati delle (pochissime) società italiane con una capitalizzazione di Borsa superiore ai quaranta miliardi è pari a 243 volte lo stipendio medio di un lavoratore italiano. Certo, non è come in America, dove le retribuzioni dei top manager sono 577 volte lo stipendio medio, né come in Francia dove sono 313 volte superiori. Ma il valore del multiplo italiano è più o meno lo stesso del Regno Unito, ed è maggiore che in Germania e in Olanda. Si tratta di numeri enormemente più grandi di quelli che si potevano calcolare fino a quindici anni fa.
L’allargarsi della forbice delle disuguaglianze distributive è un sintomo inequivocabile del fatto che la maggiore ricchezza generata dalla diffusione delle tecnologie digitali è andata a finire nelle tasche di pochi. Non soltanto perché è aumentata la quota dei profitti sul reddito complessivo, ma soprattutto perché è aumentata vertiginosamente la disuguaglianza tra coloro che percepiscono un reddito da lavoro alla fine del mese.
I dati per gli Stati Uniti sono particolarmente impressionanti. Solo il 10% dei lavoratori americani ha visto crescere il suo stipendio più del 2%, cioè la percentuale dell’aumento medio della produttività sperimentato nell’economia americana. Vuol dire che per il 90% dei lavoratori americani la rivoluzione digitale è risultata essere un treno superveloce che non si fermava dove loro lo stavano aspettando, oppure soltanto un film avvincente visto dal divano di casa. Gli stipendi dei lavoratori non qualificati sono stati schiacciati dalla tenaglia della scarsa sindacalizzazione, della concorrenza dei paesi con basso costo del lavoro e dell’immigrazione di lavoratori non qualificati dai paesi confinanti. Per la grande maggioranza dei lavoratori statunitensi, la globalizzazione e la rivoluzione tecnologica non evocano certo scenari di ricchezza, ma semmai precarietà e perdita di identità. Il successo del 10% dei lavoratori più fortunati – ancor più quello per l’1% superiore: top manager, star della televisione e dello sport – è invece, sostanzialmente, il risultato del cosiddetto «divario digitale». Le tecnologie dell’informazione, infatti, richiedono livelli di istruzione e di esperienza più elevati che in passato per svolgere la maggior parte delle mansioni. Nello stesso tempo, tecnologie come quella televisiva o di internet rendono disponibile a tutti, a costi molto contenuti, beni e servizi offerti da chi è in possesso dell’istruzione e dell’esperienza richiesti. Mettendo insieme le cose, ecco il divario digitale che ha contribuito a trasformare il mercato del lavoro in un mercato favorevole alle superstar, dove i pochi che possiedono le competenze si prendono quasi tutta la torta.
Karl Marx riscriverebbe il suo Manifesto descrivendo la storia del mondo di oggi come una lotta di classe tra le élite istruite e le masse non alfabetizzate. Di per sé, che ci siano lavoratori poveri e ricchi non dovrebbe necessariamente far gridare allo scandalo. Dopo tutto il sogno americano implica che, a differenza per esempio degli italiani, tutti gli americani sentono di avere qualche speranza di non rimanere un «lavoratore medio» per tutta la loro vita lavorativa. Ma i dati dell’Agenzia delle entrate americana (l’Internal Revenue Service) suggeriscono un quadro molto diverso: la mobilità sociale non è molto elevata nemmeno nella «terra delle opportunità». Chi guadagna tanto oggi è molto probabile che continui a guadagnare tanto anche domani. Questo valeva già negli anni Settanta, quando si cominciò a parlare dell’aumento delle disuguaglianze causato dal progresso tecnico. Ma è soltanto negli ultimi dieci anni che le forze della tecnologia hanno dispiegato pienamente la loro potenza di fuoco, producendo simultaneamente il boom della produttività e quello delle disuguaglianze.
Ram Charan, il moderno schiavo dal lavoro
La quintessenza del lavoro globale nell’era di internet è ben esemplificata in una sola persona: Ram Charan, il più pagato e il più occupato «consulente globale» dei giorni nostri. Chi è, cosa fa Ram Charan? È un signore munito di passaporto americano, ma nato in un piccolo paese vicino a Delhi, 67 anni fa. Svolge un mestiere difficile da descrivere: quello del consulente globale. Dopo aver abbandonato da circa trent’anni il suo lavoro di professore presso la Business School della Boston University, si è dato a tempo pieno alla consulenza globale. Fin qui niente di strano: tanti docenti di economia aziendale, in America e non solo, a un certo punto della loro carriera imboccano questa strada e cominciano a fare affari d’oro. Nel suo caso, però, l’espressione «tempo pieno» ha smesso di essere un modo di dire, per diventare la precisa descrizione di come è organizzata la sua vita. Ram Charan incontra uomini d’affari in ogni parte del mondo ed è disponibile, praticamente, ventiquattro ore al giorno per sette giorni alla settimana. Sul giornale «Fortune» si racconta come la sua agenda della settimana preveda: domenica e lunedì a Dubai; martedì a New York e giovedì in Arabia Saudita; la settimana successiva a West Palm Beach, New York e Perth (Australia) e mentre quella precedente era impegnata in un giro per affari in India, tra Delhi, Mumbay, Bangalore e Trivandrum (Kerala).
Ram Charan non ha una casa, né un’automobile. Non ha neanche un aereo personale, cioè un bene di lusso certamente alla sua portata e che ridurrebbe i disagi del viaggiare. Non possiede neanche un iPod, perché la musica rende sentimentali e lui non può permetterselo. Dorme in aereo (sugli aerei degli altri) o in albergo. Più precisamente: in vari alberghi. Qui si fa raggiungere dalla biancheria pulita e restituisce la sporca alla segretaria nel suo unico ufficio di Dallas. Un ufficio dove, peraltro, non è fisicamente mai stato.
Perché il signor Charan lavora tutto il tempo senza fermarsi mai? Ha una famiglia numerosa in India, ma – come sottolinea esplicitamente – non lavora per i suoi. Li ha già forniti di mezzi sufficienti a campare una vita ben più che decente. Il maître del Waldorf Astoria di New York lo accoglie usualmente con un «Bentornato a casa, signore», proprio come, nel film Pretty Woman, veniva ricevuto Richard Gere nel lussuoso hotel di Los Angeles. Ma – pare – non c’è una Julia Roberts nella vasca da bagno ad aspettare il signor Charan in nessuno degli alberghi che gli fanno da casa.
Quanto è speciale Ram Charan? Meno di quanto pensiamo. Il mistero degli eccessivi carichi di lavoro dei ricchi dirigenti e manager che non possono concepibilmente consumare tutto quello che guadagnano è molto diffuso: è certamente parte integrante dell’era di internet. Lui è solo un esempio estremo, e ben pagato, di ciò che sta accadendo a tanti professionisti – americani, indiani e, sempre più, di altri paesi – che lavorano nel settore dei servizi. Non sono vincolati a risiedere in un particolare luogo grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi modelli organizzativi. Come confermano vari studi statistici, negli Stati Uniti la maggior parte della gente attiva nei servizi sembra particolarmente disponibile a sacrificare quasi interamente il proprio tempo libero. E per tempo libero si deve intendere quello che una volta veniva dedicato davvero alla socializzazione, alle chiacchiere con gli amici oppure alla partita a calcetto, e non il tempo dedicato a tagliare l’erba, ai lavoretti di casa. Vuol dire che il mondo globale, e la flessibilità delle tecnologie informatiche (purtroppo o per fortuna) è molto efficace nel rompere la dicotomia tra lavoro e riposo. In poche parole: il lavoro globale ci rende più schiavi che in passato. Chi fa merchant banking spesso va in barca con i clienti piuttosto che con gli amici di sempre.
Se potessi avere (più di) 1000 euro al mese
Al manager giramondo Ram Charan, il mondo digitale ha rivoluzionato la vita, ma gli ha anche garantito opportunità di guadagno sconosciute quando era un anonimo professore di economia aziendale. A un pioniere dell’informatica come Steve Jobs, fondatore della Apple, le novità dell’era di internet hanno prima sottratto profitti e clienti, ma poi gli hanno anche restituito una seconda vita professionale, con sempre nuove occasioni di affari: l’ultima è quell’iPhone che sta impazzando tra i consumatori innovativi di tutto il mondo. In Italia, «Pantalone» e quelli come lui che si arrabattavano con piccoli negozietti al dettaglio, con la protezione e la compiacenza pubblica pagate sempre da qualcun altro, non sono stati altrettanto abili o fortunati. E così è andata a finire che, a cinquantun’anni dal Trattato di Roma – quando si gettarono le basi per la costruzione dell’Unione Europea –, a sedici anni dalla firma del protocollo di internet e a dieci anni dall’introduzione dell’euro (gli scambi sui mercati finanziari sono in euro dal 1o gennaio 1999), lo stipendio netto di un lavoratore medio italiano non arriva a 13 mila euro l’anno, poco più di mille euro al mese. Per precisione: 13 mila euro è lo stipendio medio annuo al netto delle tasse per un lavoratore senza carichi di famiglia, contabilizzando anche le eventuali differenze di potere d’acquisto tra le varie valute. L’Ocse conclude che un lavoratore italiano di questo tipo è al ventitreesimo posto (su trenta) nella classifica degli stipendi dei paesi più ricchi del mondo. Ovviamente, dietro Francia, Germania e Regno Unito; meno ovviamente dietro alla Spagna e, addirittura, alla Grecia. Peggio dei nostri lavoratori, nell’Ocse, stanno solo i portoghesi, i messicani e i turchi. E la classifica non cambia se invece dei single si guarda a un capo famiglia con moglie e due figli a carico.
Se l’Unione Europea, la globalizzazione, la diffusione della tecnologia e la moneta unica sono – come si legge sui testi di economia fin da Adam Smith – giochi in cui tutti vincono, vuol dire che qui in Italia, di questi processi ci siamo persi qualche cosa. La globalizzazione sembra aver reso precocemente obsoleto il modello tradizionale di specializzazione nei settori del made in Italy. Con l’arrivo dei paesi emergenti – non solo Cina e India, ma anche Vietnam e domani Cambogia – è diventato più difficile fare profitti non soltanto con magliette, scarpe e cravatte, ma anche con le macchine per produrre la pasta. Nello stesso tempo, la globalizzazione ha anche impietosamente messo a nudo la carenza di infrastrutture materiali e umane che consentirebbero all’Italia di fare un salto di qualità e di competere nei settori hi-tech. Da qui, non dal Wto o dalla contraffazione dei capi di abbigliamento, vengono fuori i mille euro al mese a cui sono inchiodati gli stipendi dei lavoratori italiani.
Una delle stranezze nostrane è che, pur con stipendi tanto bassi, le imprese si lamentino sempre in occasione del rinnovo dei contratti. Il ritornello recita: «In Italia il costo del lavoro è troppo elevato». Alla fine del gennaio 2008, dopo mesi di trattative, è stato raggiunto un accordo per il nuovo contratto dei metalmeccanici che prevede un aumento mensile di 127 euro lordi, poco più di 70 euro netti, per 30 mesi di copertura. Di più «non si poteva». In realtà, il «non si poteva» dei datori di lavoro non è in contrasto con il basso livello salariale osservato dall’Ocse e lamentato dai lavoratori. Ma hanno ragione tutti a lamentarsi, lavoratori e imprese. Ai lavoratori interessa lo stipendio netto: per pagare il mutuo, la spesa al supermercato e, possibilmente, le vacanze. E lo stipendio – non c’è dubbio – è basso, anche rispetto a quello degli altri paesi. Tuttavia non è lo stipendio che va in tasca al lavoratore ad appesantire i bilanci e a peggiorare la competitività delle imprese. Per bilanci e competitività conta il costo del lavoro per unità di prodotto, che si ottiene confrontando il salario al lordo delle imposte e dei contributi sociali, destinati a finanziare il sistema pensionistico e altre prestazioni sociali, con la produttività per occupato. Insomma, è la questione del cosiddetto «cuneo fiscale». Se le tasse sul lavoro e i contributi sociali sono alti e se la produttività del lavoro è relativamente bassa ecco che il costo del lavoro si mantiene elevato anche se i salari restano miseri.
Quanto al cuneo fiscale, l’Italia occupa purtroppo un non invidiabile posto in alto nella classifica dei paesi Ocse: il sesto, con il 46% del salario lordo che se ne va in tasse e altri contributi. Tanto, almeno per un single. Le cose vanno un po’ meglio quando invece di guardare soltanto alle tasse si considerino i dati inclusivi dei trasferimenti sociali, parzialmente finanziati con le tasse stesse. Sottraendo dunque al cuneo tali benefit, il cuneo «netto» scende al 33% per un single e, addirittura, sotto al 20% per un capo-famiglia di un nucleo monoreddito e con due figli, il che colloca l’Italia più o meno a metà della classifica dei paesi Ocse. Tra l’altro, indipendentemente dal tipo di famiglia considerata, il cuneo fiscale, in Italia, è comunque inferiore rispetto a quello di Germania e Francia. Quindi, se Germania e Francia sono più competitive dell’Italia sui mercati mondiali, non è per colpa delle tasse sul lavoro.
Allora, per capire da dove deriva la minore competitività dell’Italia rispetto ai due paesi concorrenti bisogna considerare i dati della produttività per addetto, e prima di tutto nelle aziende manifatturiere, cioè quelle «globali» per definizione. Qui i dati parlano da soli: la produttività manifatturiera per occupato è quasi uguale in Germania e Francia ed è vicina a 65 mila euro circa. In Italia, invece, è pari a 48 mila euro: è inferiore di circa un quarto. E la differenza non dipende dal fatto che i tedeschi sono bravi a fare treni e frigoriferi (beni a tecnologia intermedia o elevata), mentre gli italiani lo sono nel fare scarpe e cravatte (beni tecnologicamente semplici). Se si osserva bene l’intero settore manifatturiero con una lente di ingrandimento ci si accorge che, settore per settore, la produttività tedesca e quella francese sono quasi sempre più elevate di quella italiana. Un buon esempio è quello dei settori tipici del made in Italy: tessile, abbigliamento e scarpe. È un settore a più bassa produttività rispetto alla media dell’economia in tutti i paesi europei. Ma in Germania e in Francia la produttività annua per occupato nel tessile, abbigliamento, cuoio e calzature è pari, rispettivamente, a 43 e 46 mila euro. In Italia sfiora solo i 33 mila euro, quindi è inferiore del 25% circa. Come nel resto dell’economia.
Fare confronti di produttività con altri paesi che non condividono la stessa valuta è più controverso. Ma certamente le cose cambiano se si compara la competitività dell’Italia a quella di paesi come la Corea del Sud o il Messico. Quando ci confrontiamo con paesi meno sviluppati del nostro, le alte tasse sul lavoro dell’Italia sono una delle cause della perdita di competitività.
Niente scorciatoie, dunque. Per aumentare i salari non basta tagliare le tasse sul lavoro. Certo, ridurre il peso dell’onere fiscale sul lavoro un po’ aiuta la competitività dell’Italia, specie nella concorrenza con i paesi low cost. Ma, prima di tutto, occorre dire che questi paesi non sono più tanto low cost, perché ormai sono in grado di sfornare più ingegneri e laureati di quanti ne produca tutta l’Europa messa insieme. E poi l’obiettivo di una drastica riduzione delle imposte sul lavoro può essere realizzato solo al prezzo di ridimensionare il sistema pensionistico pubblico e le altre voci connesse con lo stato sociale; un compito che ha affossato la maggior parte dei governi che si sono cimentati nell’impresa, per i forti aspetti di iniquità. Se invece si parla di far salire gli stipendi degli italiani al livello dei tedeschi o dei francesi, il discorso è differente: deve aumentare soprattutto la produttività per addetto. Per questo occorrono quegli investimenti produttivi in infrastrutture fisiche e umane che nei decenni passati la nostra classe dirigente non è riuscita a garantire.
I veri numeri del «pericolo giallo»
La Cina è la seconda economia del mondo, ma il suo reddito pro capite figura solo al centesimo posto ne...