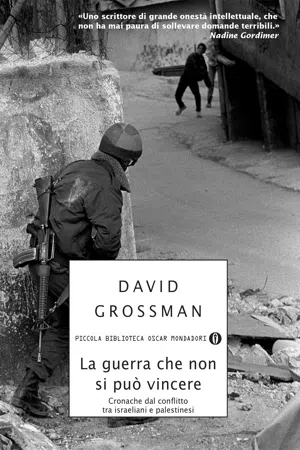![]()
Il 20 marzo 2000 Giovanni Paolo II è arrivato in Israele nel quadro di una più ampia visita ufficiale ai siti cristiani della regione in occasione del nuovo millennio. Il papa era accompagnato da decine di migliaia di pellegrini. Nel corso di una settimana ha visitato i luoghi sacri al cristianesimo in Israele e nei territori dell’Autonomia palestinese, si è recato in luoghi sacri alla religione ebraica e musulmana e ha fatto visita a siti «laici» come il museo dell’Olocausto Yad Vashem e un campo profughi palestinese. Il viaggio del papa ha suscitato molta curiosità e interesse fra israeliani, arabi e nel mondo cristiano.
Primo giorno: l’arrivo del papa
Un israeliano siede davanti al televisore nella sua casa di Gerusalemme e guarda l’arrivo del papa nel proprio paese.
L’israeliano è un laico, gli sono estranee le cerimonie e le istituzioni religiose di ogni genere. Si sente molto ebreo, rispetta chi crede, ma non ha fatto quel «salto nella fede» di cui parla Kierkegaard.
Sono giorni che ripete a se stesso: questa visita, per quanto storica, non mi commuoverà. Si dice che non è rilevante per la sua vita, per i problemi della sua esistenza privata, per quelli politico-morali che da decenni tormentano il suo paese. Ma poi, quando l’aereo atterra e il papa appare in cima alla scaletta, succede qualcosa. L’israeliano vede un vecchio curvo e appesantito dagli anni, dalle responsabilità, dalle esperienze della vita e dal dolore che traspare dal suo volto.
L’israeliano guarda il papa e all’improvviso, come per un’illuminazione, vede quello che forse vede lui: lo Stato di Israele. La realtà, simbolica e reale a un tempo, di una nazione nata dopo duemila anni di esilio, di persecuzioni religiose, di inquisizioni, di pogrom, dopo la Shoah.
Di colpo l’israeliano vede questa realtà. Non come una sfida, poiché non considera il proprio paese una «vendetta» contro tutto ciò che i gentili hanno fatto agli ebrei, condotti o ispirati da gran parte dei predecessori dell’attuale pontefice.
Al contrario, nello sguardo pensieroso, profondo, del papa, l’israeliano vede la meraviglia e la grande occasione incarnate nello Stato ebraico, vede la capacità di rinascita e di ripresa degli ebrei che in questi giorni anima la loro speranza di salvarsi dalla maledizione della guerra per realizzare la pace.
L’israeliano si muove a disagio nella sua poltrona. Non intendeva farsi coinvolgere da questo «storico» evento, né regolare vecchi conti con la cristianità: anche facendolo, non si porrebbe rimedio a niente, e chi ha l’energia per tuffarsi ancora nella tenebra delle relazioni fra ebrei e cristiani negli ultimi duemila anni?
Il papa avanza. Curvo, aggrappato al bastone, passa in rassegna soldati robusti e ben armati, così diversi dal vecchio stereotipo dell’ebreo. L’israeliano in poltrona, che non ama alcun tipo di esercito, pensa che, se un qualunque ebreo delle quaranta generazioni precedenti (compreso suo nonno fuggito dall’Europa settant’anni fa) vedesse la scena, non crederebbe ai suoi occhi. E in quell’attimo capisce più di quanto si è concesso di capire fino a ora. Dietro la sobria cerimonia formale ribolle la storia dei rapporti fra le due religioni, rapporti crudeli, misteriosi, profondi come una ferita aperta che ora forse, per la prima volta, si ha l’opportunità di curare.
Suona l’inno nazionale. Chissà se hanno tradotto le parole al papa. Parlano di duemila anni di speranza degli ebrei di diventare un popolo libero, nella terra di Sion e a Gerusalemme. Poi il papa dice cose belle e commoventi. Quest’uomo coraggioso, che ha osato cambiare la posizione della Chiesa verso Israele e l’ebraismo, parla del suo pellegrinaggio, e una speranza si insinua nel cuore: che questo possa essere un viaggio di immedesimazione e di rimorso, di chiarificazione e di studio, un viaggio fisico e spirituale verso le radici della verità attraverso le orribili stazioni che ebrei e cristiani, esseri umani, uomini, donne e bambini, hanno percorso. Un viaggio agli inizi del quale può forse cominciare un’era nuova, più umana. Non accadrà in una settimana, ma da qui può partire.
Secondo giorno: visita a un campo profughi
Tesi e preoccupati, i rappresentanti di Israele e dell’Autorità nazionale palestinese misurano ogni parola dei discorsi del papa. Andrà oltre le formule abituali? Parlerà della sorte di Gerusalemme? Difenderà la richiesta palestinese di riavere l’intera Cisgiordania e tornare così ai confini del ’67? Nella lotta tra questi due popoli ogni conquista viene percepita come una sconfitta dell’altro. Sicché oggi israeliani e palestinesi, come in una moderna incarnazione di Giacobbe ed Esaù, sembrano due fratelli che si contendono la benedizione paterna, ciascuno geloso di quello che riceverà l’altro e pervaso da una fiducia quasi magica nella forza di quella benedizione.
Mi domando se il papa, nei suoi incontri con i rappresentanti delle due parti, sia riuscito a notare fino a che punto l’interminabile contesa li abbia resi stranamente simili. Entrambi, infatti, rivelano la stessa ipersensibilità per cosa pensa e dice la controparte, lo stesso maniacale, retorico sentimentalismo, lo stesso impellente bisogno di sentirsi amati dall’ex nemico, lo stesso impulso all’autodistruzione, lo stesso amaro scetticismo che spinge a dubitare di ogni promessa e a perdere ogni speranza.
Ebbene, stando molto attento a non entrare nel campo minato della politica, il papa ha detto cose importanti e quasi dimenticate dopo un conflitto che dura da generazioni. Ha parlato della sofferenza umana di milioni di profughi palestinesi, dell’insensata situazione di cui sono prigionieri, e ha ricordato che la loro condizione non li rende meno importanti né meno degni di rispetto di altri popoli. Con grande semplicità, ha restituito loro un po’ dell’onore perduto. Ma il papa ha accennato anche alle responsabilità che i governanti di tutto il Medio Oriente hanno in questa sofferenza. Non credo affatto che fosse un’allusione casuale. Perché dietro il fumo del conflitto è ben noto che quella responsabilità non è solo di Israele: anche i capi di Stato arabi sono colpevoli dell’orribile condizione dei rifugiati palestinesi. I paesi arabi più ricchi avrebbero potuto migliorare immensamente la vita quotidiana dei profughi; invece hanno preferito cementarne la miseria, lasciarla così com’è, mantenerla nelle orribili condizioni dei campi profughi.
Nella visita del papa al campo di Betlemme è venuto fuori, tuttavia, qualcosa di più importante. Spesso, nel corso delle mie conversazioni con i palestinesi, li ho sentiti dire che stanno pagando il prezzo delle persecuzioni sofferte dagli ebrei per mano dei cristiani; e che dunque loro, i palestinesi, sono diventati le vittime delle vittime. Più di una volta li ho sentiti dire che l’ansia scolpita nell’anima ebraica dalle persecuzioni del passato avrebbe impedito a Israele di sentirsi del tutto sicuro; e perciò non ci sarebbe mai stata una vera pace.
Generalmente replico che nemmeno il mondo arabo ha mai mostrato troppa benevolenza verso lo Stato ebraico nato dai profughi dell’Olocausto, che Israele non è esattamente circondato dall’Esercito della salvezza, e che ancora oggi sulle tivù arabe fioccano appelli a distruggere «l’entità sionista».
Però non c’è dubbio che il passato del popolo ebraico – un passato di cui la Chiesa è in larga misura responsabile – crei un formidabile ostacolo psicologico che rende molto più difficile per Israele comportarsi con maggiore coraggio, generosità e fiducia verso gli arabi.
Da questo punto di vista, il destino di Israele e dei palestinesi, così come quello delle tre religioni che fanno capo alla Città Santa, è legato in un nodo tragico e aggrovigliato. Nei vicoli del campo profughi di Betlemme, mentre benediceva i bambini, cioè la quarta generazione del dolore e della miseria, il papa ha affrontato quel nodo, ha toccato con mano la ferita del nostro conflitto. La salvezza non arriverà naturalmente da questa breve visita, ma nelle parole del papa, nei suoi gesti, io cittadino di Israele ho avvertito l’impegno cristiano di provare disperatamente a sciogliere, con tenerezza e cautela, la ragnatela che soffoca dentro di sé milioni di persone: ebrei e arabi, israeliani e palestinesi.
Terzo giorno: visita a Yad Vashem
Dopo la cerimonia di ieri al museo dell’Olocausto, tutti, anche i più cinici, capiscono che il viaggio del papa tocca i fondamenti della nostra identità, le nostre emozioni più profonde.
Se, durante i preparativi per la visita, le parti interessate pensavano ai simboli astratti e alle grandi immagini, adesso che il pellegrinaggio di Giovanni Paolo II è in corso si rimescolano simboli e umanità, le idee astratte con le lacrime, le ferite e la fragilità umana.
Così è successo a Yad Vashem, quando il papa ha parlato delle sofferenze degli ebrei nel momento in cui ha incontrato i sopravvissuti del suo villaggio natale in Polonia (compresa la donna che lui stesso trasportò sulle spalle fuori dal ghetto e a cui diede una fetta di pane salvandole così la vita), e di nuovo quando si è alzato, con la testa reclinata, per commemorare le vittime.
Lasciatemi raccontare una piccola storia personale. Mia zia Itka, sopravvissuta al lager di Treblinka, venne al mio matrimonio con un cerotto sul braccio. Se lo era messo per coprire il numero che le avevano tatuato sulla pelle e non rattristarci così con la memoria della Shoah. Ma io ricordo che non riuscii a staccare gli occhi da quel cerotto, e il gesto di mia zia mi fece comprendere che tutti noi, qui in Israele, camminiamo su una crosta sottile come quel cerotto, sotto la quale si spalanca un abisso che in ogni momento minaccia di travolgere la nostra esistenza quotidiana.
Ho di nuovo provato quella sensazione ieri, quando a Yad Vashem è stata letta la lettera che Ghenia, una donna ebrea, aveva scritto a Bronia, l’amica cristiana a cui aveva affidato il figlioletto, Michael. La madre chiede a Bronia di non dimenticare di mettere il pigiama al bambino la notte e la implora di nutrirlo bene affinché sia abbastanza forte per affrontare ciò che lo aspetta. Alla fine della lettera veniamo a sapere che Ghenia e Michael furono entrambi uccisi ad Auschwitz. A quel punto ho sentito – e forse non sono stato il solo – la brutalità con cui veniva strappato quel sottile cerotto che separa noi qui, in Israele, dalla Shoah.
È vero, il papa non ha chiesto perdono al popolo ebraico, e non si è scusato per ciò che la Chiesa ha fatto durante la Shoah. Forse è stata una scelta politica del Vaticano. Ma ritengo che sia meglio così. Pensiamo a cosa sarebbe accaduto se si fosse scusato: un miliardo di cristiani sarebbe potuto arrivare alla conclusione che il papa li aveva liberati una volta per tutte dall’impegno di affrontare la memoria dell’Olocausto.
Non appartengo alla categoria di persone convinte che l’Olocausto sia una faccenda esclusivamente ebraica. Ritengo invece che ogni persona civile e onesta debba porsi domande molto serie sulla Shoah e su come sia potuta succedere.
Queste domande non sono prerogativa degli ebrei. Sono domande universali, toccano le relazioni tra gli esseri umani, i rapporti con gli stranieri, con i diversi, con i deboli. Riguardano l’animo umano che così facilmente può essere indotto a cessare di parlare al singolare per cominciare a ruggire al plurale. Riguardano l’uso della forza, il modo in cui un individuo può mantenere la sua umanità di fronte all’arbitrio che cerca di annientarlo, e toccano il coraggio più grande di tutti: quello di compiere un gesto di carità quando sarebbe molto più facile dare una mano al male.
È un bene che il papa non abbia chiesto perdono. Nessuno può chiedere perdono per la Shoah a nome di altri, e nessuno è autorizzato a perdonare in nome delle vittime. Vedere il cordoglio espresso dal papa a Yad Vashem, apice della sofferenza ebraica, vale più di qualsiasi dichiarazione ufficiale.
Quel che è accaduto nella Shoah non può essere riassunto in una frase o in un gesto, per quanto importante. Deve restare muto per sempre, come una bocca aperta in un grido, come il verso troncato che chiude la poesia del nostro poeta Dan Pagis intitolata Scritto a matita in un treno sigillato:
In questo vagone
sono Eva
con Abele mio figlio
se avete visto l’altro mio figlio
Caino, figlio di Adamo
ditegli che io…
Quarto giorno: la messa sul Monte delle Beatitudini
Per tre ore, ieri, fede e mito si sono fusi con la realtà, con lo scenario in cui si sono svolti gli avvenimenti, con i nomi divenuti fondamento della cultura occidentale.
Più di ogni altra cosa era possibile osservare la sensazione di partecipare a un evento unico sui volti di migliaia di pellegrini. Si poteva sentire, assimilandosi agli altri, la forza della speranza nel luogo dove sono avvenuti i miracoli.
Guardando la messa celebrata dal papa sul Monte delle Beatitudini, ho pensato che la maggioranza degli ebrei di Israele assisteva per la prima volta a una funzione religiosa cristiana. So che suona strano a chi vive in un paese cattolico o a chi è abituato a considerare gli ebrei una sparuta minoranza, ma in Israele è così. Se pensiamo alla storia dei rapporti fra ebrei e cristiani, si può comprendere la nostra riluttanza verso tutto ciò che è connesso con la cristianità, verso le istituzioni religiose cristiane.
Uno scolaro ebreo israeliano non sa quasi nulla di Gesù e dei cristiani, i suoi studi in materia sono limitati alle persecuzioni degli ebrei.
Posso testimoniare, con lieve imbarazzo, che nella piccola Gerusalemme provinciale degli anni Sessanta ho incontrato il primo cristiano solo all’età di dieci anni, e come tutti ero nutrito di storie spaventose sulla crudeltà dei cristiani nei confronti degli ebrei.
La messa di ieri ha dato a milioni di israeliani un’occasione unica per modificare quest’immagine stereotipata, permettendogli di vedere – forse per la prima volta – l’altra faccia della cristianità. D’improvviso gli israeliani hanno potuto scoprire gli elementi di pace e il desiderio di giustizia presenti nella dottrina dell’uomo di Nazareth. D’improvviso si sono potuti avvicinare a una funzione religiosa cristiana senza provare la minaccia e il terrore che per duemila anni hanno echeggiato, in modo incontrollato, nell’animo di ogni ebreo, come un riflesso condizionato dell’istinto di sopravvivenza.
Questa scoperta mette in luce un altro cambiamento importante prodotto dalla visita del papa. Riguarda il modo che hanno i cattolici di vedere Israele e gli ebrei.
Un altro aneddoto personale. Non molti anni fa ho fatto un viaggio in Portogallo. Una sera, in una piccola pensione familiare, avevo bisogno di telefonare a casa. La proprietaria mi ha chiesto dove volevo chiamare, e io ho risposto: «Gerusalemme». La donna è scoppiata a ridere: «Impossibile,» ha replicato «non lo sa che Gerusalemme è in cielo?».
Con questo pellegrinaggio, però, Giovanni Paolo II, e con lui milioni di cristiani in ogni angolo del mondo, incontrano un Israele che non è solo Terra Santa, ma un paese reale, terreno, abitato da ebrei in carne e ossa che non sono assolutamente simbolo di nulla.
Perché questa è forse la grande tragedia del popolo ebreo: per migliaia di anni è stato considerato dagli altri, e soprattutto dai cristiani, un simbolo, un’allegoria o una metafora di qualcos’altro, un’entità eccezionale, dotata di poteri sovrannaturali o inferiori al normale (così come ritenevano i nazisti nella loro definizione di Untermensch).
Per migliaia di anni gli ebrei sono stati allontanati ed esiliati dalla realtà. Concretezza e umanità sono state loro negate con sofisticati strumenti di demonizzazione: l’ebreo errante, Giuda Iscariota, l’avvelenatore dei pozzi, i vecchi dei protocolli di Sion e centinaia di altre descrizioni grottesche, diaboliche, infiltratesi nel folclore, nella religione, nella letteratura, perfino nella scienza. Forse è per questo che gli ebrei hanno trovato conforto in un’idealizzazione di se stessi non meno pericolosa, considerandosi il popolo eletto.
Oggi, tuttavia, lo Stato di Israele è il loro tentativo di vivere un’esistenza né idealizzata né diabolica. Di condurre una vita normale nel proprio paese, sulla propria terra, dove crescono i loro figli, si difendono con le loro forze e cercano, finalmente, di instaurare relazioni normali con i propri vicini.
Ora il papa vede questa nuova, fragilissima normalità, e con lui le migliaia di pellegrini che lo accompagnano, nonché il miliardo di fedeli che lo seguono nel suo viaggio sugli schermi televisivi. Dico questo senza dimenticare i problemi in cui Israele è invischiato e le ingiustizie che ancora infligge ad altri. Eppure, attraverso gli occhi del papa e gli occhi delle generazioni che rappresenta, credo si possa scorgere la nuova volontà del popolo ebraico di essere, finalme...