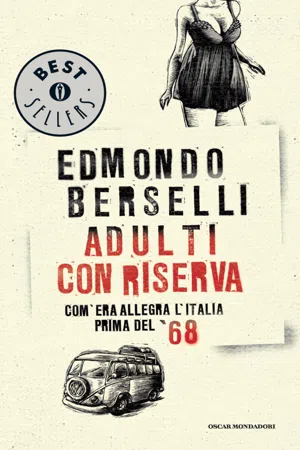![]()
Questo sarebbe il prologo
Questo sarebbe il prologo. Mia cugina una sera mi ha chiesto: ti piacciono i Beatles? E io, naturalmente, da eclettico bastian contrario come sono sempre stato anche da ragazzino, ho detto: no, i Beatles mi fanno schifo. Ma li hai mai ascoltati?, ha insistito lei, con la tenacia puntuale delle donne emiliane. A quel punto mi sono sentito toccato nel vivo della mia personalità più intima, nonché della mia dignità pubblica, e ho risposto che certamente, figurarsi. E lei, con la sua tipica ostinazione femminile, perché le donne sono legatissime al principio di realtà e non accettano divagazioni di maniera, ha infierito mettendoci la soavità pratica delle zitelle padane: allora dimmi una loro canzone.
Visto che non serviva a niente fare il muso arcigno e sfoggiare un’astratta superiorità intellettuale, e lei mi guardava ostentando l’aria inquisitoria della professoressa delle medie che interroga lo studente impreparato, alla fine ho dovuto ammettere tutto vergognoso che dei Beatles avevo letto qualcosa, ma che non avevo mai sentito una loro canzone.
Una figura da scemo. Ma lei si è accontentata della sua piccola vittoria, non ha affondato il coltello, e ha concluso: forse non lo sai, ma li hai già sentiti. E di fronte alla mia faccia perplessa ha detto: hai presente Please, please me?
Il caldo era molto afoso nella sera emiliana, e un sole di un metro di diametro scendeva placido sull’orizzonte dietro la cantina sociale. In quella stessa pianura modenese Silvio Berlusconi avrebbe fatto ridere una sterminata platea molto liberale e anticomunista, che lo aveva accolto acclamante, dicendo che qui è rosso anche il sole, compagni. Mentre il mio volto di presuntuoso e ignorante totale si infiammava prendendo i colori comunisti del tramonto padano, la cugina ha fatto un piccolo sorriso vittorioso e ha canticchiato la strofa dei Beatles: «Last night I said these words to my girl … I know you never even try, girl…».
Sì, va bene, la cugina non cantava le parole in inglese, faceva dei suoni onomatopeici, ma quando è arrivata puntuale come un soprano al decisivo «C’mon, C’mon», un ricordo impreciso mi si è risvegliato nella mente, come una luce che si accende nella notte, la sveglia che suona al mattino: ma certo che l’ho sentita. Questa sì, ho detto, la conosco. Anni dopo, corrotto dalla cultura, avrei usato la parola «agnizione».
Vedi, ha concluso lei con la bonomia didattica che si dedica agli impreparati contriti, tutti hanno ascoltato i Beatles.
La cugina canterina fin da adolescente avrebbe voluto dedicarsi alla carriera di cantante lirica, e aveva imparato una gran quantità di arie, ed eseguiva da virtuosa Sempre libera degg’io e quasi tutta la Traviata comprese le parti del baritono e del tenore, ma intanto si era dovuta mettere alla macchina da maglieria, e smanettare sbracciandosi ogni santo giorno, perché nel frattempo a Carpi era cominciato il boom del tessile e le aziende avevano bisogno di lavoranti a domicilio.
La mamma, invece, raccontava che da piccola le sarebbe piaciuto immensamente studiare da maestra, ma alla fine della quinta elementare, nonostante una pagella meravigliosa e il plauso dell’insegnante, i suoi le avevano detto: guarda che poi ti mandano in montagna, da sola, lassù, lontano da casa, e come fai? Aveva accettato di imparare a lavorare da sarta. Ancora più di vent’anni dopo se ne dispiaceva un po’: e a pensarci adesso viene in mente che la selezione di classe, come avremmo detto in seguito, nasceva anche dalla rassegnazione, dal non sapersi vedere in altra posizione se non quella conferita dal destino, e dalla fisiologia sociale.
Non che ci importasse molto delle canzoni, allora. Il mondo musicale era il sottofondo del frastuono del luna park, la colonna sonora dell’autoscontro dove le ragazze si facevano portare per sentire il brivido della sfida, l’emozione dell’urto improvviso, con i capelli che si agitavano nell’aria dopo la botta fra i paraurti di gomma e il rimbalzo contro la sponda. Era anche divertente vederle lì vicino, su una pista improvvisata, ballare in gruppo il cha cha cha sulle note di una canzone, diffusa a volume altissimo da altoparlanti a forma di tromba, che diceva più o meno: «Pepitó mi corazón ... Pepití, Pepitó». Gonne stampate a fiori che si sollevavano nella danza. Clima di quasi felicità, e risate squillanti nel profumo di zucchero filato. La sensazione che, mentre l’altoparlante scandiva il ritmo irresistibile della canzone, e i gesti di quelle giovani donne riproducevano i passi del ballo, necessari come un disegno inciso nella pista, noi da lontano, ancora troppo bambini, stessimo guardando un film lontanissimo.
Noi qui, con un cono di gelato in mano, la lingua fuori che lecca la cioccolata sgocciolante, e loro là, in una piccola giostra di seduzione. Con la consapevolezza improvvisa che quella era già un’altra realtà, un mondo diverso dal nostro: qualche mese o qualche anno più avanti, in un’altra dimensione più vicina all’età adulta, dove si celebravano storie, o premesse di storie, o ipotesi di storie. Innamoramenti, baci, baci, baci. Come nei film. E noi piccoli a guardare straniti, con gli occhi fissi come imbecilli, mentre il misterioso Pepito mostrava il suo corazón, che era un cuore giovane, un po’ irresponsabile, ballerino, tutto un saltello agile come il cha cha cha.
La storia reale è che nel dicembre 1954 ci trasferiamo al Nord, mia madre giovane con in braccio mia sorella in fasce, una bambina di quattro mesi. Hanno appena abolito la terza classe, commenta mio padre. Rivedo la piazza soleggiata della stazione di Bologna, il passaggio sul ponte del Po a Ostiglia, il fiume che si apre larghissimo sotto le carrozze e i binari, il male al culo sui sedili di legno dell’accelerato; all’arrivo una giornata stupenda dell’inverno trentino, con un volo di colombi, lontano, nell’aria chiara.
Poi il vecchio camion del trasloco che fatica a percorrere il viottolo verso la casa nuova, in piena campagna, le ruote che rischiano di scivolare nel ruscello a fianco dell’ultimo vialetto. E non appena mette piede a terra, con la bambina in braccio, la mamma giovane, che adesso sarebbe considerata poco più che una ragazza, si fa venire le lacrime agli occhi e in italiano, cioè nella lingua delle occasioni speciali, dice a mio padre: ma dove mi hai portata.
In quella storia lontana, ogni giorno era come emergere da un’epoca esotica, fatta di campagne, filari di viti e giornate infinite. Alle scuole elementari le maestre erano vecchissime e qualche volta morivano prima della fine dell’anno scolastico, fra il compianto generale, dopo malattie silenziose e segrete. La vita era come attutita, sfiorata da una lentezza luminosa. Mio padre arrivava all’ora di pranzo, sulla Gilera nuova, cilindrata 150 centimetri cubici, il motore scoppiettante, le quattro forcelle telescopiche verniciate e cromate: la sistemava sul cavalletto e saliva alla svelta le scale per sedersi a tavola. Si preparava l’acqua frizzante, con le cartine Idriz, o l’Idrolitina: aveva un gusto vagamente salato, che sembrava il dissapore da concedere alla modernità delle bollicine. Sul giornale e alla radio le notizie erano poche, filtrate, ammorbidite. Eugenio Pacelli si era spento dopo una di quelle malattie da papi, tormentose e fatali, sempre con il «sensorio vigile», come comunicava l’archiatra pontificio, e il popolo dei fedeli era passato dalla costernazione alla felicità per il suo successore, «il contadino», perché è vero che morto un papa se ne fa un altro.
Allora, lassù nel Nord prealpino, non c’erano i comunisti; o meglio, ci saranno anche stati, ma nelle grandi città, fra gli intellettuali o nelle grandi fabbriche. Nei paesi, a parte alcuni avvocati e professionisti eccentrici che rappresentavano l’ala borghese della falce e martello, personaggi stizzosi sospesi tra la fede nel Touring Club e il positivismo più truce, i comunisti erano certi tipi bizzarri, litigiosi, ai margini del consorzio della gente educata. Ha fatto il partigiano, diceva mia madre. Qualcuno addirittura aveva un alone di galera intorno a sé, alle spalle leggende di litigi, risse o minacce, di fallimenti coniugali, di scioperi rabbiosi e di scontri feroci con i padroni.
I socialisti di Nenni, appena un po’ meglio.
E dire che i nonni materni erano socialisti, di quelli d’una volta, che pensavano sinceramente che Cristo fosse stato il primo socialista, e nel Ventennio, finché avevano umanamente potuto, si erano rifiutati di iscrivere i figli ai Balilla e alle Giovani italiane, con il corpo insegnante che mandava sguardi corrucciati, occhiate di patriottico rimprovero, e i poveri bambini che imploravano di essere registrati negli elenchi del Regime come tutti i loro compagni. Ma alle elezioni del 18 aprile 1948, quelle che «Nel segreto dell’urna Dio ti vede e Stalin no», anche i nonni avevano avuto paura dei cosacchi che si sarebbero abbeverati alle fontane in San Pietro, non si erano fidati del ritratto di Garibaldi sul simbolo del Fronte democratico popolare, e avevano votato per la Democrazia cristiana (o forse per i «piselli» di Saragat, il nonno).
C’erano stati i fatti d’Ungheria, a testimonianza del carattere maligno del comunismo, ma questo lo sanno tutti. All’asilo, le suore a mezzogiorno accendevano la radio, e giuravano di sentire, fra le scariche delle onde medie, il fragore dei carri armati sovietici. Non c’era modo di capire con precisione se le brave sorelle confidassero nella resistenza ungherese, per la rivincita contro il comunismo ateo, oppure fossero in ogni caso soddisfatte poiché l’invasione russa dimostrava la perfidia irrimediabile dei sovietici senza Dio.
A casa, mio padre, degasperiano, commentava le notizie del giornale radio, stilando giudizi sommari sui dirigenti del Partito comunista. Palmiro Togliatti, «il Migliore», un uomo di intelligenza raffinatissima, un cervello febbrile, una sofisticatissima anima russa. Un mascalzone, era il verdetto finale. E quell’altro, Umberto Terracini, detto «dottor Sottile», una cultura, ma una cultura da fare spavento. Un altro mascalzone, naturalmente. Quando si parlava degli scrittori e dei registi, di Pasolini o di Visconti, la sentenza cambiava forma ma non contenuto. Un grande artista, davvero, ma uno sporcaccione. E a che cosa serviva poi tutta quella cultura se, un paio d’anni dopo, i mascalzoni sovietici, gettata la maschera, avrebbero impedito allo scrittore Pasternak di andare a ritirare il Nobel?
Sicché ci si chiedeva se, dopo la giusta scomunica di Pio XII contro i rossi, non fosse il caso di metterli fuori legge, i comunisti: ma c’era sempre un ragionamento molto sapiente, e incomprensibile per l’infanzia, che concludeva sull’impossibilità tecnica o logica di sbattere il Pci fuori dalla vita democratica. Non si sapeva allora, non era arrivata notizia, che l’imparziale Vaticano aveva vietato anche di iscriversi al Rotary, troppo contiguo agli ambienti della massoneria.
Credo di essere diventato anticomunista allora, per il legittimo terrore che i comunisti prendessero il potere, con le buone o con le cattive. E a ogni elezione si attendevano i risultati con preoccupazione, altroché, anche se c’era una specie di consapevolezza secondo cui niente avrebbe potuto scalfire la democristianità pura e profonda dell’Italia cattolica, e anche di quella puttaniera.
Fossimo pure diventati tutti comunisti, saremmo rimasti democristiani nel profondo, nell’anima, nell’istinto.
Una volta mio padre venne candidato alle comunali, un po’ controvoglia, e sul giornale locale pubblicarono addirittura la sua foto, con una biografia che lo dipingeva come una specie di eroe della resistenza al comunismo «nella difficile realtà emiliana». La domenica delle elezioni mia madre incontrò una coppia di profughi giuliani – gente poverissima, così povera che ogni tanto la moglie veniva a farsi regalare qualcosa, uno straccio, uno scampolo, un paio di pantaloni smessi, per via del marito spesso disoccupato – e quelli si misero a festeggiarla, tutti allegri: Signora, signora, noi abbiamo sempre votato per l’Msi, ma questa volta abbiamo visto il nome di suo marito e abbiamo votato per lui.
Un secolo dopo, eravamo tutti di sinistra, alcuni molto francofortesi e adorniani o marcusiani, hegeliani e freudiani, e si leggevano libri che volevano smantellare la famiglia o distruggere la scuola borghese, e si aspettavano i risultati del voto con l’ansia di vedere confermate le proprie previsioni sull’immancabile sconfitta del regime reazionario e pasticcione. Ma quando poi la televisione mostrava le tabelle con i riepiloghi, e si cominciava a capire che la grande avanzata delle masse popolari non era riuscita del tutto, si tirava in segreto un sospiro di sollievo. La Dc era sempre lì, come un elemento di stabilità e costanza antropologica. Se non altro garantiva un’ulteriore legislatura in cui avremmo potuto criticarla a sangue.
Ma il sentimento tenuto religiosamente nascosto era che se la Dc doveva continuare a governare, doveva anche mantenere tutti i suoi voti, pena una irreprimibile delusione: non avremmo voluto un governicchio instabile, un partito ferito dal voto popolare, pretendevamo che questi brutti conservatori lumaconi avessero una solida maggioranza. In modo, noi, da poter affilare le critiche contro i reazionari e i baciapile, contro Rumor e Piccoli, contro Andreotti, Fanfani e Moro, soprattutto Moro, l’uomo dell’eterno rinvio, della mediazione, di Todo modo, del lessico incomprensibile, delle «convergenze parallele», frutto queste ultime di una moderna o eterna geometria politica non euclidea.
Perché se la Dc si fosse davvero indebolita, si sarebbe dovuta trovare un’alternativa. Mentre noi, a quel tempo, eravamo proprio radicali, radicalissimi. Più che convinti che il male implicito del capitalismo, dovuto alla struttura del dominio di classe, andasse estirpato con un gesto rivoluzionario. Ma doveva essere una rivoluzione molto cerebrale, sublime, e almeno molto luxemburghiana, da fare un po’ più in là, in modo che fosse perfetta, elegante, intellettualmente rarefatta. La rivoluzione come un colpo da maestro al biliardo, una carambola argutamente pensata, e realizzata infine con la nonchalance del campione, dopo avere squadrato la disposizione delle bocce, calcolato gli angoli di incidenza e appoggiato il cognacchino sulla sponda, con un filotto che faceva frullare i birilli sul tappeto.
Altrimenti, meglio aspettare. Se proprio doveva esserci un governo cincischione, tanto valeva che fosse democristiano. Ci si incazzava meglio, si potevano fare le facce schifate, con superiore coscienza hegelo-marxiana che si proiettava di riflesso anche sulle mediocri insufficienze dell’opposizione di sinistra.
Se non c’era una processione, una festa del patrono, la cerimonia di Cristo Re, un’esibizione della banda cittadina, la sagra in un paese vicino sulla destra dell’Adige, le domeniche erano di una lentezza estenuante. Al mattino, davanti alla chiesa dei frati cappuccini dopo la messa delle dieci, si cominciò a comprare «Il Giorno», perché era un giornale pettegolo. I padri giovani si trovavano nel pomeriggio sotto casa, in maniche di camicia, a discutere di calcio o del programma di case popolari varato da Fanfani. Dopo il riposino pomeridiano capitava che uno dei vicini, giovane sposo borghese, uno che addirittura andava al circolo a giocare a tennis con la moglie, arrivasse con la racchetta, e il divertimento consisteva nel lanciare altissima la pallina, che poi i bambini andavano a recuperare nel campo di granoturco e nei vigneti, fra le generali esclamazioni di meraviglia per la spettacolare potenza del tiro.
Più di rado, mio padre estraeva dalla custodia il clarinetto, verificava le condizioni dell’ancia, poi si scaldava il fiato e le dita, e alla fine tirava giù una Mazurka di Migliavacca, con un virtuosismo meraviglioso e uno sforzo impressionante, sicché mia madre, che passava con il caffè, diceva: Stai attento che non ti scoppi una vena nella testa.
Non si è capito subito che era successo qualcosa di importante, o di decisivo, con l’arrivo della televisione. Eppure, bastava pensare che i genitori giovani si sarebbero dati appuntamento tutti insieme, a casa di non so chi, o forse in un caffè, o perfino in un cinema attrezzato per l’occasione, per assistere alle puntate di «Lascia o raddoppia?» e di «Campanile sera». Ma il colpo di grazia, dal punto di vista sociologico, fu assestato quando una sera le ragazze pretesero di giocare al «Musichiere».
Ora, cerchiamo di intenderci: io non so un tubo di canzoni, di Mario Riva e dei cantanti, dell’orchestra del maestro Gorni Kramer, di Johnny Dorelli, Paolo Bacilieri e Nuccia Bongiovanni, e di come funziona il gioco, con le poltrone e la campanella, i premi e «Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane». Io sono cresciuto a pane e calcio, se permettete. Avevo neanche tre anni e sapevo a memoria la formazione del Milan: una sera d’estate, seduto sul vaso da notte in mutandine e canottiera, l’ho recitata agli amici di famiglia raccolti a tavola, assai compiaciuti di sentire quei nomi favolosi e della mia capacità di descrivere le qualità tecniche di giocatori mai visti. Adesso mi ricordo solo un mediano rossonero che si chiamava Annovazzi. Poi Ghiggia e Schiaffino. Chissà perché il Milan, poi. La prima squadra del cuore è stata la Roma. Sostituita poco più tardi dalla Juventus, quando arrivò a manifestarsi in Italia il genio satanico di Omar Sivori.
Sicché non era il caso di rompermi le scatole con le canzoni, il vibrato e i gorgheggi, fate il piacere. Fin dall’età di cinque anni il sottoscritto è un fenomeno del dribbling, a dispetto di due gambette scheletriche (mio padre ne sorride spesso indicandomi ai suoi amici: Lo hanno ingambato quando hanno ingambato i merli). Passo il tempo palleggiando in cortile come una foca, tentando con alterne fortune il colpo di tacco. Mi hanno regalato un formidabile album di figurine, Come si gioca al calcio, con tutte le regole e gli accorgimenti tecnici: come si colpisce di piatto, ovvero «di spazzola», di collo, di interno, di esterno, come si stoppa, come si triangola, come si porta il tackle, come si fa la finta contro il difensore avversario (il segreto è sbilanciarlo con una mossa del corpo e puntare dalla parte in cui lui ha il piede a terra, ma a pensarci mentre si gioca ci si imbroglia). Ancora adesso, quando vedo sbagliare un calcio d’angolo, mi viene in mente che cosa prescriveva il manuale, e mi chiedo perché questi stupidi non sanno tirarlo come si deve. Il pallone deve essere diretto a parabola verso il dischetto del rigore, anche un po’ più indietro, scamorze.
Il pallone: quale pallone, poi. Quando si deve acquistarlo, quello di cuoio, la scelta è tormentosa. Prendere il numero tre, come consigliano i calciatori? Ma no, è da bambini, troppo piccolo, ce ne vorrà un altro fra un anno. Allora il numero cinque, il pallone da grandi, quello definitivo? Troppo pesante, troppo impegnativo. E allora vada per la mediazione del numero quattro: anche se a questo punto si prospettano altri dilemmi. Perché c’è chi sostiene con calore il passaggio alla modernità, rappresentato dalla valvola e dall’ago da montare sulla pompa della bicicletta. Mentre i conservatori preferiscono ancora la versione vecchio stampo, con la cucitura, che rende la sfera una pera, ma «dà più garanzie».
Dopo duemila considerazioni e dubbi, da non dormirci la notte, arriva il pallone numero quattro con la cucitura, accompagnato da una scatola rotonda di grasso di balena, per tenerlo morbido. Indifferente allo sterminio dei grandi cetacei, ogni momento era buono per scendere davanti a casa e compiere prodezze balistiche, provare tiri a effetto, simulare azioni individuali, esercitarsi a palleggiare in due e in tre, e anche giocare in cinque o sei tutti contro tutti, «a porta romana», con la regola dei tre corner un rigore.
Ma siccome le ragazze insistono con il «Musichiere», si gioca. C’è una di loro, una vivace apprendista parrucchiera, che conosce tutte le canzoni dall’inizio alla fine...