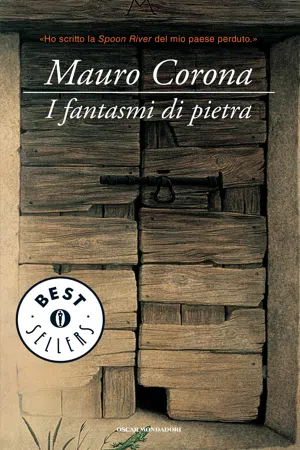Maggio è arrivato, i cuculi cantano, due o tre campi superstiti sono vangati, la terra ha ricevuto sementi, il sole le scalda, è tempo di riprendere il viaggio lungo le vie del paese abbandonato. Si va per la via Centrale, partendo da occidente, dove dorme il sole. Dovrei tralasciare la contrada Spesse, non c’è più. Fu spazzata via la notte del Vajont, con tutti gli abitanti. Ma è difficile non ricordare quell’oasi tranquilla, una radura splendida, dove viveva gente laboriosa e geniale, artigiani fantasiosi, che inventavano di tutto. Come lungo il greto del Vajont, alle Spesse c’erano segherie e mulini, tanto che la contrada si chiamava anche Mulini. Sopra quel piccolo villaggio vigilava la mole turrita del Borgà con le sue ossa di pietra, candide, sforacchiate come scheletri di uccelli rosicchiati dalle formiche. Era il regno dei bracconieri della contrada, primo su tutti Francesco Filippin detto Checo de Costantina. Si ritrovavano di notte, sempre al Passo Colòn, chiamato anche Scalèt, sotto la cima del monte. Non vi erano segreti in quella zona per i bracconieri del Passo Colòn. Era terreno loro, riserva privata, bisognava chiedere permesso prima di metter naso da quelle parti con un fucile in mano. Checo Filippin cacciava lassù anche d’inverno. Durante i gelidi bivacchi, si scaldava bruciando sterpaglie e loppe (erbe secche) che s’abbarbicavano all’asciutto sotto antri e caverne. Salire al Passo Colòn in gennaio non è uno scherzo, neppure oggi con i materiali di cui disponiamo. Scarponi termici, ghette, tute in goretex, piumini, lassù mollano la presa. Sessant’anni fa era peggio, eppure Checo saliva e stava lassù anche tre giorni. Si racconta che la vigilia di San Sebastiano, in piena notte, per non congelarsi come una rapa, incendiasse ciuffi di loppe per poi metterseli tra la giacca e il petto. Quelle brevi fiammate, che si spegnevano in un attimo, regalandogli pochi secondi di tepore gli salvarono la vita. Aspettò così fino all’alba lontana. Tutta l’estate dormiva fuori casa, in un angolo dell’orto. Vera bestiaccia, Francesco Filippin. Per arrotondare le magre entrate s’era improvvisato guida alpina. Conduceva sulle montagne, che conosceva a menadito, inglesi e tedeschi. D’estate bazzicavano da queste parti. Lo cercavano anche italiani, ma con quelli Checo non s’intrigava. Diceva che erano cragne, gente tirchia, pagava poco e niente. Non cambiava mai la sua divisa da bracconiere. Il dottor Paolo Gallo un giorno lo fotografò in posa di caccia. Tre anni dopo gli fece un’altra foto, la divisa era sempre la stessa. La barba gli arrivava alla cintola, portava un cappellaccio calcato in testa. Fumava trinciato forte. Arrotolava sigarette in brandelli di giornale. Risultavano grosse come pali. Non ebbe malattie, nemmeno un raffreddore. Morì nel Vajont. L’acqua lo spazzò via mentre stava coricato sotto una coperta nell’angolo orientale dell’orto. In contrada Spesse c’era molta acqua. Una sorgente copiosa si diramava in ogni direzione. Gli artigiani la incanalarono per far girare mulini e segherie. I più bravi realizzavano figure di legno che si muovevano sotto la spinta di minuscole ruote. Si potevano vedere nei prati ometti variopinti alti una spanna che falciavano, rastrellavano, spaccavano legna, battevano l’incudine, piallavano assi.
Due gemelli geniali avevano scolpito un intero presepe che si muoveva. Lo visitai nel settembre del 1963, rimanendo estasiato. Lo avevano costruito d’estate, con l’intenzione di lasciarlo esposto fin dopo Natale se l’acqua non gelava. Quelle figurine parevano vive. Pastori, animali, Re Magi, la Madonna, san Giuseppe, non si spostavano però alzavano le braccia in gesti di adorazione. Due pastorelli segavano legna per scaldare il Bambin Gesù. Uno di qua e uno di là del cavalletto muovevano la sega senza sosta. Chi s’inchinava, chi porgeva qualcosa, chi faceva altri lavori. Tutto era vivo in quel presepe. Per me fu una scoperta sbalorditiva. Nella frazione Spesse vivevano i più abili artigiani del paese. Gente che inventava di tutto. A primavera il luogo acquistava una bellezza da paradiso terrestre. Piccole radure circondate da larici e pini scuri punteggiavano l’intero paesaggio. Viste dal sentiero dei carbonai, sembravano occhi di gufo che spiavano la vita della gente.
Un giorno d’aprile andai a fare un giro da quelle parti. Avevo dodici anni. Era pomeriggio, i cuculi cantavano, gli uccelli s’indaffaravano attorno ai nidi, uomini e donne stavano chini sui campi con zappe e vanghe. Nella parte alta della frazione c’era una piana contornata da meli selvatici che si può ancora ammirare. L’acqua del Vajont la risparmiò. Oggi è inselvatichita, ma la sua bellezza non è venuta meno. Quel giorno dalla radura arrivava un suono. Andai a vedere cos’era quel suono. Incontrai un uomo sui trent’anni. Lo conoscevo. Stava appoggiato a un larice storto e suonava il violino. Era uno strumento bello, con un diavolo scolpito vicino all’impugnatura. Gli chiesi se me lo faceva provare. Non riuscivo a tenerlo sotto il mento, e nemmeno a cavare altro se non qualche stridio. Disse che lo aveva costruito lui, un po’ alla volta, nella sua bottega di falegname. Tutto con legni della zona. A quei tempi ogni casa aveva una camera dotata di banco da falegname e attrezzi d’ogni foggia e per ogni uso. Gli uomini, soprattutto i vecchi, costruivano tutto ciò che serviva alla famiglia. Cucchiai, forchette, piatti, scodelle, manici da falce, da zappa, da scure, slitte, slittini, secchi, grondaie, porte, finestre, scale. L’interno delle abitazioni veniva arredato con gusto. Si costruivano letti, madie, scansie, cantonali, panche, sedie, mastelli. Erano rari quelli che non sapevano usare le mani per intagliare, scolpire, scavare, piallare, assemblare. Essere buoni artigiani significava sopravvivenza. Gli uni imparavano dagli altri. E si tramandava l’arte ai figli. Quelli delle Spesse erano i migliori. Entrare in uno di quei laboratori era un’emozione mozzafiato. Soprattutto per un ragazzino. Il caos regnava sovrano. Lavori appena abbozzati occhieggiavano dappertutto. Utensili dalle forme strampalate suscitavano domande: “A cosa servirà?”. Alcuni artigiani avevano anche il tornio, fatto girare da una lunga e flessibile pertica di frassino mossa dal piede. Con quello creavano pestatali, arcolai, ciotole.
L’uomo della radura suonava alla buona il suo violino. Avendolo costruito senza alcuna nozione, non aveva idea di come fosse il suono. Non era uno Stradivari o un Guarnieri del Gesù, ma a me piaceva ascoltarlo e ammiravo colui che lo aveva costruito. Le corde e il crine dell’archetto disse che le aveva comperate a Padova. Quando s’accorse che lasciavo gli occhi sullo strumento, promise che me ne avrebbe fatto uno quella stessa primavera. Ma doveva tagliare il legno il 21 maggio, dopo mezzanotte, quando il bosco si mette a cantare. «Allora sì che il violino suona bene» disse. Quel violino non lo costruì mai. Venne il Vajont che gli rubò moglie e figli. Lui si salvò perché era via. Perse la voglia di costruire violini e quella di vivere. Iniziò a bere. La sorte in seguito gli riservò drammi a non finire, compreso il carcere per una brutta storia di omicidio. Lo rividi dopo trent’anni. Venne a trovarmi a casa. «Mi hai fatto il violino?» chiesi. Non ricordava nessun violino né i particolari che io invece rammentavo. Allora gli dissi di quando lo avevo incontrato nella radura poco prima del Vajont, mentre suonava un violino fatto da lui. A quel punto ricordò e le lacrime gli rigarono il volto, che non era cambiato quasi niente in tutti quegli anni. Morì di lì a poco per stanchezza di esistere. Che non è il suicidio diretto ma un lasciarsi andare lentamente, giorno dopo giorno, guardando lontano verso chissà quale ricordo.
Mi viene in mente un uomo grande e grosso che viveva solo in una casupola altrettanto solitaria. Quell’omone era ghiotto di una cosa: i pulcini appena nati degli uccelli, soprattutto quaglie, merli e tordi. In primavera, durante il periodo dei nidi, mandava me e mio fratello a caccia di quei minuscoli esserini ancora implumi. Dovevamo rubarli dai nidi prima che mettessero la peluria, altrimenti non ce li pagava. Nella teglia faceva fondere un’unghia di burro, aggiungeva due manciate di erbe aromatiche e vi buttava gli uccellini senza pulirli dalle interiora. Diceva che il buono stava proprio nelle microscopiche budella. Non tagliava nemmeno il becco, era molle come argilla. All’inizio glieli portavamo vivi, in un sacchetto. Venti, venticinque bocciolini rosei che pigolavano chiedendo da mangiare. Saccheggiavamo tutti i nidi delle valli attorno al paese. Ci dava trenta lire a sacchetto, non importa se erano tanti o pochi. Pagava alla consegna. Con quei soldi compravamo carrube e castagne secche. Un giorno si stufò che gli portassimo gli uccellini vivi. Disse che ci avrebbe aumentato la paga se li portavamo già morti. «Non siamo capaci di ucciderli» balbettai. «È facile» disse. Afferrò una alla volta quelle testoline tra pollice e indice e, facendo pressione con quelle dita grosse come pali, le faceva scoppiare con un puff che pareva un soffio. «Dovete fare così» farfugliò indifferente, «se me li portate morti vi do dieci lire in più.»
Vedendo quell’uomo grande e grosso dal viso buono che ispirava fiducia, verso il quale nutrivamo simpatia, uccidere i pulcini come niente fosse, mio fratello e io ci convincemmo che era una cosa normale, una cosa da fare e basta. Spazzando via paure, indecisioni e soprattutto sensi di colpa, iniziammo a far scoppiare le testoline ai piccoli prima di portarli al nostro amico. All’inizio ci fu qualche riluttanza. Non era facile premere pollice e indice su quei capini fragilissimi, con gli occhi ancora chiusi. Ci frenava un istinto sconosciuto ma presente, come un dolore dentro. Forse era la coscienza di compiere un’azione contro natura. Ma il nostro amico aveva detto che era normale schiacciare le teste agli uccellini per mangiarli. Fino a una certa età, i ragazzini pendono dalle labbra dei grandi. Ciò che gli adulti insegnano ai bambini viene preso come Vangelo. Ogni senso di colpa dettato dall’istinto che, seppur vagamente, suggerisce dove stanno il bene e il male, viene messo da parte senza indugi. Dopo alcuni giorni di caccia, far scoppiare le teste agli uccellini era diventato un gioco. Facevamo a chi era più veloce a frantumarle. Spesso le mamme ci seguivano volando disperate fino alla casa del buongustaio. La raccolta andò avanti per anni, primavera dopo primavera, fino al 1963 quando il nostro committente scomparve nell’acqua del Vajont. Ci ho messo diverso tempo a capire quanto brutale fosse quella pratica. Tornare sui sentieri giusti dopo essere stati educati a ignorarli non è facile. Occorre un intenso esercizio di revisione per mettere i piedi di nuovo sul buono. Tale esercizio può durare anni, e non sempre dà risultati. Alla fine pochi riescono a migliorare, gli altri continuano a percorrere il sentiero sbagliato convinti di stare nel bene, convinti di far giusto. Io sto fra questi ultimi. Non ho più schiacciato le teste agli uccellini, ho fatto di peggio.
Abbandono con la memoria la contrada Mulini che non esiste più. Delle case sono rimasti soltanto i pavimenti di pietra incollati alla terra. Il resto cancellato. Dopo il Vajont un superstite, Svaldin Benetto, salvatosi perché era a Torino, volle ricostruire la casa nel punto in cui si trovava prima che l’acqua la spazzasse via. Fece tutto con le sue mani e i suoi soldi. Per sentirsi meno solo adattò la cucina a osteria. Con la scusa di bere un bicchiere, qualcuno andava a trovarlo. Quando fummo più grandi iniziammo a frequentare quel bar fuori mano. Io, Silvio, Carle, l’Altro Carle, Sepp e compagnia ne diventammo assidui visitatori. Sulla parete di fronte all’entrata aveva attaccato una foto incorniciata, contenente i volti dei famigliari morti nel Vajont. Quattordici persone. Fratelli, sorelle, nipoti, il padre. Tra loro anche i gemelli autori del presepe che si muoveva con l’acqua. Attaccò quella foto al muro e non parlò più di Vajont per quanto gli restò da vivere. Se qualche turista gli chiedeva informazioni alzava le spalle. Alcuni metri sotto la casa costruì un tempietto corredato dalle foto dei morti di contrada Mulini. Sessantasette foto. Lo scultore Flavio Pancheri di Ortisei scolpì nel tiglio un crocefisso quasi a grandezza naturale. Svaldin lo inchiodò sulla parete di fondo che guarda l’entrata. Fu tutto. Rimase col suo dolore, taciturno e mite, finché non morì a settantadue anni per infarto. Aveva cercato di ridare un po’ di vita alla contrada Mulini cancellata dalla morte. Un poco vi era riuscito.
Di notte, quando passavamo da quelle parti, si vedeva la lampadina dell’osteria forare il buio. Pareva un occhio di gufo. Nelle sere d’autunno, quando le nebbie correvano per la valle come fantasmi silenziosi, quel lume accendeva polveri d’oro attorno alla casa. Ma tutto questo non bastava a far rivivere i Mulini. Non vi erano più case, non vi era più gente, né boschi, né prati, né alberi da frutta. Tutto piallato quella notte. Rimaneva solo lui, Svaldin Benetto e la moglie Albina, solitari guardiani di quelle terre desolate, graffiate fino all’osso, spazzate dal vento.
Terre dove un tempo ferveva la vita, l’erba cresceva con i fiori, il bestiame con i bambini, e gli artigiani invecchiavano con le loro creazioni tra le mani. Ora non c’è più nulla. Oggi, anno 2006, è rimasta soltanto Albina, indomita e tenace, a vegliare la terra abbandonata. Una selva disordinata e chiassosa è tornata pian piano a dare un po’ di verde sui segni spaventosi di quella lontana tragedia, costruita mattone su mattone da uomini arroganti e avidi, la cui unica connotazione era il cinismo.
Proseguo verso oriente. Dal colle del Chastòn arrivano fino in paese canti di galli forcelli. I cuculi sbraitano più vicini, sul Col delle Acacie e sul Col delle Pale. Passo davanti a due case vicine, vuote. Un tempo furono mitiche osterie. Nonostante le separassero solo pochi metri, non vi fu mai rivalità. Quando c’è miseria ce n’è per tutti, non conviene baruffare per rubarsi l’osso. È più utile passarselo, fare in modo che rosicchi un po’ l’uno e un po’ l’altro. L’osso erano i clienti. Se li tenevano da conto e così andavano nell’una e nell’altra osteria senza beghe o preferenze. In una di quelle bettole accoglienti e pittoresche apparve il primo televisore del paese. Era verso il 1960. Fu una rivoluzione. Alla sera tutti correvano a vedere quei pochi programmi in bianco e nero. Rin Tin Tin lo davano al pomeriggio, l’ora permessa ai ragazzini. Ogni volta mi pareva di assistere a un miracolo. Mai avrei pensato di vedere roba simile. Non tanto per le avventure del cane e del suo giovane amico, bensì per il fatto di vederli a pochi metri dentro una scatola di vetro. Pilòn, un uomo tarchiato e irascibile, approfittava tutte le sere di quella strabiliante invenzione. S’incollava al video e non si muoveva più. Ma non beveva, non consumava nulla, nemmeno un bicchiere di acqua minerale. Alla fine l’oste si era rotto le palle. In fondo aveva piazzato l’apparecchio per incentivare le consumazioni. Una sera che cercavo di trascinare via mio padre ubriaco, lo udii bestemmiare di brutto. Dopodiché, rivolto agli avventori, sbraitò: «Quell’avaro di Pilòn non beve nemmeno se mangia sale!». Con il televisore come concorrente, l’osteria vicina subì un certo tracollo. Consci del problema, gli avventori televisivi, prima di godersi i programmi, andavano a bere nella bettola sfortunata in modo da limitare i danni.
Il mio passo procede accanto al vecchio muro tappezzato di muschio. M’accompagna verso il camposanto. Fino a pochi anni fa il nostro cimitero era una reliquia. Guai toccarlo. Oggi lo è un po’ meno. Scavano le fosse con la ruspa, non c’è più il vecchio becchino che lavorava di pala e piccone. Un tempo curavano le tombe una per una, come minuscoli orti. Non mancavano mai rami di mugo e stelle alpine. Fiori ci sono anche adesso ma, come ebbe a dire Rilke, “Oggi, la morte dell’uomo si è fatta più piccola”. Si bada meno alla cura delle fosse. Manca la voglia, forse il tempo. Vi sono tante cose da fare, da gestire, in quest’epoca caotica e confusa. Per la prima volta dopo secoli nel cimitero sono comparsi i loculi. Fino a poco tempo fa i morti andavano nella terra, oggi vanno nei loculi. C’è bisogno di spazio. Pare che quassù si muoia più che altrove nonostante la durata della vita sia andata avanti.
È primavera. I due tassi secolari che vigilano l’entrata del camposanto si portano la fioritura addosso. Hanno udito gente piangere e accompagnato quelli che tacevano per sempre. Hanno visto morti varcare la soglia, e vivi che vanno a trovare coloro che non ci sono più. Una visita ogni tanto, lungo le stagioni, anno dopo anno. Alla fine anche quelli che visitavano i loro morti varcheranno la soglia per l’ultima volta. E qualcuno li andrà a trovare finché non verrà il suo turno. Il cancello di Mano del Conte aspetta tutti.
Tempo fa si era deciso di abbattere i tassi per paura che crollassero sotto i temporali, spaccando le lapidi. Sono grossi, hanno due secoli. I tassi crescono piano, un pochino all’anno. Con discorso paziente e ragionando un poco, dissuasi i responsabili del progetto. Per ora i severi guardiani dei defunti sono ancora là, che aspettano il prossimo morto per salutarlo l’ultima volta, per piangere assieme ai parenti. Quando venne stabilito di abbatterli, il becchino disse che me li avrebbe regalati da far statue. Il tasso è un albero eccezionale da scolpire. Duro, compatto, di grana fine, colore rosso fiammato, si presta a eccellente politura. Dopo una mano di cera d’api, il risultato è stupefacente. Le venature gialline emergono dal rosso come fili d’oro che avvolgono a spirale tutta la scultura. Rifiutai decisamente. Non volevo venissero tagliati, ma soprattutto mi sovvenne una storia che raccontava il nonno. Due secoli fa, nel cimitero davanti alla chiesa, era stato abbattuto un tasso di trecento anni. La parte alta fu bruciata, ma i primi due metri, dritti e senza rami, il prete li regalò a un tornitore che cavasse degli oggetti. L’artigiano non lasciò neppure che si stagionasse, iniziò subito il lavoro. In un giorno tornì un arcolaio, un attaccapanni sul quale appese la giacca e una decina di zufoli. Soddisfatto andò a dormire, ma non dormì. A mezzanotte udì rumori strani provenire dalla polverosa bottega. Si alzò per vedere, temeva i ladri. Col lume sollevato varcò la soglia. Quel che vide gli fece accapponare la pelle. L’arcolaio girava da solo a velocità vertiginosa con cigolii spaventosi. La giacca sull’attaccapanni sbatteva in qua e in là, le maniche s’agitavano come braccia che lanciano maledizioni. I pifferi emettevano urla e lamenti terrificanti, tutti insieme, con suoni diversi. Fuggì terrorizzato passando il resto della notte in canonica sulla panca del prete. Ancora tremante ricordò che, mentre torniva, dal legno colava una linfa oleosa che pareva sangue, ma aveva imputato il fenomeno al colore del tasso.
Ne parlò al prete, il quale disse che occorreva benedire la casa immediatamente. Di buon’ora, assieme a un assonnato chierichetto, i due si recarono alla bottega. Aperta la porta videro una scena raccapricciante. Tutt’intorno le pareti erano chiazzate di sangue, la giacca era lorda di sangue, le bocche degli zufoli erano intasate da sangue rappreso come tappi di ceralacca. Il prete benedì, ma gli tremavano le gambe. Disse all’artigiano che si doveva portare il resto del tasso al cimitero, assieme agli oggetti torniti, e seppellirli. Cosa che fecero il giorno stesso. L’artigiano tornò al laboratorio per lavare le pareti, ma non trovò traccia di sangue. Il prete la benedisse una seconda volta e tutto finì. La bottega tornò silenziosa, non si udì più alcun rumore. Ma nelle case dov’era stata bruciata la parte alta del tasso non vi fu pace. Appena si accendeva il fuoco, un lugubre lamento di morti ululava su per la canna fumaria. Urla spaventose, pianti, ruggiti, salivano assieme al fumo lungo le pareti del camino e continuavano a risuonare anche fuori, spandendosi nel cielo e terrorizzando l’intero villaggio. Fu interpellato il vescovo, il quale consigliò di piantare un tasso giovane nel cimitero il giorno dei morti. Gli uomini dissero che il giorno dei morti non è tempo da piantare alberi. La terra è dura, fa freddo, nessuna pianta attecchisce a novembre. Ma il vescovo li pregò di farlo. «Per il vostro bene» disse. Se volevano ridare pace alle anime urlanti nei camini e trovare pace loro stessi, dovevano farlo, a tutti i costi. Occorreva avere fede. Allora, verso la fine di ottobre, sei uomini si recarono in Val Zemola, sotto i boschi della Bécola dove crescono i tassi. Trovarono e cavarono due giovani esemplari. «Due fanno più miracolo» dissero. Il giorno dei morti li misero a dimora nel cimitero. Uno accanto all’altro, subito dopo l’entrata. Parevano chierichetti. La gente era convinta che sarebbero morti di freddo, novembre non è stagione da piantumare. Invece attecchirono. A primavera misero foglioline e, nello stesso momento, cessarono gli ululati lungo le canne fumarie. I tassi stanno ancora là. Sono gli stessi che si voleva abbattere alcuni anni or sono, e che invece furono risparmiati. Ecco perché rifiutai con fermezza l’offerta del becchino che voleva regalarmeli. Se in futuro verranno tagliati per qualsiasi motivo, non prenderò nemmeno una scheggia né un ramo, tanto meno una radice o una foglia per farne uso.
Quando si decise di rimodernare il cimitero, qualche paesano brontolò, alcuni insorsero. Alla gente di montagna puoi fare di tutto, è paziente, tollerante, comprensiva, ma non toccargli i morti. Se gli tocchi i morti sono dolori.
In primavera coprivamo le fosse con fiori dei monti. Se t’affacciavi al portone sentivi profumi di mughetto, moretto e viole. Sortiva assieme a quello delle candele. Gli attrezzi da sepoltura erano pala, piccone, la mazza per piantare le croci e un rastrello coi denti di ferro. Oggi, una minuscola escavatrice parcheggiata in un angolo aspetta il morto. Vi sono tombe in subbuglio, lapidi spostate, rotte, alcune datate prima del Milleottocento. Capolavori di scultura unici. Molte opere sono in corso, stanno aprendo entrate nuove, erigono altri muri, spostano ossa, rimuovono morti. Più che un cimitero sembra un cantiere. Tutto per pochi metri quadrati di terra. Non c’è mai stato tanto rumore in quella terra come durante il periodo di abbellimento. Per secoli vi ha regnato il malinconico silenzio della mort...