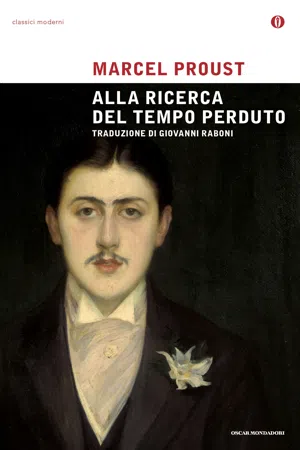![]()
A Léon Daudet,
l’autore
del Voyage de Shakespeare,
del Partage de l'Enfant,
dell'Astre noir,
di Fantômes et Vivant,
del Monde des Images,
di tanti capolavori.
All’incomparabile amico,
in segno di gratitudine
e ammirazione.
M.P.
![]()
Il pigolìo mattutino degli uccelli sembrava insipido a Françoise. La minima parola pronunciata dalle “donne” la faceva sussultare; disturbata da ogni loro passo, se ne chiedeva il perché: avevamo traslocato. Non che, al sesto piano della nostra vecchia abitazione, i domestici si muovessero meno; ma quelli li conosceva; i loro andirivieni se li era fatti amici. Adesso, persino al silenzio prestava un’attenzione dolorosa. E poiché il nostro nuovo quartiere pareva tanto calmo quant’era rumoroso il boulevard sul quale davano prima le nostre finestre, il canto d’un passante (nitido anche quando, da lontano, giunge fievole come un motivo d’orchestra) faceva venire le lacrime agli occhi a Françoise in esilio. Così, se m’ero preso gioco di lei che, desolata di dover lasciare uno stabile dove eravamo “tanto stimati dappertutto”, aveva fatto i bagagli piangendo, secondo il rituale di Combray, e proclamando la superiorità di quella in cui avevamo abitato su tutte le case possibili, in compenso mi riavvicinai alla nostra vecchia domestica quando m’accorsi – io portato ad assimilare le cose nuove con difficoltà pari alla disinvoltura con cui abbandonavo le vecchie – che installarsi in una casa senza aver ricevuto dal portiere, il quale non ci conosceva ancora, i segni di considerazione necessari al suo buon nutrimento morale, l’aveva sprofondata in uno stato prossimo al deperimento. Lei sola poteva capirmi; non certo il suo giovane aiutante, per il quale, estraneo com’era al clima di Combray, andare ad abitare in una casa nuova, in un altro quartiere, era come prendersi una vacanza, in cui la novità delle cose produceva lo stesso senso di riposo che deriva dal viaggiare; si credeva in campagna; e un raffreddore di testa gli diede, come un “colpo d’aria” preso sul treno, in uno scompartimento dal finestrino malchiuso, l’impressione deliziosa d’aver visto un po’ di mondo; a ogni starnuto, si rallegrava d’aver trovato un posto così elegante, dopo aver tanto desiderato dei padroni che viaggiassero molto. Perciò, ignorandolo, andai a colpo sicuro da Françoise; e lei, siccome avevo riso delle sue lacrime per un distacco che mi aveva lasciato invece indifferente, si mostrò glaciale, proprio perché la condivideva, di fronte alla mia tristezza. L’egoismo delle persone nervose s’accresce con la loro pretesa “sensibilità”; non possono sopportare che qualcun altro esibisca i malesseri cui dedicano in se stessi un’attenzione sempre più intensa. Françoise, che non si lasciava sfuggire il più lieve dei suoi, si voltava dall’altra parte se ero io a soffrire, per non darmi la soddisfazione di veder compatita o, semplicemente, notata la mia sofferenza. Così fece anche quando tentai di parlarle della nuova casa. D’altronde, poiché due giorni dopo le era toccato d’andare a cercare dei vestiti rimasti per una dimenticanza nell’appartamento sgomberato, Françoise – mentre io avevo ancora, in conseguenza del trasloco, un po’ di “temperatura” e, come un serpente boa che abbia appena finito d’inghiottire un bue, mi sentivo penosamente gonfio e deforme per via d’una lunga cassapanca che la mia vista doveva “digerire” – tornò dichiarando, con infedeltà affatto femminile, che nel nostro vecchio boulevard le era parso di soffocare, che strada facendo s’era sentita tutta “scombussolata”, che mai aveva visto scale tanto scomode, che non sarebbe tornata ad abitare laggiù nemmeno se – ipotesi gratuite – le avessero “regalato un impero” o promesso dei milioni – e che tutto (vale a dire quel che concerneva cucina e corridoi) era, nella nostra nuova casa, incomparabilmente più “ben messo”. Ora, è tempo di dire che questa nuova casa – dove eravamo venuti ad abitare perché la nonna, in non buona salute (ragione che, con lei, ci eravamo ben guardati dall’addurre), aveva bisogno d’aria più pura – era un appartamento situato in una dépendance di palazzo Guermantes.
All’età nella quale i Nomi, offrendoci l’immagine dell’inconoscibile che vi abbiamo infuso, nel momento stesso in cui designano per noi anche un luogo reale, ci costringono in tal modo a identificare l’uno con l’altro, tanto che ci rechiamo in una città alla ricerca di un’anima di cui questa non può certo costituire l’involucro, ma che non è più in nostro potere espellere dal suo nome, non è soltanto alle città e ai fiumi ch’essi attribuiscono, come i dipinti allegorici, un’individualità, non è soltanto l’universo fisico ch’essi screziano di differenze e popolano di meraviglioso, ma anche l’universo sociale: ogni castello, allora, ogni famoso palazzo o residenza ha la sua regina o la sua fata, così come le foreste hanno i loro geni, e le loro divinità le acque. A volte la fata, nascosta in fondo al proprio nome, si trasforma seguendo l’evolversi della nostra immaginazione, che la nutre; allo stesso modo, l’atmosfera nella quale Madame de Guermantes esisteva dentro di me cominciava – dopo essere stata, per anni, nient’altro che il riflesso d’una lastra di lanterna magica o d’una vetrata di chiesa – a spegnere i suoi colori, quando ben altri sogni l’intrisero della schiumosa umidità dei torrenti.
Tuttavia, se ci accostiamo alla persona reale cui corrisponde il suo nome, la fata deperisce, giacché quella persona, allora, il nome comincia a rifletterla, e in lei non c’è niente della fata; questa può rinascere se ci allontaniamo da quella; ma se le restiamo accanto, la fata muore definitivamente, e con lei il nome, come quella famiglia Lusignano che avrebbe dovuto estinguersi il giorno in cui fosse scomparsa la fata Melusina. Allora il Nome, sotto le cui successive ridipinture potremmo finire col trovare il bel ritratto originario d’una straniera mai vista prima, si riduce a una semplice carta fotografica d’identità alla quale facciamo riferimento per sapere se conosciamo, se dobbiamo o no salutare una persona di passaggio. Ma basta che una sensazione di un anno lontano – simile a quegli strumenti musicali capaci di conservare, come li avessero registrati, la sonorità e lo stile dei vari artisti che li suonarono – consenta alla nostra memoria di farci riudire quel nome con il timbro particolare con cui s’offriva allora al nostro orecchio ed ecco che, immutato in apparenza quel nome, avvertiamo tutta la distanza fra l’uno e l’altro dei sogni di cui le sue sillabe identiche sono state per noi, in tempi successivi, portatrici. Per un attimo, dal riascoltato accento ch’esso aveva in quella certa, remota primavera, possiamo estrarre, come dai tubetti utilizzati per dipingere, la sfumatura giusta, obliata, misteriosa e fragrante dei giorni che ci era parso di ricordare quando, come i cattivi pittori, davamo al nostro passato disteso per intero su un’unica tela le tonalità convenzionali, e tutte simili fra loro, della memoria volontaria. Ora, ciascuno dei momenti che lo composero impiegava invece in un’armonia senza pari, per una creazione originale, i colori di quel tempo, che noi non conosciamo più e che, ad esempio, ancora mi rapiscono all’improvviso se, per combinazione, riacquistando per un istante, dopo tanti anni, il suono – oggi così diverso – con cui giungeva al mio orecchio nel giorno del matrimonio di Mademoiselle Percepied, il nome Guermantes mi restituisce quel mauve così dolce, troppo brillante, troppo nuovo, che vellutava la cravatta mollemente rigonfia della giovane duchessa e, simili a una pervinca inattingibile e rifiorita, i suoi occhi soleggiati da un azzurro sorriso. Ed è anche, il nome Guermantes d’allora, come uno di quei palloncini in cui è stato immesso dell’ossigeno, o un altro gas: quando riesco a farlo scoppiare, a farne uscire il contenuto, respiro l’aria di Combray in quell’anno, in quel giorno, mista a un profumo di biancospini trasportato dal vento che veniva dall’angolo della piazza ad annunciare la pioggia e, alternativamente, faceva sparire il sole o lasciava che si stendesse sul tappeto di lana rossa della sacrestia rivestendolo d’un incarnato acceso, quasi roseo, da geranio, e di quella dolcezza, che si potrebbe dire wagneriana, nell’esultanza, grazie alla quale le feste conservano tanta nobiltà. Ma anche prescindendo da questi rari minuti, durante i quali sentiamo l’entità originale trasalire bruscamente e riprendere la sua forma e la sua cesellatura all’interno di sillabe ormai morte, se nel turbine vertiginoso della vita quotidiana, dove si sono ridotti a un’utilità puramente pratica, i nomi hanno perduto ogni colore, come una trottola prismatica che prilla così vorticosamente da sembrarci grigia, in compenso, quando nelle nostre fantasticherie, nelle nostre meditazioni, ci sforziamo, per recuperare il passato, di rallentare, di sospendere il moto perpetuo che ci trascina, vediamo a poco a poco riaffiorare, giustapposti ma perfettamente distinti l’uno dall’altro, i colori che un medesimo nome ci ha via via presentati nel corso della nostra esistenza.
Certo, quale forma si profilasse ai miei occhi nel nome Guermantes quando la mia balia – che sicuramente ignorava, come io stesso oggi ignoro, in onore di chi fosse stata composta – mi cullava con la vecchia canzone Gloria alla marchesa di Guermantes, o quando, alcuni anni dopo, ai Champs-Élysées, il vecchio maresciallo di Guermantes, colmando d’orgoglio la mia domestica, si fermava a commentare: «Che bel bambino!» e, tratta di tasca una bomboniera, mi offriva una pastiglia di cioccolato, questo non lo so dire. Gli anni della mia prima infanzia non sono più dentro di me, mi rimangono esterni, non posso apprenderne nulla, come di ciò che è avvenuto prima della nascita, se non dai racconti degli altri. Ma più tardi, nella durata in me di quello stesso nome, trovo disposte in successione sette o otto figure diverse; le prime erano le più belle: a poco a poco, spinto dalla realtà ad abbandonare una posizione indifendibile, il mio sogno veniva via via attestandosi un po’ più in qua, finché non fosse costretto a ripiegare ulteriormente. E, con Madame de Guermantes, si trasformava in pari tempo la sua dimora, generata anch’essa dal medesimo nome che questa o quella parola, il cui ascolto sopraggiungeva a modificare le mie fantasie (riflesse dalla dimora nelle sue stesse pietre, fattesi specchianti come la superficie d’una nube o d’un lago), d’anno in anno fecondava. Un torrione privo di spessore, nient’altro che una striscia di luce aranciata, dall’alto del quale il signore e la sua dama decidevano della vita e della morte dei loro vassalli, aveva ceduto il posto – ai confini estremi di quella “parte di Guermantes” dove, in tanti pomeriggi sereni, seguivo con i miei genitori il corso della Vivonne – al territorio ricco di torrenti dove la duchessa mi insegnava a pescare la trota e a dare un nome ai fiori dai grappoli violacei e rossastri che ornavano le basse recinzioni delle tenute circostanti; poi era stata la volta della terra ereditaria, del poetico dominio dove la razza altera dei Guermantes, simile a una torre che, biondeggiante di rosoni, avanzi attraverso i secoli, svettava già sulla Francia quando ancora il cielo era vuoto là dove, in seguito, sarebbero sorte Notre-Dame di Parigi e Notre-Dame di Chartres; quando sulla cima della collina di Laon la navata della cattedrale non s’era ancora posata come l’Arca del Diluvio sulla cima del monte Ararat, gremita di Patriarchi e di Giusti che ansiosamente si sporgono dalle finestre per vedere se la collera divina si sia placata, carica di tutti i tipi di vegetali destinati a moltiplicarsi sulla terra, straripante di animali che sbucano persino dalle torri dove qualche bue, passeggiando tranquillamente sulla copertura dell’edificio, contempla dall’alto le pianure della Champagne; quando il viaggiatore che, sul finire del giorno, lasciava Beauvais, non vedeva ancora le ali nere e ramificate della cattedrale seguirlo volteggiando, spiegate contro il sipario d’oro del tramonto. Era, il Guermantes d’allora, come la cornice d’un romanzo, un paesaggio immaginario che tanto più desideravo di scoprire quanto più duravo fatica a rappresentarmelo, incuneato fra terre e itinerari reali che tutt’a un tratto, a due leghe da una stazione ferroviaria, s’impregnavano di particolarità araldiche; ricordavo i nomi delle località contigue come se queste si fossero trovate ai piedi del Parnaso o dell’Elicona, e mi sembravano preziose come – nell’ambito della scienza topografica – le condizioni materiali legate al prodursi di un fenomeno misterioso. Rivedevo gli stemmi dipinti sui basamenti delle vetrate di Combray, i cui quarti s’erano riempiti, secolo dopo secolo, di tutte le signorie che l’illustre casata aveva fatto volare a sé, per via di matrimoni o acquisizioni, da ogni angolo di Germania, Italia e Francia: immensi territori del Nord, potenti città del Mezzogiorno, venuti a congiungersi e combinarsi in Guermantes e ad iscrivere allegoricamente nel suo campo azzurro, perdendo la propria materialità, un torrione verde smalto o un castello d’argento. Avevo sentito parlare dei celebri arazzi di Guermantes e li vedevo, medievali e turchini, un po’ grezzi, stagliarsi come una nube sul leggendario amaranto del nome, ai piedi dell’antica foresta dove così spesso cacciò Childeberto, e quella misteriosa profondità delle terre, quella lontananza dei secoli, mi sembrava che avrei potuto penetrarne, come viaggiando, i segreti, se solo mi fosse riuscito d’avvicinare un istante, a Parigi, Madame de Guermantes, sovrana del luogo e signora del lago, quasi che il suo volto e le sue parole dovessero necessariamente possedere lo specifico incanto delle fustaie e delle rive e le medesime, secolari particolarità dell’antica raccolta di norme consuetudinarie conservata nei suoi archivi. Ma, a quel tempo, avevo conosciuto Saint-Loup; da lui avevo saputo che il castello si chiamava Guermantes soltanto dal XVII secolo, quando la famiglia l’aveva acquisito. Prima, essa aveva avuto la propria residenza lì vicino, e il suo titolo non veniva da quella regione. Il villaggio di Guermantes aveva preso nome dal castello presso il quale era stato costruito, e una servitù rimasta in vigore regolava il tracciato delle strade e limitava l’altezza delle case per non alterarne le prospettive. Quanto agli arazzi, erano di Boucher, li aveva comprati, nel XIX secolo, un Guermantes appassionato d’arte, e stavano appesi, accanto a mediocri scene di caccia da lui stesso dipinte, in un orripilante salotto drappeggiato di raso rosso e di peluche. In seguito a queste rivelazioni, con cui Saint-Loup aveva introdotto nel castello elementi estranei al nome Guermantes, non mi fu più possibile continuare ad estrarre unicamente dalla sonorità delle sillabe la muratura degli edifici. Scomparso in fondo al nome il castello riflesso nel lago, intorno a Madame de Guermantes m’era apparsa come sua dimora la residenza di Parigi, il palazzo Guermantes, limpido come il suo nome, senza nessun elemento opaco e materiale che ne interrompesse e offuscasse la trasparenza. Come “chiesa” non designa solo il tempio, ma anche la comunità dei fedeli, così “palazzo Guermantes” comprendeva tutti coloro che partecipavano della vita della duchessa; ma questi intimi, che non avevo mai visti, non erano per me che nomi celebri e poetici, e dal momento che conoscevano unicamente persone le quali erano, a loro volta, semplici nomi, non facevano che ampliare e proteggere il mistero della duchessa, stendendole tutt’intorno un vasto alone che, al massimo, andava gradatamente sfumando.
Nelle feste che dava Madame de Guermantes, poiché non immaginavo per gli invitati né corpo, né baffi o stivaletti, né frase pronunciata che fosse, non dico banale, ma nemmeno originale nel senso umano e razionale del termine, il turbinio dei nomi – non raccogliendo, intorno a quella statuetta di porcellana di Saxe che era la duchessa, più materia d’una cena di fantasmi o d’un ballo di spettri – conservava al suo palazzo di vetro la trasparenza d’una bacheca. In seguito, dopo che Saint-Loup m’ebbe raccontato alcuni aneddoti relativi al cappellano, ai giardinieri di sua cugina, il palazzo Guermantes era diventato – così come, un tempo, poteva esserlo stato un Louvre – una sorta di castello circondato, nel centro stesso di Parigi, dalle sue terre, posseduto a titolo ereditario in virtù d’un antico diritto bizzarramente sopravvissuto, e sulle quali la duchessa esercitava ancora privilegi feudali. Ma quest’ultima dimora era a sua volta svanita quando eravamo venuti ad abitare vicinissimo a Madame de Villeparisis, in uno degli appartamenti confinanti con quello di Madame de Guermantes, in un’ala del suo palazzo. Era una di quelle vecchie dimore come, forse, ne esiste ancora qualcuna, il cui cortile d’onore – si trattasse di detriti accumulati dall’alluvione della democrazia o di lasciti di tempi più antichi, quando i diversi mestieri gravitavano intorno al signore – aveva spesso, sui lati, dei retrobottega, dei laboratori, se non addirittura qualche botteguccia di calzolaio o di sarto, simili a quelle che si vedono addossate ai fianchi delle cattedrali che l’estetica degli ingegneri non ha ancora “ripulite”, o un portiere ciabattino che allevava polli e coltivava fiori – e in fondo, nella parte della costruzione che “faceva palazzo”, una “contessa” che quando usciva nel suo vecchio calesse a due cavalli (col cappellino ingentilito da qualche nasturzio appena scappato, si sarebbe detto, dal giardinetto della portineria e, accanto al cocchiere, un lacchè incaricato di distribuire biglietti da visita con l’angolo ripiegato in tutti i palazzi aristocratici del quartiere) elargiva indistintamente sorrisi e lievi cenni di saluto ai figli del portiere e ai locatari borghesi dello stabile che passassero in quell’istante e di cui lei, nella sua sdegnosa affabilità e nel suo sussiego egualitario, faceva un sol fascio.
Nella casa dove ci eravamo trasferiti, la gran dama in fondo al cortile era una duchessa, elegante e ancora giovane. Era Madame de Guermantes – e, grazie a Françoise, non tardai a entrare in possesso di informazioni sul palazzo. Infatti i Guermantes (cui Françoise si riferiva spesso con le locuzioni “di sotto”, “da basso”) costituivano la sua costante preoccupazione dal mattino, quando – pettinando mia madre – lanciava un’occhiata proibita, irresistibile e furtiva in cortile, per poi commentare: «To’, due suore; vanno sicuro “di sotto”», oppure: «Che belli quei fagiani alla finestra della cucina! Inutile chiedere da dove divengono, il duca sarà stato a caccia», fino alla sera, quando, se nel portarmi l’occorrente per la notte sentiva un rumore di pianoforte, un’eco di canzonette, ne deduceva: «“Da basso” hanno gente, c’è allegria»; allora nel suo viso regolare, sotto i capelli ormai bianchi, un sorriso della sua giovinezza, animato e dignitoso, metteva ben a posto, per un istante, ciascuno dei suoi tratti, armonizzandoli in un ordine fine e un po’ affettato, come per una contraddanza.
Ma il momento della vita dei Guermantes che più suscitava l’interesse di Françoise, le dava più soddisfazione e, insieme, le faceva più male, era per l’appunto quello in cui si spalancavano entrambi i battenti del portone e la duchessa saliva sul suo calesse. Accadeva, di solito, poco dopo che i nostri domestici avevano finito di celebrare quella sorta di solennità ebraica, cui nessuno doveva recare turbamento, che era il loro pasto del mezzogiorno, durante il quale erano essi stessi così “tabù” che nemmeno mio padre si sarebbe mai permesso di suonare per chiamarli, ben sapendo, d’altronde, che nessuno si sarebbe scomodato alla quinta scampanellata più che alla prima e ch’egli avrebbe dunque commesso una sconvenienza in pura perdita, ma non priva, per lui, di conseguenze negative. Infatti Françoise (che, da quando era vecchia, assumeva in ogni situazione quella che si chiama “una faccia di circostanza”) gli avrebbe immancabilmente presentato, per l’intera giornata, un viso coperto di piccoli segni cuneiformi e rossastri, destinati a manifestare esteriormente, ma in modo quasi indecifrabile, l’interminabile lista delle sue lagnanze e le ragioni profonde del suo scontento. Le sviluppava, del resto, anche “verso le quinte”, ma senza che riuscissimo a distinguere bene le parole: atteggiamento che lei definiva – supponendolo per noi motivo di disperazione, di «mortificazione», di «offesa» – dirci per tutto il santo giorno le «giaculatorie».
Compiuti gli ultimi riti, Françoise – che era ad un tempo, come nella chiesa primitiva, il celebrante e uno dei fedeli – si versava un ultimo bicchiere di vino, si slacciava dal collo il tovagliolo, lo piegava tergendosi dalle labbra una traccia d’acqua tinta e di caffè, l’infilava in un anello, ringraziava con sguardo dolente il “suo” giovane lacchè che per fare lo zelante le diceva: «Suvvia, signora, ancora un po’ d’uva; è schisita» e s’affrettava ad aprire la finestra col pretesto che “in quella miserabile cucina” faceva troppo caldo. Gettando con destrezza, mentre girava la maniglia della finestra per prendere una boccata d’aria, un colpo d’occhio disinteressato verso il fondo del cortile, ne coglieva la furtiva certezza che la duchessa non fosse ancora pronta, covava per un attimo, con occhiate sdegnose e appassionate, la carrozza con i cavalli già attaccati e, concessa ai propri occhi questa istantanea attenzione per le cose terrene, subito li alzava al cielo, che aveva già indovinato terso dalla dolcezza dell’aria e dal tepore del sole; e fissava, all’angolo del tetto, il punto dove, ogni primavera, venivano a fare il loro nido, proprio sopra il camino della mia stanza, dei colombi simil...