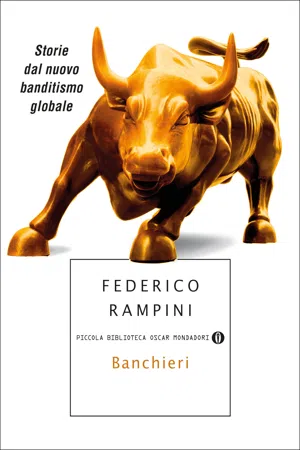Nelle antiche fiabe cinesi, proprio come nelle Mille e una notte, ogni tanto l’imperatore viene colto dal desiderio di conoscere il mondo esterno qual è davvero. Quindi gli viene in mente di calarsi nei panni di un suddito qualunque, per poter girare senza scorte e codazzi, magari anche orecchiare ciò che il popolo pensa e dice di lui. L’imperatore allora si traveste da poveraccio, inganna la sorveglianza dei suoi cortigiani e dei suoi soldati, esce dal palazzo e s’immerge nella folla senza essere riconosciuto. Naturalmente, i lettori di quelle favole non sarebbero mai stati sfiorati dall’idea che quello fosse un comportamento «democratico». L’imperatore non si sognava di cancellare la distanza tra lui e la plebe. Il sotterfugio era momentaneo, un trucco per calarsi «al di là dello specchio», magari con l’intenzione di ricavarne saggezza, ma tornando poi a comandare dal trono imperiale.
È così che si sarebbe dovuto interpretare «lo strano caso di Xi Jinping sul taxi di Pechino». Una storia che è parsa verosimile, ma solo per poche ore, nella Cina di oggi. Capital-comunista, globalizzata, ipermoderna, e tuttavia in qualche modo sempre imperiale. Dunque, l’antefatto è questo: all’inizio del mese di aprile 2013 è uscita la notizia che il nuovo numero uno della Repubblica popolare, Xi Jinping, era stato visto per le vie della capitale mentre saliva su un taxi, come un cittadino qualsiasi. Senza scorta, senza auto blu, senza corteo al seguito, senza paralizzare il traffico. Il primo a riportare quella notizia fu un giornale di Hong Kong, molto vicino al Partito comunista. Vista l’attendibilità della fonte, il resoconto fu ripreso da organi d’informazione ufficiali al 100 per cento, compresa l’agenzia di stampa Xinhua (Nuova Cina), che è direttamente controllata dal governo. Con tanto di dettagli sull’amabile conversazione tra il segretario generale del Partito comunista e il tassista di Pechino: una chiacchierata molto terra terra, su problemi concreti, come il traffico, l’inquinamento, il costo della vita. La bella favola sull’imperatore travestito da popolano è durata poche ore. Era tutto falso. L’agenzia Xinhua ha dovuto fare una retromarcia clamorosa, smentendo la notizia. Pura leggenda metropolitana. Nel frattempo, però, il falso Xi Jinping a spasso per la capitale su un taxi aveva scatenato una gran quantità di commenti, sui siti e sui blog. La censura di Stato ha faticato parecchio, ex post, per cancellare tutto quel brusio imbarazzante generato da una bufala.
Per chi come me ha vissuto a lungo in Cina, quella non notizia è quasi più eccitante che se fosse vera. Casa mia, a Pechino, era sul laghetto Houhai, a pochi isolati di distanza da Zhongnanhai, che significa «laghi centrale e meridionale». Si tratta degli specchi d’acqua che si trovano subito a nord della Città proibita, in quella che in epoca medievale fu l’area abitata dalla nobiltà, dai cortigiani, dai servitori della Corte. Zhongnanhai è diventato, già ai tempi di Mao Zedong, il quartier generale della nomenclatura. Lì dentro alloggiano i massimi leader cinesi con le loro famiglie. Io abitavo a poche centinaia di metri, e tuttavia avrei potuto essere a mille miglia: tra noi comuni abitanti di Pechino e i residenti di Zhongnanhai le differenze erano (sono) abissali. In termini di ricchezza, segretezza, e isolamento, la «casta» cinese – per usare un termine che gli italiani hanno preso dall’India – è una delle più privilegiate del mondo. Non solo la cinta di mura che circonda Zhongnanhai è impenetrabile, ma perfino dal cielo è impossibile spiare ciò che accade là dentro. Provate a usare Google Maps e scoprirete che in coincidenza con quell’area (vista dall’alto, cioè dal satellite, sta subito a destra della Città proibita quindi a nordest di piazza Tienanmen) c’è una zona oscurata.
Li chiamano «i principini», e non a caso, certi dirigenti cinesi. L’espressione «principini» viene usata in modo particolare per Xi Jinping e altri come lui, che discendono dai padri fondatori della Repubblica popolare, la prima generazione di dirigenti comunisti, i compagni di rivoluzione di Mao. Ma se i padri vissero un’epoca spartana, eroica e crudele, i figli governano in un contesto molto diverso. La Cina di Xi è stata capace di innalzare il tenore di vita di centinaia di milioni di suoi cittadini. Nel farlo, però, la nomenclatura si è appropriata di una fetta sproporzionata di ricchezze collettive.
Il caso di «Xi e il tassista» si colloca in un clima particolare. Da quando il nuovo leader ha preso il posto del suo predecessore Hu Jintao, nel dicembre 2012, uno dei suoi cavalli di battaglia è stata la lotta alla corruzione. Il 2012 fu l’anno dei grandi scandali. Il più grave portò alla caduta di Bo Xilai, (ex) potentissimo gerarca comunista a Chongqing, accusato di aver costruito un apparato mafioso in senso letterale: si arricchiva con le tangenti e perfino dirigendo un sistema di sequestri di persona a scopo di estorsione (sua moglie ha fatto di peggio, è stata condannata per omicidio). Per dare un segnale di cambiamento, Xi Jinping ha varato una sua forma di austerity, o, per meglio dire, un suo codice etico sui «costi della politica». Basta coi banchetti sontuosi per i funzionari di partito, stop ai regali di lusso come borse Vuitton e liquori di marca, addio ai voli in prima classe. Tutto questo è stato ampiamente pubblicizzato. E a sentire il ministero del Commercio, gli effetti si notano perfino a livello macroeconomico. Crollano i consumi di pinne di squalo (una prelibatezza, ricercatissima dai gourmet per le minestre), rendendo felici gli animalisti. Si svuotano le cabine di prima classe sui voli di Air China. Intere catene di ristoranti che facevano affari grazie ai banchetti ufficiali devono ridurre i prezzi e licenziare personale. Gli hotel a cinque stelle vedono arrivare delegazioni di alti ufficiali dell’esercito che chiedono di poter condividere le stanze per risparmiare sul conto.
Tutto questo, va da sé, è molto difficile da verificare. I dati che vengono forniti dal governo potrebbero essere manipolati. I membri della nomenclatura potrebbero aver trovato altri sistemi per elargirsi lussi e prebende, pur rispettando in apparenza le nuove consegne di austerity. Infine, tutta questa operazione lanciata da Xi non va alla sostanza del problema: che è il monopolio del potere da parte del Partito comunista. È grazie a quel monopolio che il clan di Xi (così come quello dell’ex premier Wen Jiabao) oggi controlla patrimoni dell’ordine di alcuni miliardi di euro. Ragnatele di società finanziarie intestate a mogli, figli, parenti vicini e lontani. Uno squarcio di luce su questi sistemi fu gettato da una celebre inchiesta del «New York Times» e dell’agenzia di stampa Bloomberg, prontamente ripagati con censure e blackout dei loro siti in Cina.
Dunque, quando la storia di «Xi a spasso in taxi» è stata lanciata ai lettori cinesi, la sua presunta credibilità derivava dal contesto. Si è potuto pensare – ci sono cascati perfino gli zelanti giornalisti governativi dell’agenzia Xinhua – che in uno slancio di populismo «occidentale» Xi volesse davvero mescolarsi alla folla, far finta di essere un cittadino come gli altri. Come un premier danese o un monarca svedese, insomma, di quelli che puoi incontrare a spasso in bicicletta o nel metrò. Niente di tutto questo. Semmai, la storia di Xi e il tassista andava collegata con le antiche favole sugli imperatori «travestiti per un giorno», ché di quello si sarebbe trattato.
«Scuotere la montagna per spaventare la tigre.» Così viene descritto a Pechino il terremoto giudiziario, una sorta di Mani pulite in stile cinese, che sta scuotendo la «montagna» dell’oligarchia comunista. Ma qual è la tigre che si vuole spaventare, esattamente? Le maxindagini, i processi spettacolari, sono una vera svolta nella storia della Repubblica popolare e possono estirpare la malapianta della corruzione? Oppure siamo di fronte a una vicenda più classica e tradizionale, un regolamento tra fazioni avverse in seno al partito, con l’obiettivo di consolidare l’uomo forte al vertice? Di certo quel che sta accadendo dall’arrivo di Xi è eccezionale. Inchieste e processi per corruzione in Cina ce ne sono sempre stati, ma per ritrovare «indagati eccellenti» di questo livello bisogna risalire addirittura al processo contro la Banda dei Quattro, quello che segnò la fine ufficiale della Rivoluzione culturale e del maoismo (tra i quattro c’era la vedova di Mao Zedong, il fondatore della Repubblica popolare). Correva l’anno 1981. Ne sono passati dunque trentadue, senza che finissero sul banco degli imputati personaggi di altissimo livello della nomenclatura. Le condanne per corruzione, spesso esemplari (inclusa la pena di morte), solitamente colpivano «pesci piccoli» o medio-piccoli, servivano a placare le masse dando un’impressione di severità contro i profittatori del regime. Ma nelle alte sfere vigeva un’immunità di fatto. Ora è proprio questa regola non scritta che viene calpestata clamorosamente.
A pochi giorni dalla condanna all’ergastolo inflitta a Bo Xilai, nel settembre 2013, una nuova maxindagine ha lambito un personaggio ancora più potente. Si tratta nientemeno che dell’ex capo supremo di tutte le forze di sicurezza (polizia, servizi segreti, magistratura), Zhou Yongkang. A 70 anni, Zhou adesso è un pensionato, ma fino al 2012 è stato il capo del potentissimo Comitato affari legali e politici del partito, un organo politico che ha la supervisione sugli apparati di sicurezza. Come tale, Zhou era non soltanto un membro del Politburo, ma anche del suo comitato esecutivo, la cupola suprema del potere politico a Pechino. Personaggi di quel livello non erano mai stati coinvolti in indagini per corruzione. E invece un’indagine scottante si avvicina proprio a Zhou. Riguarda «violazioni disciplinari» – eufemismo che nel codice della nomenclatura indica la corruzione di alti dirigenti – commesse da quattro top manager del colosso petrolifero China National Petroleum Corporation, detto anche PetroChina. Il più importante, Jiang Jiemin, che fu presidente di PetroChina, è stato formalmente incriminato. Ma sia Jiang sia gli altri top manager finiti nella rete degli inquirenti sono tutti cresciuti all’ombra di Zhou. Prima di diventare capo della sicurezza nel 2007, la carriera di Zhou si era svolta in gran parte al vertice del colosso petrolifero. Per gli insider cinesi non c’è alcun dubbio: il vero bersaglio di quest’inchiesta aperta in agosto è lui. Che si arrivi a trascinarlo in tribunale oppure no, la sua figura uscirà a pezzi, via via che il processo si organizza. E tutti guardano al presidente Xi come al vero mandante di questa operazione. In Cina non esiste neppure la parvenza di una magistratura indipendente. Tanto più quando sotto inchiesta ci sono personaggi eccellenti di questa stazza, non si muove foglia senza che ne sia informato il numero uno del partito, che è anche il presidente della Repubblica. Xi, del resto, ha promesso una lotta senza quartiere contro la corruzione. A tutti i livelli. Anzi, «contro le mosche e contro le tigri», per usare un’altra immagine colorita con cui si descrive un’offensiva che non guarda in faccia a nessuno e vuole colpire sia i piccoli corrotti sia i veri potenti.
Per quanto riguarda l’impatto sulla popolazione, comunque, l’evento più sconvolgente rimane per ora il processo a Bo Xilai. Anche lui è un «principino», cioè un discendente diretto dei padri fondatori della Repubblica popolare. L’attuale presidente Xi e Bo avevano in comune le storie dei loro padri, tutti e due combattenti al fianco di Mao. E il collegamento storico con l’epopea maoista ha avuto un peso nel costruire l’immagine di Bo. Dopo la sua ascesa ai vertici nazionali del partito, e occupando una posizione chiave come capo comunista nella città più popolosa della Cina (Chongqing, ex capitale provvisoria durante l’occupazione giapponese, oggi è una megalopoli da 30 milioni di abitanti), Bo si era distinto come il fautore di una sorta di revival maoista. Aveva promosso campagne per riscoprire e rivalutare il pensiero comunista. In questo modo si era conquistato simpatie fra quella parte della popolazione che si sente emarginata dal boom economico, penalizzata dalle diseguaglianze crescenti.
Quanto il «maoismo» di Bo fosse sincero, è discutibile. Ma la sua popolarità era salita alle stelle. In un certo senso, pur usando argomenti veterocomunisti, Bo era stato il protagonista di un’operazione di marketing politico molto moderna. E pericolosa per il regime. Anziché promuovere se stesso dentro i meandri della nomenclatura, Bo aveva puntato sulla propria immagine esterna, sulla propria popolarità a livello nazionale. Una sfida alle regole del sistema, visto che i leader vengono cooptati dai loro simili, non eletti dal basso. Perciò il processo a Bo ha avuto una spettacolarità senza precedenti. Evidentemente voluta dai suoi compagni e nemici al vertice del paese, Xi per primo. Almeno all’inizio, l’ampia pubblicità data a quel processo doveva servire a smontare l’immagine pubblica di Bo. Sono usciti dettagli sulla sua vita lussuosa, da magnate occidentale. La moglie di Bo, Gu Kailai, si è potuta regalare più di dieci anni fa una villa da 3 milioni di dollari (con le tangenti di un amico affarista). Il figlio Bo Guaga, che attualmente studia alla Columbia University di New York, nel 2011 fece una vacanza in Africa da 131.000 dollari, con tanto di jet privato per volare da Dubai al monte Kilimangiaro.
Lussi sfrenati, che Bo poteva permettersi grazie alla fitta rete di relazioni con imprenditori che gli versavano tangenti. Corruzione, ricchezza, decadenza e vizi privati (incluse le relazioni extraconiugali della signora Gu), tutto ciò è stato dato in pasto ai cinesi con la pubblicizzazione del processo, per demolire la facciata «maoista» ed egualitaria di Bo. Tuttavia, l’operazione è riuscita solo a metà. La popolarità di Bo resta elevata. E a un certo punto i giudici hanno optato per la segretezza, dal processo non sono più emersi dettagli piccanti, fino alla sentenza finale dell’ergastolo.
Gli ottimisti sperano che questi castighi eccellenti segnino l’inizio di una vera guerra contro la corruzione. Ma insieme con le maxindagini, il presidente Xi ha lanciato una campagna di segno ben diverso. Il Documento n. 9, così si chiama il nuovo Verbo ideologico che tutto il partito è tenuto a studiare. In quel testo si denunciano i «sette pericoli» che vengono dall’Occidente. Tra questi: la democrazia costituzionale, i valori universali dei diritti umani, lo Stato di diritto. A giudicare da quel documento, Xi non è affatto intenzionato a promuovere la trasparenza, l’informazione dei cittadini, tantomeno l’indipendenza della magistratura.
C’è un filo invisibile che collega queste vicende della Cina imperial-comunista e le banche di Wall Street. Ve lo immaginate un luogo dove assumere i figli dei potenti è reato? Questo luogo esiste, è l’America. La più grande banca di New York, la JPMorgan Chase, è finita sotto inchiesta proprio per questo. È una storia che ha dell’incredibile, se vista con occhi cinesi… o italiani. Vale la pena di raccontarla nel dettaglio perché aiuta a capire tante cose: il valore della meritocrazia, le cause profonde della fuga dei cervelli dal resto del mondo verso gli Stati Uniti, la differenza di costume tra classi dirigenti. L’inchiesta sulla JPMorgan parte dall’America, il presunto reato, invece, sarebbe avvenuto in Cina. Corruzione, nientemeno. Di che tipo di corruzione si tratta? La Securities and Exchange Commission (Sec), l’authority che vigila sulle società quotate in Borsa, indaga sul fatto che JPMorgan Chase avrebbe assunto diversi figli di gerarchi della nomenclatura cinese, per ottenere in cambio lucrosi contratti con aziende di Stato nella Repubblica popolare. Un simile comportamento è normale in altre latitudini, economicamente ha una sua logica. Se assumendo il figlio di un leader straniero io mi garantisco ricchi affari per il futuro, non sto forse facendo il bene della mia azienda? Tuttavia, la legge americana sulla corruzione all’estero è tra le più severe al mondo, e l’assunzione di «rampolli» dei Vip stranieri può ricadere dentro la definizione di questo reato. Corruzione, per l’appunto. L’inchiesta della Sec verte su due casi in particolare. Il primo riguarda l’assunzione di Tang Xiaoning, figlio di Tang Shuangning. Quest’ultimo è presidente del conglomerato pubblico China Everbright. In seguito all’assunzione di suo figlio, la JPMorgan Chase ottenne diversi contratti importanti da China Everbright.
Il secondo episodio è l’assunzione di Zhang Xixi, figlia di un dirigente delle ferrovie dello Stato cinesi. L’assunzione avvenne nel 2007, e nello stesso periodo JPMorgan Chase fu ingaggiata per il collocamento in Borsa di China Railway Group, azienda che costruisce linee ferroviarie per lo Stato. Le authority Usa applicano alla lettera il Foreign Corrupt Practices Act, la legge del 1977 che stabilì regole severe contro il pagamento di tangenti all’estero. Fra l’altro, quella legge proibisce alle società americane di offrire «qualsiasi cosa che abbia un valore» a un funzionario straniero «al fine di ricavarne vantaggi impropri negli affari». L’assunzione di un figlio di potenti personalità straniere non può costituire reato in sé. Ma il sospetto di violazione della legge può scattare se si dimostra che il figlio in questione «non ha le competenze necessarie». Oppure, la presunzione di reato può nascere se l’azienda americana improvvisamente comincia a ottenere contratti o altri benefici da un partner straniero con il quale prima non riusciva a fare affari.
Il sistema di regole che vige in America è del tutto incomprensibile in Cina, dove i rampolli dei gerarchi hanno la certezza di poter scalare i vertici delle aziende di Stato, banche o grandi industrie. Può sembrare surreale anche se tradotto in Italia. Ve l’immaginate mettere sotto inchiesta i vertici di una grandissima azienda italiana perché hanno assunto un giovane incompetente, figlio di genitori importanti? Non che qui negli Stati Uniti la meritocrazia prevalga sempre e ovunque. Ci sono eccezioni, viene in mente per esempio l’ammissione di George W. Bush, mediocre studente, alla grande università dove aveva studiato anche suo padre, allora presidente degli Stati Uniti. Ma restano delle eccezioni. Come dimostra il caso della JPMorgan, l’America ha imparato da tempo una cosa importante: che la selezione dei migliori è nel suo interesse, le dà una marcia in più rispetto a paesi dove prevalgono logiche di clan.
È anche su queste cose che si costruisce un’egemonia culturale, un modello esportabile di valori, una leadership globale. È per questo che l’America resta un polo mondiale di attrazione dei cervelli, mentre la Cina no. Nel momento più buio della crisi occidentale, nel triennio 2008-2010, ci si è potuti interrogare sull’emergere di un contromodello di capitalismo alla cinese. La Repubblica popolare riuscì effettivamente a evitare quella recessione, manovrando le potenti leve del suo capitalismo di Stato. Fece come Obama e più di Obama una maximanovra di investimenti pubblici, in un sistema dove lo Stato può agire in modo determinato e senza vincoli (soprattutto, senza l’opposizione della destra repubblicana, che ha fatto di tutto per impedire le politiche keynesiane di Obama). La tenuta della Cina nella Grande Contrazione è stata un elemento importante per attutire l’impatto globale di quella crisi. Ma un modello cinese non è esportabile nei paesi più avanzati dell’Occidente. E anche quando siamo indignati dai nostri banchieri-banditi, sappiamo che a Pechino e Shanghai si praticano gli stessi vizi, senza neppure la trasparenza per denunciarli né i contropoteri con cui combatterli.
Il 28 novembre 2011 ero in trasferta da New York a Washington per seguire un vertice Usa-Ue, l’incontro tra Barack Obama e la troika europea di Herman Van Rompuy, José Barroso e Lady Catherine Ashton. Appena arrivato nel mio albergo, il JW Marriott all’angolo della Quattordicesima Strada, ho notato un cambiamento nel panorama rispetto alla veduta che mi è familiare. Oltre alla Pennsylvania Avenue e al celebre obelisco, dalle finestre dell’albergo si vedeva anche l’accampamento di Occupy DC (abbreviazione per District of Columbia, dove si trova la capitale federale). Nei giorni del vertice ha piovuto, poi si è alzato un vento gelido, ma quei ragazzi hanno resistito intrepidi nelle loro tende, dormendo nei sacchi a pelo, a pochi isolati dalla Casa Bianca. Noi newyorchesi tendiamo a credere che Manhattan sia il centro del mondo, e perciò Occupy Wall Street ci sembra il fenomeno più importante di questa stagione di proteste. In realtà, il movimento degli indignati americani ha molte facce e molte sedi. Diversamente dall’Europa, nessuna delle sue versioni si è lasciata contaminare dalla violenza. Scontri ci sono stati soprattutto a Oakland, in California, sgomberi brutali sono avvenuti a Los Angeles, Chicago, Filadelfia, qualche episodio di tensione e qualche dozzina di arresti (brevi) anche a Manhattan.
Mentre scrivo, sul finire del 2013, di Occupy non resta quasi nulla, almeno in apparenza. Zuccotti Park, il suo epicentro a Wall Street dove nacque il 17 settembre 2011, due anni dopo è tornato a essere un anonimo giardinetto nel cuore del quartiere finanziario, a Downtown Manhattan.
La tentazione è di liquidare Occupy come un fenomeno effimero, che non lascia traccia di sé. Svanito. Se i suoi nemici erano i banchieri-banditi, l’oligarchia dell’1 per cento, i privilegiati dell’alta finanza, il verdetto sembra chiaro: hanno stravi...