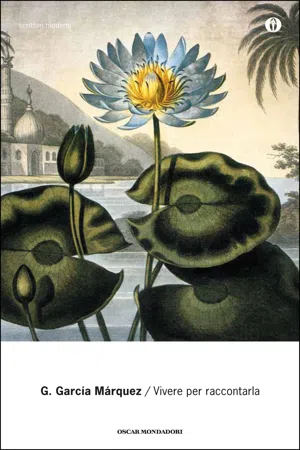
- 434 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Vivere per raccontarla
Informazioni su questo libro
In Vivere per raccontarla Gabo ricrea e racconta gli anni dell'infanzia e della giovinezza: dalla nonna che lo incantava con le sue storie, alla vita da bohèmien nei quartieri malfamati di Bogotá, mentre si formava quell'immaginario fantastico che ha dato vita a Cent'anni di solitudine e agli altri capolavori. Un libro in cui vita e opera, realtà e romanzo, si fondono, illuminandosi a vicenda sotto il segno dell'inarrivabile capacità di raccontare di un grande maestro della letteratura del Ventesimo secolo.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
1
Mia madre mi chiese di accompagnarla a vendere la casa. Era arrivata quel mattino a Barranquilla dal paese lontano dove viveva la famiglia e non aveva la minima idea su come trovarmi. Domandando qui e là fra i conoscenti, le indicarono di cercarmi nella libreria Mondo o nei caffè lì accanto, dove mi recavo due volte al giorno a chiacchierare con i miei amici scrittori. Chi glielo disse l’avvertì: «Ci stia attenta perché sono dei pazzi scatenati». Arrivò a mezzogiorno in punto. Si fece strada con il suo andare lieve fra i tavoli carichi di libri in mostra, mi si piantò davanti, guardandomi negli occhi con il sorriso malizioso dei suoi giorni migliori, e prima che io potessi reagire, mi disse:
«Sono tua madre.»
Qualcosa in lei era cambiato e mi impedì di riconoscerla a prima vista. Aveva quarantacinque anni. Sommando i suoi undici parti, aveva passato quasi dieci anni incinta e almeno altrettanti allattando i suoi figli. I capelli le erano incanutiti prima del tempo, gli occhi sembravano più grandi e attoniti dietro le sue prime lenti bifocali, e osservava un lutto stretto e severo per la morte di sua madre, ma conservava la bellezza romana del suo ritratto di nozze, adesso nobilitata da un’aura autunnale. Innanzitutto, ancora prima di abbracciarmi, mi disse con il solito stile cerimoniale:
«Vengo a chiederti il favore che mi accompagni a vendere la casa.»
Non dovette dirmi quale, né dove, dal momento che per noi ne esisteva una sola al mondo: la vecchia casa dei nonni ad Aracataca, dove avevo avuto la buona sorte di nascere e dove non avevo più abitato dopo gli otto anni. Avevo appena abbandonato la Facoltà di Legge dopo sei semestri, dedicati più che altro a leggere quanto mi finiva tra le mani e a recitare a memoria le poesie irripetibili del Secolo d’Oro spagnolo. Avevo già letto, tradotti e in edizioni imprestate, tutti i libri che mi sarebbero bastati per imparare la tecnica di scrivere romanzi, e avevo pubblicato sei racconti in supplementi di giornali, che avevano riscosso l’entusiasmo dei miei amici e l’attenzione di alcuni critici. Il mese successivo avrei compiuto ventitré anni, ero ormai inadempiente rispetto al servizio militare e veterano di due blenorragie, e ogni giorno fumavo, senza premonizioni, sessanta sigarette di tabacco atroce. Alternavo i miei ozi fra Barranquilla e Cartagena de Indias, sulla costa caraibica della Colombia, sopravvivendo come un pezzente grazie a quello che mi pagavano per i miei articoli quotidiani su «El Heraldo», che era meno di niente, e dormivo nella miglior compagnia possibile dove mi sorprendeva la notte. Come se l’incertezza delle mie aspirazioni e il caos della mia vita non bastassero, insieme a un gruppo di amici inseparabili mi accingevo a pubblicare una rivista temeraria e senza mezzi che Alfonso Fuenmayor progettava da tre anni. Cos’altro potevo desiderare?
Più per penuria che per gusto personale anticipavo la moda che si sarebbe diffusa di lì a vent’anni: baffi silvestri, capelli scarruffati, pantaloni di tela jeans, camicie a fiori equivoci e sandali da pellegrino. Nel buio di un cinema, e senza sapere che io ero lì vicino, un’amica di allora disse a qualcuno: «Il povero Gabito è un caso disperato». Sicché quando mia madre mi chiese di andare con lei a vendere la casa non ebbi problemi a dirle di sì. Lei mise in chiaro che non aveva abbastanza denaro e per orgoglio le dissi che mi sarei pagato le mie spese.
Al giornale dove lavoravo non avrei potuto risolvere la situazione. Mi pagavano tre pesos per ogni pezzo e quattro per un editoriale quando mancava qualcuno degli editorialisti fissi, ma mi bastavano appena. Cercai invano di chiedere un prestito, perché il direttore mi ricordò che il mio debito originale ammontava a oltre cinquanta pesos. Quel pomeriggio commisi un abuso di cui nessuno dei miei amici sarebbe stato capace. All’uscita dal caffè Colombia, vicino alla libreria, mi incamminai con don Ramón Vinyes, il vecchio maestro e libraio catalano, e gli chiesi in prestito dieci pesos. Ne aveva solo sei.
Né mia madre né io avremmo neppure potuto immaginare che quell’innocente passeggiata di soli due giorni sarebbe stata così determinante per me, che la più lunga e diligente delle vite non mi basterebbe per finire di raccontarla. Adesso, con oltre settantacinque anni alle mie spalle, so che fu la decisione più importante fra quante dovetti prendere nella mia carriera di scrittore. Ossia, in tutta la mia vita.
Fino all’adolescenza, la memoria ha più interesse per il futuro che per il passato, sicché i miei ricordi del paese non erano ancora stati idealizzati dalla nostalgia. Lo ricordavo così com’era: un buon posto per viverci, dove tutti si conoscevano, in riva a un fiume dalle acque diafane che si precipitavano lungo un letto di pietre polite, bianche ed enormi come uova preistoriche. All’imbrunire, soprattutto in dicembre, quando passavano le piogge e l’aria diventava di diamante, la Sierra Nevada di Santa Marta sembrava avvicinarsi con i suoi picchi bianchi fino alle piantagioni di banani della riva opposta. Da lì si vedevano gli indios arhuacos che correvano in file da formiche sui cornicioni della sierra, con i loro sacchi di zenzero sulla schiena e masticando palle di coca per distrarsi la vita. Noi bambini nutrivamo allora l’illusione di organizzare battaglie con le nevi perpetue e giocare alla guerra nelle strade divampanti. Il caldo era così inverosimile, soprattutto durante la siesta, che gli adulti se ne lamentavano come se ogni giorno fosse stato una sorpresa. Fin dalla mia nascita avevo sentito ripetere senza tregua che i binari della ferrovia e gli edifici della United Fruit Company erano stati installati di notte, perché di giorno era impossibile afferrare i pezzi di ferro riscaldati dal sole.
L’unico modo per arrivare ad Aracataca da Barranquilla era una sgangherata lancia a motore lungo un canale scavato a braccia di schiavi durante la Colonia, e poi attraverso una vasta palude dalle acque torbide e desolate, fino al misterioso villaggio di Ciénaga. Lì si prendeva il treno normale che alle sue origini era stato il migliore del paese, e con cui si faceva il tragitto conclusivo attraverso le immense piantagioni di banani, con molte fermate oziose in abitati polverosi e ardenti, e stazioni solitarie. Questo fu il percorso che mia madre e io intraprendemmo alle sette di sera di sabato 18 febbraio 1950 – vigilia di carnevale – sotto un acquazzone diluviale fuori stagione e con trentadue pesos complessivi che ci sarebbero bastati appena per tornare se la casa non fosse stata venduta alle condizioni previste.
I venti alisei erano così selvaggi quella sera, che al porto fluviale feci fatica a convincere mia madre a imbarcarsi. Non gliene mancava motivo. Le lance erano imitazioni ridotte dei battelli a vapore di New Orleans, ma con motori a benzina che comunicavano un tremito da brutta febbre a tutto quanto si trovava a bordo. C’era una sala con ganci per attaccare le amache a diversi livelli, e scanni di legno su cui ognuno si sistemava a gomitate come gli riusciva con i suoi bagagli eccessivi, fagotti di merci, gabbie di galline e persino maiali vivi. Le cabine erano poche e soffocanti, con due brande da campo, quasi sempre occupate da bagasce della mala morte che prestavano servizi di emergenza durante il viaggio. Poiché all’ultimo momento non ne trovammo una libera, né avevamo con noi le amache, mia madre e io occupammo d’assalto due seggiole di ferro del corridoio centrale e lì ci preparammo a passare la notte.
Proprio come lei temeva, la tempesta flagellò l’impavida imbarcazione mentre percorrevamo il fiume Magdalena, che a così breve distanza dal suo estuario ha un’indole oceanica. Al porto io avevo comprato una buona provvista di sigarette fra le più economiche, di tabacco nero e con una carta che le mancava poco per essere straccia, e cominciai a fumare alla mia maniera di allora, accendendo l’una con il mozzicone dell’altra, mentre rileggevo Luce d’agosto, di William Faulkner, che in quel periodo era il più fedele dei miei demoni tutelari. Mia madre si aggrappò al suo rosario come a un argano capace di disincagliare un trattore o di reggere un aereo nell’aria, e secondo la sua consuetudine non chiese nulla per sé, ma solo prosperità e lunga vita per i suoi undici orfani. Le sue preghiere dovettero arrivare dov’era il caso, perché la pioggia si fece docile quando entrammo nel canale e la brezza spirò appena per allontanare le zanzare. Mia madre ripose allora il rosario e per un bel pezzo osservò in silenzio il fragore della vita che trascorreva intorno a noi.
Era nata in una casa modesta, ma crebbe nello splendore effimero della compagnia bananiera, di cui le rimase almeno una buona educazione da bambina ricca al Collegio della Presentazione della Santissima Vergine, a Santa Marta. Durante le vacanze di Natale ricamava sul tombolo con le sue amiche, suonava il clavicordio alle feste di beneficenza e partecipava con una zia guardiana ai balli più depurati della timorata aristocrazia locale, ma nessuno aveva mai saputo che avesse un fidanzato quando si sposò contro la volontà dei genitori con il telegrafista del paese. Le sue virtù più note fin d’allora erano il senso dell’umorismo e la salute di ferro che le insidie dell’avversità non sarebbero riuscite a vincere nella sua lunga vita. Ma quella più sorprendente, e già allora la meno sospettabile, era il talento squisito con cui riusciva a nascondere la tremenda forza del suo carattere: un Leone perfetto. Le era stato così possibile instaurare un potere matriarcale il cui dominio si estendeva fino ai parenti più remoti nei luoghi meno immaginabili, come un sistema planetario di cui lei disponeva dalla sua cucina, con voce tenue e senza quasi batter ciglio, mentre faceva bollire la marmitta dei fagioli.
Vedendola affrontare senza scomporsi quel viaggio brutale, io mi domandavo come avesse potuto subordinare così in fretta e con tanto dominio le ingiustizie della povertà. Niente come quella brutta notte per metterla alla prova. Le zanzare carnivore, il caldo denso e nauseabondo per via del fango dei canali che la lancia rimuoveva al suo passaggio, l’andirivieni dei passeggeri insonni che non trovavano requie nella loro pelle, tutto sembrava fatto di proposito per mettere in crisi il carattere più equilibrato. Mia madre sopportava il tutto immobile sulla sua seggiola, mentre le ragazze in affitto mietevano il raccolto del carnevale nelle cabine lì accanto, travestite da uomini o da bamboline. Una di loro era entrata e uscita dalla sua più volte, sempre con un cliente diverso, e proprio accanto al sedile di mia madre. Io pensavo che lei non l’avesse vista. Ma la quarta o quinta volta che entrò e uscì in meno di un’ora, la seguì con uno sguardo di compassione sino in fondo al corridoio.
«Povere ragazze» sospirò. «Quello che devono fare per vivere è peggio che lavorare.»
Rimase così fino a mezzanotte, quando mi stancai di leggere per via del tremore insopportabile e delle luci esigue del corridoio, e mi sedetti a fumare al suo fianco, cercando di salire a galla dalle sabbie mobili della contea di Yoknapatawpha. Avevo abbandonato l’università l’anno prima, con l’illusione temeraria di vivere di giornalismo e letteratura senza bisogno di impararli, incoraggiato da una frase che credo avessi letto in Bernard Shaw: “Fin da piccolo dovetti interrompere la mia educazione per andare a scuola”. Non mi ero sentito di discuterne con nessuno, perché capivo, senza poterlo spiegare, che le mie ragioni potevano essere valide solo per me stesso.
Cercar di convincere i miei genitori di una simile follia quando avevano riposto in me tante speranze e avevano speso tanto denaro che non avevano, era tempo sprecato. Soprattutto mio padre, che mi avrebbe perdonato qualsiasi cosa, meno che non appendessi alla parete un titolo accademico che lui non era riuscito ad avere. I rapporti si erano interrotti. Quasi un anno dopo progettavo sempre di andarlo a trovare per spiegargli le mie ragioni, quando arrivò mia madre a chiedermi di accompagnarla a vendere la casa. Tuttavia, lei non accennò al problema fin dopo la mezzanotte, sulla lancia, quando sentì come una rivelazione sovrannaturale che aveva infine trovato il momento propizio per dirmi quello che di certo era il motivo reale del suo viaggio, e cominciò con il modo e con il tono e con le parole millimetriche che dovevano essere maturate nella solitudine delle sue insonnie assai prima che le pronunciasse.
«Tuo papà è molto triste» disse.
Eccolo, infine, l’inferno tanto temuto. Iniziava come sempre, quando uno meno se l’aspettava, e con una voce rasserenante che non si sarebbe alterata dinanzi a nulla. Solo in osservanza del rituale, dal momento che conoscevo benissimo la risposta, le domandai:
«E come mai?»
«Perché hai interrotto gli studi.»
«Non li ho interrotti» le dissi. «Ho solo cambiato carriera.»
L’idea di una discussione a fondo le sollevò l’animo.
«Tuo papà dice che è la stessa cosa» disse.
Sapendo che era falso, le dissi:
«Anche lui ha smesso di studiare per suonare il violino.»
«Non era lo stesso» replicò lei con una grande vivacità. «Il violino lo suonava solo alle feste e alle serenate. Se ha interrotto gli studi è stato perché non aveva neppure di che mangiare. Ma in meno di un mese ha imparato a fare il telegrafista, che allora era un’ottima professione, soprattutto a Aracataca.»
«Io vivo scrivendo sui giornali» le dissi.
«Questo lo dici per non rattristarmi» disse lei. «Ma lo si nota da lontano che sei in una brutta situazione. Come mai, quando ti ho visto nella libreria non ti ho riconosciuto?»
«Neppure io ho riconosciuto lei» le dissi.
«Ma non per lo stesso motivo» disse. «Io ho pensato che eri un accattone». Mi guardò i sandali logori, e aggiunse: «E senza calze».
«È più comodo» le dissi. «Due camicie e due paia di mutande: uno addosso e l’altro che si asciuga. Di cos’altro c’è bisogno?»
«Di un po’ di dignità» disse lei. Ma subito dopo raddolcì il tono: «Te lo dico per tutto il bene che ti vogliamo».
«Lo so» le dissi. «Ma mi dica una cosa: al mio posto lei non farebbe la stessa cosa?»
«Non la farei» disse «se così contrariassi i miei genitori.»
Ricordando la tenacia con cui era riuscita a vincere l’opposizione della sua famiglia per sposarsi, le dissi ridendo:
«Coraggio, mi guardi.»
Ma lei mi schivò con serietà, perché sapeva troppo bene cosa stavo pensando.
«Non mi sono sposata finché non ho avuto la benedizione dei miei genitori» disse. «Per forza, sia pure, ma l’ho avuta.»
Interruppe la discussione, non perché i miei argomenti l’avessero sconfitta, ma perché voleva andare in bagno e diffidava delle sue condizioni igieniche. Domandai al nostromo se c’era un posto più salubre, ma lui stesso mi spiegò che usava il bagno comune. E concluse, come se avesse appena finito di leggere Conrad: «Sul mare siamo tutti uguali». Sicché mia madre si sottomise alla legge di tutti. Quando uscì, al contrario di quanto io temevo, a stento riusciva a dominare le risate:
«Figurati» mi disse «cosa penserà mai tuo papà se torno con una malattia da mala vita?»
Dopo la mezzanotte subimmo un ritardo di tre ore, perché i grovigli di anemoni del canale immobilizzarono le eliche, la lancia si incagliò in un gruppo di mangrovie e molti passeggeri dovettero tirarla dalle rive con le funi delle amache. Il caldo e le zanzare divennero insopportabili, ma mia madre se ne liberò con una raffica di sonni istantanei e intermittenti, ormai celebri in famiglia, che le permettevano di riposare senza perdere il filo della conversazione. Quando il viaggio riprese e sopraggiunse la brezza fresca, si svegliò del tutto.
«Comunque» sospirò «una risposta devo portarla a tuo papà.»
«Meglio se non si preoccupa» le dissi con la stessa innocenza. «In dicembre andrò a trovarlo, e allora gli spiegherò tutto.»
«Mancano dieci mesi» disse lei.
«In fin dei conti, quest’anno non si può combinare più niente all’università» le dissi.
«Prometti davvero che andrai a trovarlo?»
«Lo prometto» le dissi. E per la prima volta colsi una certa ansia nella sua voce:
«Posso dire a tuo papà che gli dirai di sì?»
«No» le replicai perentorio. «Questo no.»
Era evidente che cercava un’altra via di uscita. Ma non gliela concessi.
«Allora è meglio se gli dico la verità una volta per tutte» disse lei. «Così non sembrerà un inganno.»
«D’accordo» le dissi sollevato. «Gliela dica.»
Rimanemmo in questi termini, e chi non l’avesse conosciuta bene avrebbe pensato che lì fosse finito tutto, ma io sapevo che era una tregua per riprendere fiato. Poco dopo si addormentò profondamente. Una brezza tenue allontanò le zanzare e saturò l’aria nuova con un odore di fiori. La lancia acquistò allora la sveltezza di un veliero.
Eravamo nella Palude Grande, un altro dei miti della mia infanzia. Vi avevo navigato più volte, quando mio nonno il colonnello Nicolás Ricardo Márquez Mejía – che noi nipoti chiamavamo Papalelo – mi portava da Aracataca a Barranquilla a trovare i miei genitori. «Della palude non bisogna aver paura, bensì rispetto» mi aveva detto lui, parlando degli umori imprevedibili delle...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Vivere per raccontarla
- Capitolo 1
- Capitolo 2
- Capitolo 3
- Capitolo 4
- Capitolo 5
- Capitolo 6
- Capitolo 7
- Capitolo 8
- Copyright
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Vivere per raccontarla di Gabriel García Márquez, Angelo Morino in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Biografie in ambito letterario. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.