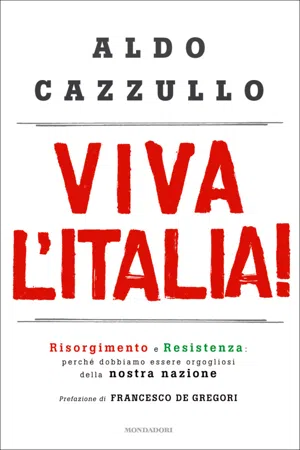![]()
«Io parto domattina per la campagna con l’Esercito. Procurerò di sbarrare la via di Torino, se non ci riesco e il nemico avanza, ponete al sicuro la mia famiglia e ascoltate bene questo. Vi sono al Museo delle armi quattro bandiere austriache prese dalle nostre truppe nella campagna del 1848 e là deposte da mio padre. Questi sono i trofei della sua gloria. Abbandonate tutto, al bisogno: valori, gioie, archivi, collezioni, tutto ciò che contiene questo palazzo, ma mettete in salvo quelle bandiere. Che io le ritrovi intatte e salve come i miei figli. Ecco tutto quello che vi chiedo; il resto non conta.»
Il re arci-italiano
Non era scontato ma neppure sorprendente che un arci-italiano come re Vittorio Emanuele scrivesse così a Costantino Nigra, alla vigilia della seconda guerra d’indipendenza. Come ogni autentico italiano, il re poteva essere simpaticamente cialtrone, ma nei momenti drammatici dava il meglio di sé. E quel momento era drammatico davvero: la vigilia del conflitto che avrebbe deciso la sorte del paese e della dinastia. «Tra un anno sarò re d’Italia o il signor Savoia» aveva confidato Vittorio Emanuele dopo il discorso alla Camera – «non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d’Italia si leva verso di noi» – con cui aveva aperto le ostilità con l’Austria, d’intesa con Napoleone III e con il proprio detestato primo ministro, Camillo Benso conte di Cavour, vero artefice dell’unificazione.
Non è facile però amare Cavour. Aristocratico, cosmopolita, uomo di confine, un po’ svizzero e un po’ parigino, trattato da pari a pari dall’imperatore dei francesi e dal premier britannico Palmerston, considerato nelle cancellerie europee come una delle intelligenze più vive del tempo; morto più povero di quando era entrato in politica, primo ministro senza stipendio e con un appartamento di rappresentanza che non usava, preferendo invitare gli ospiti per pranzo a proprie spese al Cambio: la sua figura è troppo complessa, paradossalmente troppo moderna per essere sentita vicina dall’Italia di oggi. Cavour non colpiva l’immaginazione popolare, non portava divise o abbigliamenti stravaganti alla Garibaldi, non era un monarca o un avventuriero ma un «avvocato»come lo chiamava con disprezzo Vittorio Emanuele: un borghese.
Il re, invece, è un personaggio italianissimo. Non a caso si trovava molto bene a Napoli, ricambiato. A Napoli pensò quando dovette portare la capitale lontano dalla sua Torino, per poi scegliere Firenze perché «tra qualche anno da Firenze si potrà venir via, mentre a Napoli ci si resta». Un re popolano: evitava le salse francesi servite ai pranzi di gala, era ghiotto di bagne caude, agnolotti, zuppe, pane intinto nel sugo della cacciagione, fontina, fonduta. Non amava le nobildonne e sintetizzava la sua idea del femminino scandalizzando il raffinato Massimo d’Azeglio: «A me mi piacciono le donne vere, che odorano di forte. La femmina profumata va bene alle feste da ballo, ma a letto si deve sentire la spuzzetta della cicalona». Non a caso fu d’Azeglio ad accreditare la diceria della sostituzione d’infante, secondo cui il re sarebbe stato appunto figlio di un macellaio fiorentino.
Certo Vittorio Emanuele non assomigliava a suo padre. Carlo Alberto era alto due metri, magrissimo, biondo, chiaro, elegante, colto, austero, tormentato sino a punirsi con il cilicio per una gioventù giacobina e libertina. Vittorio era basso, grassoccio, rozzo, simpatico, ignorante, alla mano, un po’ grottesco con i baffoni all’insù che divertirono la regina Vittoria, a cui sembrò più un guerriero medievale che un re costituzionale. Amava la caccia e la guerra, ai teatri preferiva i camerini delle attrici, si fermava a parlare con i sudditi, offriva sigari ai soldati, si appartava con le popolane nei fienili. Ebbe infatti figli – oltre che dalla moglie rampolla degli Asburgo – dall’attrice Laura Bon, da un’oscura maestra di Frabosa, e ovviamente dalla Bela Rosin, prosperosa e analfabeta, figlia di un tamburo maggiore dell’esercito. Amò pure la vedova di suo fratello, la moglie del suo caro amico Urbano Rattazzi e, durante la drammatica campagna del 1848, una contadina di Volta Mantovana: ferito durante un assalto, rifiutò di farsi medicare per mostrarsi sanguinante ai soldati e portare poi in dono la palla nemica all’amante. L’imperatrice Eugenia, bigotta e anti-italiana, fu approcciata con una battuta da postribolo: «Ho saputo che le parigine non portano le mutande; questo è un cielo azzurro che si apre per me!». E ai messi di Cavour, che gli offrivano un assegno da due milioni di lire «per rimborsargli le spese sostenute per la causa nazionale» – vale a dire per corrompere generali borbonici, spie, funzionari, avventurieri – purché lasciasse una volte per tutte l’impresentabile Rosina, rispose: «Ringrazio lor signori e tengo la Rosina, ca l’è ’na gran bela fija». Tenne pure l’assegno.
Un re che escogita sotterfugi da bambino: quando giura di ignorare le intenzioni di Garibaldi, che è appena sbarcato a Marsala con il suo incoraggiamento, alza di nascosto il piede destro, convinto che così lo spergiuro non valga. Un re capace però di nobili impuntature; come quando resiste a Radetzky che gli chiede di abolire lo Statuto, o a don Bosco che annuncia sventure se il re promulgherà norme sgradite alla Chiesa: prima le leggi Siccardi che aboliscono il foro ecclesiastico facendo dei sacerdoti cittadini come gli altri, poi le leggi del 1854 che sciolgono le corporazioni religiose. Il santo, che ha fama di taumaturgo e veggente non sempre benevolo, scrive al re per raccontargli un sogno. C’è un valletto di corte che grida: «Triste notizia! Triste notizia! Grande funerale alla reggia!». Vittorio è preoccupato. La regina Maria Adelaide, incinta per la settima volta, stamolto male. Don Bosco scrive ancora: gli è riapparso in sogno il valletto, ma stavolta i funerali alla reggia sono due. Si ammala anche la regina madre Maria Teresa. È lei la prima a morire, il 12 gennaio 1855. Il fratello del re, Ferdinando, ha uno sbocco di sangue, si mette a letto. Il 20 gennaio muore Maria Adelaide dopo aver dato alla luce il settimo figlio, chiamato Vittorio Emanuele come il padre; il piccolo sopravviverà solo quattro mesi. Il re è atterrito. Quando, il 10 febbraio, muore anche Ferdinando, si comincia a parlare di maledizione divina. Vittorio Emanuele piange tutto il giorno, consolato da una processione di cortigiani e popolani. Ma le leggi contro il clero non cambieranno. Passa a salutare anche Alfonso La Marmora, in partenza per la Crimea, alla testa di una spedizione che si batterà bene sulla Cernaia e, pur decimata dal vaiolo, imporrà il piccolo regno e la causa italiana al tavolo delle grandi potenze. Il re lo congeda così: «Fortunato lei, generale, che va a combattere i russi. A me tocca restare a combattere preti e monache».
Con i figli è affettuoso, chiama l’erede Umberto «Beto» e la prediletta Clotilde «Chichina», ma accetta tra le lacrime di darla in sposa – appena quindicenne – al nipote libertino di Napoleone, Gerolamo, che aveva quasi quarant’anni. È la stessa Clotilde a consolare il padre: «Non sono una principessa di Casa Savoia per niente. Nei momenti gravi bisogna avere energia e coraggio. Io li ho, il Signore me li ha dati e me li dà». È un re che piange spesso, anche in pubblico: quando rientra a palazzo dopo l’abdicazione del padre; quando la Camera umilia il generale De Launay da lui designato presidente del Consiglio; quando gli muore la madre; davanti alla bara della moglie; e soprattutto al momento di salutare la figlia che parte per la Francia. Ma gli piace soprattutto ridere, scherzare, dire volgarità, fare battute. Immagina per burla di salire sul Campidoglio, quando Roma sarà nelle sue mani, e di proclamare la Repubblica. Giunto davvero nella capitale, dopo un lungo viaggio in treno, esclama in piemontese: «Finalment ai suma»; diventerà un solenne «finalmente ci siamo e ci resteremo». Superstizioso, evita di dormire nel Quirinale perché una zingara gli ha predetto che la prima notte a Roma gli sarebbe stata fatale. Si ammala lo stesso, a San Rossore. Un «colpo apoplettico», vale a dire un infarto, lo riduce in fin di vita.
L’arcivescovo di Pisa Cosimo Corsi fa sapere che non concederà l’assoluzione, se il re non firmerà un documento che disconosce il suo operato di padre della patria, ma Vittorio Emanuele rifiuta: è un re costituzionale, non può firmare una carta di tale rilevanza senza il suo primo ministro. Il primo ministro è il generale Menabrea, che impone al messo dell’arcivescovo, il malcapitato don Renai, di dare l’assoluzione al re, se non vuol finire in prigione; ma secondo la voce popolare è la Rosina a intervenire per il suo uomo, puntando contro il prete una pistola. Rosina e Vittorio si sposano su quello che pare il suo letto di morte. Ma miracolosamente il re si riprende, vivrà altri nove anni, e a chi attribuisce la guarigione alla benevolenza del prete risponde che il merito è del suo cameriere, che gli ha procurato una prodigiosa bottiglia di porto.
Neanche un uomo così facile da amare, però, si è ritagliato uno spazio nella memoria del paese. Vittorio Emanuele non è un personaggio popolare, a differenza di Garibaldi, e non è considerato un grande di cui non si sa molto ma che merita comunque rispetto, come Mazzini. Ci si ostina a vederlo come un re piemontese, un estraneo, un conquistatore, per il suo rifiuto di cambiar nome, di diventare Vittorio Emanuele I anziché II. Si dimentica che, per fare l’Italia, il re rinunciò alla regione che aveva dato i natali e appunto il nome alla sua famiglia, la Savoia (pur facendo rettificare i confini per non perdere i terreni dove andava a caccia). E rinunciò a Torino, da tre secoli capitale della dinastia, sia pure con sofferenza: «Che dirà Torino? Non è indegno rimeritarla di tanti sacrifici con un sacrificio ancora più crudele? E che importa a voialtri di Torino? Sono io che ne ho il cuore schiantato, io che ho sempre vissuto qui, che ho qui tutte le memorie d’infanzia, tutte le abitudini, i miei affetti…».
Non era scritto da nessuna parte che Torino non potesse restare la capitale d’Italia. Ovunque è capitale la città d’origine della dinastia che ha unificato il paese. Parigi, Londra, Berlino non sono al centro della Francia, del Regno Unito, della Germania. Eppure non vi fu dubbio alcuno, anche nella classe dirigente sabauda, che la capitale dovesse essere Roma, la città fondativa della classicità e della cristianità.
Per allargare un regno straniero, del resto, non sarebbero morti così tanti volontari, in quell’anno straordinario per l’Italia e per l’intera Europa che fu il 1848.
L’Italia insorta
Per prima insorge Palermo, che il 12 gennaio si ribella alla guarnigione dei Borboni. Il 31 Ferdinando II, il sovrano più reazionario d’Europa, è costretto a concedere la Costituzione, che limita i suoi poteri. In gran fretta a Torino si scrive lo Statuto. Nelle fredde serate d’inverno la capitale sabauda è percorsa da giovani patrioti con le fiaccole che invocano la guerra all’Austria.
L’Italia è inquieta da almeno due anni, da quando è divenuto papa Giovanni Maria Mastai Ferretti, che come primo provvedimento ha liberato i prigionieri politici. Spaventato da se stesso e dall’incendio appiccato dalle sue riforme, Pio IX finirà per chiamare in Italia eserciti stranieri e mandare i patrioti sulla forca; ma all’evidenza l’Italia non aspettava altro che un segnale per ribellarsi. A ferragosto del 1847, con l’obiettivo di dare un avvertimento al papa, le truppe austriache devastano Ferrara. Il 3 gennaio 1848 prendono a sciabolate i milanesi che fanno lo sciopero del fumo per danneggiare l’erario imperiale: tra i feriti ci sono sei bambini. Il giorno dopo i carbonari genovesi tentano di linciare i padri gesuiti, simbolo della reazione.
All’alba del 19 marzo Milano insorge contro gli austriaci. Quella notte stessa Francesco Arese, inviato dal comitato rivoluzionario lombardo, va a Torino per sollecitare l’intervento delle truppe piemontesi. Quando, al mattino del 20, Arese si reca alla reggia, assiste impressionato al saluto dei torinesi ai primi reparti mobilitati per la guerra: «A Milano! A Venezia!». La notte del 22 il maresciallo Radetzky e i suoi uomini fuggono con la cassa, dopo aver lasciato sul terreno 335 milanesi. Di 244 si è potuta conoscere la condizione sociale: 160 erano artigiani e operai, 25 domestici, 14 contadini, 29 commercianti, 16 borghesi. Più quattro bambine. E 38 donne, quasi tutte operaie. Non è vero che «sono stati i signori» a cacciare gli austriaci. Il 23 marzo Cavour scrive sul suo giornale, che ha chiamato «Il Risorgimento»: «L’ora suprema per la monarchia sarda è suonata».
I ministri votano all’unanimità: il governo di una città di frontiera di 120 mila abitanti scende in campo contro la più grande potenza d’Europa. Si scrive il proclama ai popoli in rivolta: «Le nostre armi vengono ora a porgervi quell’aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall’amico l’amico». Carlo Alberto precisa che si tratta di una guerra di indipendenza, non di conquista: «Vogliamo che le nostre truppe, entrando nel territorio della Lombardia e della Venezia, portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana». A Torino si canta l’Inno alre: «Figli tutti d’Italia noi siamo / forti e liberi il braccio e la mente / più che morte i tiranni aborriamo / aborriamo più che morte il servir». A Genova, città repubblicana, risuona un inno in cui il re non è menzionato. Si rivolge invece, fin dall’inizio, ai «fratelli d’Italia».
«Niuno che l’abbia amata tanto»
Non era la prima volta nella storia che un esercito combatteva nel nome dell’Italia. «Italia e libertà» era scritto sugli scudi dei veneziani che il 14 maggio 1509 si scontrarono, purtroppo con altri italiani (oltre che con truppe francesi e spagnole unite dal papa nella Lega Santa), alla Ghiara d’Adda, presso Agnadello, a pochi chilometri da Milano. Erano gli anni in cui nel resto d’Europa si andavano consolidando gli Stati nazionali: Francia, Inghilterra, Spagna, e anche la Polonia, destinata a una sorte travagliata spesso parallela alla nostra (l’inno polacco cita l’Italia, «Włochy», e l’inno italiano cita la Polonia). Ma uno Stato unitario nella penisola non nacque. I veneziani furono sconfitti, e non ci riprovarono; il loro disegno egemonico era un altro, il baricentro del loro impero transnazionale era il Mediterraneo orientale, e i loro interessi erano sul mare.
Andò malissimo pure la prima guerra d’indipendenza. Anche per colpa di Carlo Alberto, troppo preoccupato di non farne una guerra di popolo. Il nizzardo Giuseppe Garibaldi si mette subito a disposizione, con il coraggio disinteressato che l’ha fatto amare da generazioni di italiani, ma viene di fatto respinto dal re. Annota Garibaldi: «Vidi quell’uomo che aveva uccisi dei più nobili figli d’Italia, che aveva condannato alla morte me e tanti altri capi e capii la freddezza del suo accoglimento». Scrive Carlo Alberto, in francese, al ministro della Guerra Franzini: «È assolutamente impossibile accettarli [i garibaldini] nell’esercito, e soprattutto nominare Garibaldi generale. L’esercito ne sarebbe disonorato».
Carlo Alberto vince qualche scontro, ma perde l’occasione di unirsi agli insorti delle città venete. Però, quando l’Austria gli offre la Lombardia in cambio della pace, rifiuta: si combatte per l’Italia, non per ingrandire il Regno di Sardegna. Sconfitto a Custoza, comincia una lunga ritirata che si concluderà solo sul Ticino, dopo un tentativo poco convinto di resistere davanti a Milano (infuriati, i milanesi inveiscono contro il re e qualcuno gli tira pure qualche fucilata). Potrebbe rientrare a Palazzo e riprendere a regnare: una volta ripristinato l’ordine di Vienna in Europa, l’Austria non intende infierire sul piccolo e inquieto vicino; le regole dell’assolutismo e del diritto divino proteggono anche chi le ha infrante. Ma ormai Carlo Alberto ha legato il proprio regno alla causa italiana. All’amico milanese Giorgio Pallavicino Trivulzio scrive: «Noi due abbiamo sempre lo stesso pensiero, l’indipendenza d’Italia. Fu il primo sogno della mia gioventù; esso dura ancora. Io ci muoio dietro». Non erano parole vuote.
L’anno dopo, il 1849, il Piemonte torna in guerra contro l’Austria. Una guerra senza speranza, voluta da Carlo Alberto come un destino. Alla vigilia della battaglia decisiva, alle porte di Novara, il generale polacco Chrzanowski, cui è stato affidato l’esercito piemontese, cerca il re per concordare i piani. Lo trova alle tre del mattino, mentre dorme per terra, avvolto in una coperta di lana, la testa su uno zaino: il sovrano si agita nel sonno, la mano inguantata traccia ordini immaginari nell’aria; i soldati sfilano in silenzio a guardare lo spettacolo, e non ne traggono auspici favorevoli per il giorno dopo.
A Novara l’esercito è sconfitto, ma si batte bene. Scrive Radetzky: «Quei diavoli di piemontesi sono sempre gli stessi e, malgrado il minor numero loro e la stanchezza delle marce fatte, ho creduto più di una volta dovermi ritirare». (Quello stesso 23 marzo 1849 insorge Brescia, e si batterà contro gli austriaci per dieci eroiche giornate.) Carlo Alberto cammina da solo sulle vie battute dal fuoco nemico; invano gli scudieri tentano di trascinarlo via; il re cerca una palla che metta fine alle sue sofferenze. Anche i suoi figli sono salvi per caso; il minore, Ferdinando, duca di Genova, ha avuto due cavalli uccisi sotto di lui. Scrive Massimo d’Azeglio: «Sia salvato almeno il nostro onore nella memoria degli uomini».
Carlo Alberto convoca i generali e i familiari. Chiede se c’è ancora speranza di battersi. Tutti dicono di no. Lui risponde: «Da questo momento io non sono più il re; il re è Vittorio, mio figlio». Parte quella notte stessa, solo con il cocchiere e lo stalliere, in tasca un passaporto intestato a un colonnello in pensione, il conte di Barge. Non si ferma neppure a firmare l’abdicazione, devono rincorrere la carrozza, spiegargli che è necessario.
Carlo Alberto attraversa Novara a occhi chiusi, per non vedere i resti del suo esercito. Lo ferma un posto di blocco austriaco. Dice di essere il conte di Barge. La pattuglia lo scorta dal generale Thurn.
Il re è disperato, teme di essere riconosciuto e finire nelle carceri di Radetzky, e in effetti il generale austriaco l’ha riconosciuto, ma vorrebbe evitargli l’ultima umiliazione. Decide di lasciarlo andare; deve però salvare le forme. Viene chiamato un bersagliere, che trasale trovandosi di fronte il suo re. Thurn gli chiede: «Conoscete quest’uomo?». «Lo conosco bene» risponde il bersagliere. «Attento, potete confermare che si tratta del conte di Barge?» lo indirizza Thurn. «È il conte di Barge, lo conosco bene, è lui senza dubbio.» La via dell’esilio è aperta. Carlo Alberto impiegherà ventisette giorni a raggiungere il Portogallo, e tre mesi a morire.
Sono stato a Oporto a vedere la sua stanza, il suo letto. È in un palazzotto a due piani, alla periferia della città. Tappeti francesi, porcellane inglesi, parquet inchiodato. Una piccola cappella con un inginocchiatoio. Una finestra sul fiume Douro. La stanza in cui morì il re che tentò di fare l’Italia è quella d’angolo. Pare una via di mezzo tra una poesia di Gozzano e il mercato dei mobili usati di Porta Palazzo: fiori sotto una campana di vetro, un comodino di legno a colonna. Un thermos, tre sedie, due poltrone, su cui sedettero gli ultimi visitatori giunti da Torino, Giacinto Provana di Collegno e Luigi Cibrario. Il re morente assicurò di essere pronto, «se mai sorgesse una nuova guerra contro l’Austria», ad «accorrere spontaneo, anche qual semplice soldato»; perché «la nazione può avere avuto principi migliori di me, ma niuno che l’abbia amata tanto».
Il disastro della prima guerra d’indipendenza reclama un colpevole. Lo si trova nel generale Gerolamo Ramorino. Patriota convinto, di idee democratiche, non a caso comandante della divisione dei volon...