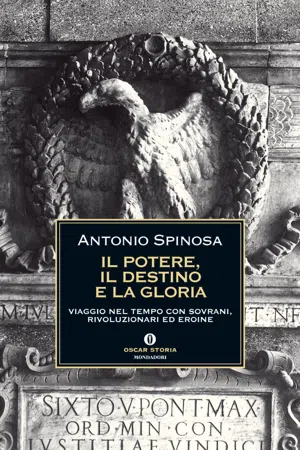
eBook - ePub
Il potere, il destino e la gloria
Viaggio nel tempo con sovrani, rivoluzionari ed eroine
This is a test
- 312 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il potere, il destino e la gloria
Viaggio nel tempo con sovrani, rivoluzionari ed eroine
Dettagli del libro
Anteprima del libro
Indice dei contenuti
Citazioni
Informazioni sul libro
Un avvincente viaggio nel tempo fra uomini di potere, eroine, figure segnate dal destino e artefici della propria gloria. Da Romolo ad Annibale, dal cardinale Schuster a papa Pacelli, passando per Galileo, Nelson, Napoleone, Garibaldi, Verdi. Di ciascun personaggio l'autore delinea un ritratto originale e sorprendente, mettendo l'accento ora sulle tappe cruciali di un'esistenza caratterizzata da profonde contraddizioni, come nel caso di Pio IX, ora sul tragico epilogo di una vita vissuta pericolosamente, come nel capitolo dedicato all'avventura calabrese di Gioacchino Murat.
Uno sguardo attento è riservato alle grandi figure femminili come Eleonora Pimentel, Anita Garibaldi, Anna Kuliscioff, Mafalda e Maria Josè.
Domande frequenti
È semplicissimo: basta accedere alla sezione Account nelle Impostazioni e cliccare su "Annulla abbonamento". Dopo la cancellazione, l'abbonamento rimarrà attivo per il periodo rimanente già pagato. Per maggiori informazioni, clicca qui
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui
Entrambi i piani ti danno accesso illimitato alla libreria e a tutte le funzionalità di Perlego. Le uniche differenze sono il prezzo e il periodo di abbonamento: con il piano annuale risparmierai circa il 30% rispetto a 12 rate con quello mensile.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì, puoi accedere a Il potere, il destino e la gloria di Antonio Spinosa in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia mondiale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia mondialeParte quarta
PARTICIPIO PRESENTE
IL DUCA DEGLI ABRUZZI,
NON SOLO MONTAGNE
Dalle parole del testamento – «Preferisco che intorno alla mia tomba s’intreccino le fantasie delle donne somale, piuttosto che le ipocrisie degli uomini civilizzati» – risaltava tutta intera l’originale personalità di questo duca pioniere, scalatore, circumnavigatore, ma anche ammiraglio e comandante in capo delle forze navali nel corso della Grande Guerra, dal 1915 al 1917. E soprattutto tenace colono, avendo bonificato la piana di Giohàr, in Somalia, ch’era esclusivamente popolata, prima del suo arrivo nel ’19, da iene, sciacalli, serpenti, fra intricate boscaglie e acquitrini mortali.
Venne alla luce a Madrid, dove il padre Amedeo abdicava al trono di Spagna appena due settimane dopo la sua nascita. Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, aveva preso a solcare i mari a sei anni, nel 1879, come mozzo a La Spezia; a dieci anni era allievo dell’accademia navale, dalla quale usciva sedicenne col grado di guardiamarina. E così avanti lungo gli scalini d’una splendida carriera, che non fu soltanto quella del marinaio. Già a vent’anni aveva cominciato a scalare le Alpi con intenti scientifici. Ventiquattrenne conquistava in Alaska il monte Sant’Elia di oltre cinquemila metri. Il nuovo secolo, il Novecento, cominciava per lui tragicamente, costretto all’amputazione di due dita congelate durante una spedizione artica compiuta con Umberto Cagni che commuoverà d’Annunzio nelle Laudi.
Nella sua vita avventurosa mancava però una donna cui legarsi stabilmente, e cominciò a pensare di accasarsi pur senza voler rinunciare né alle ascensioni né alle circumnavigazioni. Ma il matrimonio gli si rivelò più arduo di qualsiasi spedizione. A Washington, nel 1907, aveva conosciuto una ragazza americana – non molto giovane, ma affascinante oltre ogni dire – che sembrava fare al caso suo, essendo entrambi nemici di ogni formalismo. Si chiamava Katherine Elkins. Era figlia d’un senatore repubblicano del West Virginia e miliardaria. Possedeva un’immensa tenuta appunto in Virginia, e lì i due innamorati si rifugiarono per alcuni giorni. Una loro comune passione era rappresentata dai cavalli, e in alcune foto essi furono ripresi durante furiose cavalcate. Kathe, che aveva vinto molti concorsi ippici, apprezzava nel duca italiano il fatto di essere sufficientemente taciturno e ottimo cavallerizzo.
Lui aveva trentaquattro anni, lei trenta. Lei lo raggiungeva in Italia, lui tornava in America sotto il falso nome di Luigi Sarto, conte, e quelle erano le iniziali dei suoi bagagli. L’andirivieni si ripeté per più volte, fino a quando la loro vicenda finì sui giornali di tutto il mondo. Si mormorava che Katherine, oltre a essere priva di quarti di nobiltà, fosse un po’ chiacchierata a causa di alcune sue storie amorose. Se lui conquistava montagne, lei espugnava cuori. Almeno così si diceva. E la voce naturalmente arrivò alle orecchie del severo re d’Italia, Vittorio Emanuele III.
Il sovrano si oppose al matrimonio, che non gli appariva né morale né all’altezza della famiglia reale. Eppure Vittorio aveva sempre mostrato simpatia per il cugino Luigi, nell’ambito delle sue ristrette possibilità caratteriali. Si diceva al tempo stesso che il re avesse già in animo di insignire Kathe del titolo di duchessa di Teramo. Si sospettava anche che il veto provenisse in realtà dalla regina madre Margherita, convinta dell’esigenza di reprimere i sentimenti personali quando non erano in sintonia con gli obblighi dinastici. Quei sospetti si rivelarono fondati, e Luigi, che sui monti e in mare appariva volitivo, piegò la testa. I giornali, soprattutto in America, continuavano a sperare nella felice conclusione d’una tormentata storia d’amore tra un principe di sangue reale – che tuttavia occupava soltanto il nono posto nella linea di successione al trono d’Italia – e una borghesuccia che con i suoi miliardi avrebbe potuto farsi perdonare la mancanza di sangue blu.
Furono proprio i miliardi a costituire l’ostacolo principale alle nozze. La regina madre Margherita così disse a Luigi: «Tu l’ami, e io so che la sposeresti per amore. Ma la ragazza è miliardaria. Il pubblico non ignora questo fatto e crederebbe che un Savoia ha offerto una corona ducale in cambio d’un’astronomica dote. Ti scongiuro, non lo fare».
Ai due innamorati sconfitti non rimaneva che mantenersi in rapporti epistolari. E così fecero per il resto della vita. Luigi ebbe però una nuova amarezza anche in veste di scalatore, poiché sul massiccio del Karakorum non gli riuscì di conquistare la piramide del K2 e i suoi 8600 metri di altezza che ne facevano la seconda cima del mondo. Allora si rivolse al Bride Peak. Non poté raggiungere neppure quella vetta, ma la quota da lui toccata, 7498 metri, era rimasta inviolata fino al suo arrivo. Katherine e il K2 saranno i suoi incancellabili crucci. Non varranno ad annullarli né un’altra donna anch’essa molto amata, la giovane somala Faduma Ali, che naturalmente egli non sposò mai, né la colonizzazione dei venticinquemila ettari dell’impervia piana di Giohàr, a nord di Mogadiscio, cui dedicò tutto se stesso negli ultimi tredici anni di vita. Una vita che si concluse, per un tumore, a sessant’anni nel marzo del 1933. Aveva detto, morendo: «Non chiedete più mie notizie», e diede uno sguardo allo spadino di accademico d’Italia, alle foto che celebravano le sue gesta: le Alpi, il Sant’Elia, le distese del Polo, il Ruwenzori, il Karakorum, le sorgenti dell’Uebi Scebeli. Mancava Kathe. L’aveva dentro più dei suoi monti, dei suoi mari, dei suoi fiumi.
page_no="189" SCHWEITZER,
L’ILLUSIONE DI POTER FARE DA SOLO
Albert Schweitzer era ancora un personaggio che viveva nella nostra immaginazione senza un contorno preciso quando ci mettemmo in viaggio per raggiungerlo. Il senso di incertezza sulla sua figura permaneva benché avessimo letto un paio dei suoi libri più famosi e al nostro orecchio risuonassero le note di alcuni brani musicali di Bach da lui eseguiti all’organo e registrati su un disco che avevamo voluto ascoltare prima della partenza. La meditazione melodiosa della Toccata, adagio e fuga in do maggiore, doveva anzi accompagnarci con i suoi ritorni suadenti fino a Lambaréné, dove avremmo sentito dal suo vecchio organo equatoriale un’altra esecuzione di Bach, un preludio.
Al momento di salire sull’aereo che ci avrebbe portato in Africa, eravamo disposti ad affrontare, insieme ai rischi del viaggio, le rivelazioni che sarebbero potute derivare da un contatto diretto con Schweitzer. L’aver sentito tanto spesso parlare di lui con toni di grande esaltazione aveva indotto non pochi a figurarselo come un personaggio fantastico e irreale. Il dramma di Gilbert Cesbron È mezzanotte, dottor Schweitzer poteva avere a sua volta contribuito a creare intorno a lui un alone di leggenda.
Che cosa, noi stessi, sapevamo di lui? Molto, eppure ancora poco. Sapevamo che era l’animatore di un ospedale africano.
Folgorato dal desiderio di alleviare le sofferenze delle più misere popolazioni della terra, Schweitzer si trovava dal 1913 in Africa a contatto della lebbra, della malattia del sonno, della malaria. I suoi pazienti erano i neri del Gabon, una regione equatoriale dell’Africa francese. L’ospedale da lui fondato nella Missione protestante di Lambaréné, sulle rive del fiume Ogouè, si reggeva con aiuti provenienti da ogni parte del mondo.
La presenza di questo dottore alsaziano in Africa indicava a quali altezze lo spirito umano potesse salire. Ai popoli arretrati si porta il primo sollievo curando i mali del corpo. Quando un individuo primitivo si sente libero dalla sofferenza fisica potrà disporsi ad accogliere l’insegnamento dell’intelligenza. Il Gabon era una delle regioni più depresse dell’immensa Africa. Il dottore elevò il suo ospedale ai margini della foresta vergine. Le esperienze dei suoi primi anni africani le apprendemmo da uno dei suoi libri che portavamo con noi in viaggio e che recava appunto il titolo Dove comincia la foresta vergine.
Era, questo, un documento di rilievo soprattutto perché illustrava con chiarezza il cammino compiuto in soli quarant’anni dal Continente nero. I capitoli finali del libro recavano la data del 1923. Tra queste pagine e la prefazione c’era un immenso divario. La prefazione, che Schweitzer aveva scritto nel 1951, era significativa perché si concludeva con queste parole: «La relazione del mio primo soggiorno a Lambaréné ha il valore di un modesto monumento dedicato all’epoca in cui le colonie erano ancora colonie».
La testimonianza in questo campo di un uomo come Schweitzer era qualcosa di serio. Il dottore non aveva secondi fini da raggiungere, non solo perché alla sua vegliarda età si era davvero liberi dai compromessi, ma pure perché chi ha scelto volontariamente l’esilio africano in nome dell’amore per l’umanità non cede a interessi colonialistici. Come al sorgere del secolo egli parlava di un diritto dell’uomo bianco di sentirsi superiore all’uomo nero, così ora sosteneva che i bianchi hanno il dovere di considerare «cresciuti» i fratelli neri.
«All’epoca descritta nel mio libro» osserva il dottore «avevamo il diritto di sentirci, di fronte all’indigeno, nella posizione del fratello maggiore che vuole il bene del minore e che con la sua maggior istruzione e intelligenza è in grado di giudicare ciò che più favorisce il suo sviluppo e il suo vero progresso, e potevamo quindi agire di conseguenza ... Oggi dobbiamo rassegnarci a non sentirci più i fratelli maggiori e a non agire più come tali. È ormai opinione prevalente che si possa arrivare a un’era di progresso solo a condizione che il fratello minore sia considerato maggiorenne e capace di discernere allo stesso titolo del fratello grande, e che gli indigeni possano prendere sempre più nelle loro mani il destino del paese.»
Questi riferimenti concreti da lui fatti ai problemi dello sviluppo autonomo delle popolazioni africane ci avevano indotto a immaginare uno Schweitzer direttamente impegnato nella soluzione delle vicende economiche e politiche delle terre dove svolgeva la sua opera di medico. Senza sforzo avevamo collegato il nome di Schweitzer, oltre che a una missione umanitaria, a un vivo interesse per la cronaca di ogni giorno.
Egli era di fronte a un’Africa che si emancipava. Il Continente nero ha una superficie di trenta milioni di chilometri quadrati, corrispondente all’estensione dell’Europa Occidentale, degli Stati Uniti, dell’India e della Cina messe insieme. È una proporzione impressionante. L’Africa si stava scuotendo dal suo torpore. Non si poteva comunque pensare che il processo di emancipazione fosse già a buon punto. Il maggiore ostacolo all’incivilimento in senso europeo dei popoli africani era costituito dalla stessa impraticabilità delle regioni. I confini fra uno Stato e l’altro avevano delimitazioni «tracciate nei cieli» più che sulla terra, e di rado corrispondevano alle effettive divisioni delle popolazioni nere. Mai nessun uomo, bianco o nero che fosse, aveva ancora messo piede in sconfinate zone di questo continente; ma avremmo avuto modo di accorgerci direttamente che nello stesso tempo larghi settori della vita africana erano già permeati di nuove civiltà.
page_no="192" Appariva difficile determinare quale potesse essere lo sviluppo delle popolazioni africane. Non si poteva dire con certezza se la civiltà europea sarebbe stata risolutiva nelle scelte dei neri o se l’emancipazione di questi popoli avrebbe imboccato una via del tutto autonoma. Alcuni paesi europei (Francia, Gran Bretagna, Belgio, Portogallo, Spagna) estendevano il loro dominio sul continente africano, ma il numero degli Stati retti dai locali governi di colore era destinato ad aumentare nel giro di pochi decenni.
I fermenti nazionalistici si diffondevano con sempre maggiore rapidità, per cui la funzione dell’Europa si sarebbe dovuta qui modificare e rinnovare. John Gunther nel suo libro sull’Africa si domandava se l’opera dei bianchi fosse finita in queste terre. No di certo, se la loro opera avesse saputo trasformarsi. Già molta strada in questo senso era stata percorsa, essendosi concluso quel cupo periodo trisecolare durante il quale il bianco aveva considerato l’Africa come una riserva di schiavi. I discorsi in Europa e le opere in Africa del dottor Schweitzer, anche a questo proposito, si erano sempre ispirati a un concetto morale che si riassumeva nella sua famosa formula: «Rispetto per la vita». Schweitzer nella solitudine della foresta equatoriale si era chiesto se sarebbe stato mai possibile descrivere le ingiustizie e le crudeltà commesse nel corso dei secoli dai popoli bianchi o valutare i mali causati dall’acquavite che essi distribuivano per istupidire gli indigeni. E rilevava: «Il bene che facciamo agli uomini di colore è un atto non di carità, ma di riparazione ... Per cui le nazioni che possiedono colonie devono sapere che si sono accollate una grave responsabilità dal punto di vista umanitario».
Accanto a questi problemi morali – così intensamente sentiti da anime di nobiltà eccezionale – c’erano quelli più terreni, ma non trascurabili, che si riferivano al posto che l’Africa avrebbe avuto nel futuro assetto mondiale. Via via, le carte geografiche mutavano immagine. Si affacciavano sulla scena del mondo popoli che fino a ieri si erano trovati nella condizione di colonie. Presso quei popoli si svilupparono i principi di libertà che i bianchi, superato lo schiavismo, avevano portato con sé; gli stessi bianchi non sapevano più come andare incontro alle nuove esigenze delle popolazioni che si emancipavano.
Ciò non era riservato all’Africa, perché i fermenti di libertà sono alla base delle trasformazioni politiche e geografiche del mondo intero. Tibor Mende osservò che l’uomo, nello stesso momento in cui cessa di seguire le trasformazioni del mondo nel quale vive, non appartiene più al suo tempo ed è un superato. Mutano i confini e mutano i centri di gravità. In passato il centro di gravità dei popoli civili si trovava in Europa. Oggi dove si trova? Negli Stati Uniti, hanno detto alcuni, mentre altri sostengono che si sia già spostato verso l’oceano Pacifico. Tibor Mende era tra coloro che la pensavano così, e immaginava che perfino verso l’Africa avrebbe potuto trasferirsi il nuovo baricentro mondiale. L’Africa, con le sue immense riserve di materie prime – egli scriveva – arriverà forse un giorno a rivendicare l’egemonia mondiale.
Nell’affannosa corsa dei popoli verso le nuove sistemazioni, molto spesso venivano dimenticati i valori umani che Schweitzer era andato a difendere in Africa tra i lebbrosi della foresta.
Sotto un cielo carico di nubi, al cospetto di un immenso e torbido fiume che spezzava la cupa violenza della foresta equatoriale, sorgeva il villaggio ospedaliero creato da Schweitzer. Raggiungemmo questo luogo, insieme ad altri giornalisti italiani e stranieri, al termine d’un viaggio in aereo di oltre cinquemila chilometri attraverso il Mediterraneo, il Sahara, la Nigeria, il Golfo di Guinea e il Gabon. Il ricordo di Roma, dopo tre giorni di volo su questo immenso mondo impressionante e ancora sconosciuto, era diventato un piccolo punto in fondo ai pensieri dei giornalisti così repentinamente piombati sulle rive dell’Ogouè, all’Equatore.
L’occasione di avvicinare Albert Schweitzer – il grande dottore bianco della giungla – ci era stata offerta da una iniziativa benefica. Un ragazzo nero, Robert Hill, figlio di un sergente americano di stanza a Napoli, commosso dalle notizie sulle sofferenze delle popolazioni africane, aveva avuto l’idea di lanciare un appello perché si soccorressero quelle genti con l’invio gratuito di medicinali. La NATO stessa curò l’iniziativa, così che due aerei militari da trasporto partirono dall’Italia verso l’Africa con a bordo grandi quantitativi di medicinali. La maggiore offerta era stata quella della casa farmaceutica italiana Lepetit che aveva inviato al dottor Schweitzer un carico di «specialità» per un valore di 220 milioni di lire di allora.
I due grossi aerei militari, uno italiano e l’altro francese, arrivarono a Libreville, capitale del Gabon, la mattina del 17 luglio 1959. L’oceano Atlantico conferiva a questa città un aspetto di grande spiaggia internazionale. Le rigogliose palme che si inseguivano lungo la marina testimoniavano, meglio degli stessi indigeni, che questa era una regione dell’Africa. Libreville era infatti l’ultimo lembo di terra che ancora conservava sembianze europee. Un nuovo balzo condusse poi la spedizione a Lambaréné, meta del viaggio.
Lambaréné sorgeva a soli 260 chilometri da Libreville, verso l’interno, eppure quei pochi chilometri, ancor più dei cinquemila che separano queste terre da Roma, valsero a portarci nel vero cuore dell’Africa.
Sul piccolo aeroporto di Lambaréné, il dottor Albert Schweitzer attendeva i donatori. L’abbraccio fra il grande dottore e il ragazzo nero che aveva avuto l’idea di far pervenire i medicinali in Africa era stato commovente. Un leggero vento scompigliava i capelli del vecchio Schweitzer. L’abbraccio era stato più volte ripetuto perché i fotografi e gli operatori potessero fermare meglio quel momento. Ogni volta la stretta era ugualmente sentita.
Intorno, la foresta vergine dominava il paesaggio. Nella mente di ognuno di noi era ancora presente l’immensa e compatta distesa di alberi così come dall’aereo era apparsa in tutto il suo inviolato mistero. Solo l’Ogouè riusciva a fendere quella massa verde con le sue gialle acque. Risuonava ancora alle nostre orecchie il sibilo del segnalatore acustico che il comandante dell’aereo aveva premuto nel momento in cui superavamo l’immaginaria linea dell’equatore. Lambaréné sorgeva ottanta chilometri a sud di questa linea.
Schweitzer era al centro dell’attenzione e l’Africa intorno a questo grande personaggio era soltanto uno scenario. Di alta statura, magro, leggermente curvo sotto il peso degli ottantaquattro anni, il dottore della giungla vestiva di bianco. Un po’ trasandato negli abiti, nervoso nei movimenti. Lo sguardo acuto; la stretta della mano ossuta, ferma e calorosa. I grossi baffi spioventi mitigavano la severità del suo duro volto di tedesco. Lo sguardo, da severo, si faceva di volta in volta malizioso, capriccioso, condiscendente, interessato, nobile, ma anche irritato, e perfino sprezzante. Nei tre giorni di sosta della spedizione a Lambaréné, il grande dottore doveva mostrarci tutti questi suoi aspetti in così aperto contrasto tra loro.
La durezza con cui egli trattava gli indigeni ci avrebbe più di ogni altra cosa sorpreso. Lo vedemmo inveire contro un nero che non aveva eseguito certi suoi ordini. Lo chiamò «bestione selvaggio e ignorante». Ma da questa sua irritabilità Schweitzer trovava nuovi motivi filosofici. Vi costruiva sopra un’etica del perdono inteso come un atto cui si è costretti dalla sincerità verso se stessi. Alla domanda «Perché perdono al mio simile?», Schweitzer diceva che l’etica comune risponde: «Si perdona al proprio simile perché si ha pietà di lui». Quindi l’etica comune presenta gli uomini come esseri eccezionalmente buoni quando perdonano e permette loro di praticare una specie di indulgenza che è davvero umiliante per la persona perdonata. Invece l’etica del rispetto per la vita chiarifica queste oscure e annebbiate nozioni poiché afferma che ogni tolleranza e perdono è un atto cui si è costretti dalla sincerità verso se stessi. «Sono obbligato» spiega ulteriormente Schweitzer in Civiltà ed etica «a esercitare perdono illimitato perché, se non perdonassi, sarei insincero verso me stesso, in quanto agirei come se non fossi mai stato colpevole verso di me. Devo perdonare le bugie rivolte contro di me, perché la mia vita è stata macchiata tante volte dalla menzogna; devo perdonare la mancanza di carità, l’odio, la calunnia, l’inganno, l’arroganza, dato che io stesso ho mancato di carità, ho odiato, calunniato, ingannato e sono stato arrogante. Devo perdonare senza far scalpore. In generale, non perdono, non arrivo nemmeno a essere semplicemente giusto.»
Dal 1913 Albert Schweitzer svolgeva la sua opera di medico in questo lontano angolo dell’Africa. La medicina non fu per lui una vocazione della gioventù, ma piuttosto degli anni maturi; fu una scelta che egli compì quando già si era lungamente dedicato allo studio della musica, della filosofia, della teologia, e aveva ottenuto il successo in ognuno di questi settori. Quando si laureò in medicina aveva trentotto anni. Si era nel 1913. L’anno successivo, accogliendo l’invito d’una missione evangelica di Parigi, costruì la prima baracca sulla riva dell’Ogouè, nel Gabon, in una zona chiamata Andende. Con lo scoppio della Prima guerra mondiale egli, a causa della sua nazionalità tedesca, fu trattato da straniero nemico e condotto in Francia dove venne internato in un campo di concentramento. Nel 1924, dopo alcuni anni di insegnamento universitario e di attività concertistica, fece ritorno in Africa. Il suo ospedale era caduto in rovina sotto l’inesorabile avanzata degli alberi della foresta. Schweitzer ricominciò da capo piantando le tende sull’altra sponda dell’Ogouè, a ridosso d’una verde collina denominata Adolinanongo, che, nel linguaggio degli indigeni, significa «il luogo da dove si guarda il popolo».
Come raccontava Schweitzer la maturazione della sua idea missionaria? Mentre frequentava l’università e godeva «la felicità di studiare e di ottenere qualche risultato nel campo delle scienze e dell’arte», non poteva fare a meno di «pensare continuamente a coloro ai quali questa felicità veniva negata dalle circostanze materiali o dalla salute». A ventun anni, nella sua casa di Giinsbach, fu sorpreso dal pensiero che non gli era possibile accettare quella felicità come un fatto naturale e che pertanto doveva dare qualcosa in cambio. Precisava: «Continuando a ragionare su questo argomento decisi con me stesso che mi sarei ritenuto scusato se avessi vissuto fino ai trent’anni per la scienza e l’arte, e mi fossi poi dedicato da quell’età in avanti alla diretta assistenza dell’umanità».
Si fece medico anche perché aveva bisogno di az...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Introduzione
- Parte prima
- Parte seconda
- Parte terza
- Parte quarta
- Indice dei nomi