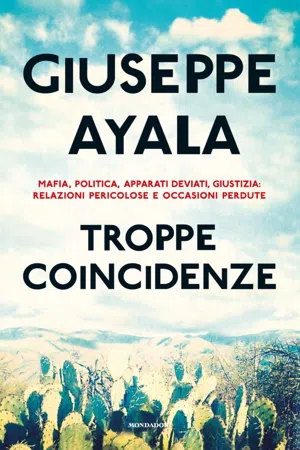![]()
Ho voluto raccontare la stagione dell’Ulivo soprattutto per far comprendere come sia stato possibile perdere un’occasione storica, anzi unica, visto come sono andate le cose negli anni successivi: quella di realizzare una profonda e incisiva riforma della giustizia nell’interesse dei cittadini e per il bene del paese.
L’amarezza e la delusione per le aspettative tradite sono riaffiorate. Ci avevo creduto e mi ero speso come più non potevo. Avevo vissuto i difficili anni in cui, dall’abisso di Tangentopoli e delle stragi, pareva ci fossimo rialzati per dar vita a una nuova stagione di speranza. Ma che speranza si può alimentare senza una giustizia degna di questo nome?
L’ultimo bagliore mi era stato offerto da Giuliano Pisapia, ministro della Giustizia in pectore dopo la vittoria dell’Unione nel 2006.
Lo chiamai per congratularmi e fargli gli auguri di buon lavoro.
Venne a trovarmi a casa e mi propose di seguirlo in quell’esperienza. Non gli sarebbe dispiaciuto avvalersi della mia collaborazione per la realizzazione del disegno riformatore che aveva in mente.
Non coltivavo illusioni, tuttavia lo ringraziai e gli confermai la mia disponibilità anche per ricambiare l’attestato di stima manifestatomi. Non se ne fece niente.
Giuliano non entrò nella squadra di governo. Il ministero della Giustizia non fu più assegnato a Rifondazione comunista, dopo l’elezione di Fausto Bertinotti alla presidenza della Camera dei deputati. Sarebbe stato troppo rispetto ai delicati equilibri che regolavano la distribuzione dei ruoli tra i partiti della coalizione. L’incarico di Guardasigilli fu affidato a Clemente Mastella.
Non mi avventuro nella cronaca degli anni successivi. Quello che è accaduto era scontato. Nessuna aspettativa è stata più tradita per la semplice ragione che solo un visionario avrebbe potuto averne una. E così mi sono risparmiato nuove amarezze e nuove delusioni. Non consola, ma aiuta a vivere meglio.
La mia amata giustizia, invece, vive sempre peggio. Nessuno l’aiuta, molti la bastonano. La credibilità della magistratura, dopo aver raggiunto la fiducia dell’80 per cento dei cittadini ai tempi di Mani Pulite, è precipitata intorno al 40 per cento. La forbice tra i due dati non è significativa in termini assoluti, per la semplice ragione che l’uno, al pari dell’altro, sono condizionati dall’andamento dello scontro con la politica e, di conseguenza, dall’irragionevolezza delle reazioni che ne derivano. È assai probabile che entrambi siano «drogati», per eccesso il primo e per difetto il secondo. Non rispecchiano realtà: misurano emotività.
Ciò non toglie che dal conflitto tra magistratura e potere politico non si può prescindere, se si vuole ragionare sulle cause che determinano quella «crisi della giustizia» che è sotto gli occhi di tutti e che si trascina da un tempo talmente lungo da farla apparire difficilmente superabile.
È vero, come ha sottolineato il procuratore generale della cassazione, Vitaliano Esposito, «che il conflitto tra politica e magistratura è rilevabile in qualsiasi società moderna, tanto da portare a definire questo fenomeno come espansione globale del potere giudiziario. Ma l’incontro-scontro tra il mondo giuridico e quello politico crea sconcerto nell’opinione pubblica. E la credibilità della giustizia si dissolve laddove questo scontro si incunei all’interno della stessa magistratura». Parole sagge ed equilibrate, ma forse un po’ troppo super partes rispetto alla situazione italiana.
Mi avvalgo, ancora una volta, dell’autorevolezza di Giovanni Falcone, il quale vent’anni fa, ancora prima della deflagrazione di Tangentopoli, disse: «Siamo, ancora una volta, in presenza della storia infinita delle reciproche querelles dei magistrati che addebitano al potere politico di volere soffocare l’autonomia e indipendenza della magistratura, per ottenere una sostanziale impunità, e dei politici che addebitano alla magistratura un sostanziale straripamento dai propri compiti, per ergersi a sorta di contropotere non legittimato da alcuna istanza popolare». Una fotografia ingiallita dal tempo che ritrae, però, l’identico scenario che continua a offrirsi ai nostri occhi. Con la differenza che, nel frattempo, i toni, e non solo quelli, si sono inaspriti sino a superare ogni limite di guardia.
Il guaio è che mentre politica e magistratura rinnovano la querelle che li oppone, il comune cittadino che per qualsivoglia ragione si ritrovi ad avere a che fare con la giustizia maledice quel momento, sperando che rimanga l’unico della sua vita.
È però riduttivo e, per certi versi, anche fuorviante guardare al mondo della giustizia senza allargare lo sguardo al più complesso e articolato sistema di garanzia della legalità. La quale non è soltanto un bene, ma è anche una risorsa, la cui difesa va affidata a uno spettro ampio di interventi che non possono essere assegnati in esclusiva alla magistratura, come molti sono portati a credere; il suo ruolo istituzionale ne risulterebbe distorto. Una società complessa, come lo sono tutte quelle avanzate, non può permettersi di convivere con tassi di illegalità che superino una certa soglia (possibilmente bassa). Di conseguenza, deve essere capace di dotarsi di meccanismi di controllo idonei ad assicurare il mantenimento di quella soglia. Ed è pacifico che questi debbano essere di due tipi: preventivi e repressivi. Quanto meglio funzionano i primi, tanto meno saranno chiamati in causa i secondi.
Questo avviene nelle moderne democrazie ma non in Italia, dove tutte le strutture amministrative e burocratiche di controllo (preventivo) sono inefficienti, quando non sono addirittura saltate, per cui di fronte al malaffare dell’apparato politico, così come di quello economico, è rimasto soltanto il filtro della magistratura (repressivo). Il nodo l’abbiamo trovato.
La «questione giustizia» domina il campo della contrapposizione politica per una sola ragione, tanto semplice quanto grave: l’unico baluardo che tenta di arginare il diffondersi di ogni forma di illegalità – quella dei colletti bianchi compresa – è ormai costituito soltanto dalla magistratura. La quale si ritrova così a rivestire un ruolo che l’ha spinta, in talune occasioni, ai limiti dell’alveo istituzionale di competenza.
Un esempio, tra i tanti: se il mondo politico della cosiddetta Prima Repubblica non avesse supinamente accettato che la corruzione dilagasse sino al punto da dominare la scena istituzionale, non sarebbe esplosa Tangentopoli, con tutti i suoi meriti, ma anche con qualche distorsione, difficilmente evitabile visto il debordante protagonismo oggettivamente assunto in quella vicenda (mi piace pensare loro malgrado) dai magistrati.
La politica non è stata capace di rispondere in modo convincente. Non ha tesaurizzato la lezione e, anziché rigenerarsi, ha fatto altro. I settori più agguerriti si sono scagliati in un’interessata contrapposizione spinta sino alla più ostinata e devastante delegittimazione possibile, quelli più riflessivi, invece, sono rimasti prigionieri di una sorta di gelosa insofferenza per l’avvenuta invasione del campo riservato al potere politico. Gli uni e gli altri non si sono risparmiati, sia pure con diversità di stile, nel brandire a mo’ di clava gli errori o gli eccessi compiuti da questo o quel magistrato. Ci sono stati, non c’è dubbio, e sarebbe ingiusto negarli. Così come è altrettanto ingiusto denunciarli quando, invece, non se ne vede traccia.
Come venirne fuori? I più combattivi, la strada l’hanno trovata e la percorrono da anni: non fare nulla che possa risolvere i problemi che affliggono il servizio giustizia, primo fra tutti l’inefficienza, per puntare invece con decisione verso un sostanziale ridimensionamento dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, con il malcelato fine di renderla meno «pericolosa» e «ingombrante». Gli altri si vedono poco e si sentono meno, perché sono alle prese con la loro insofferenza, alla quale si è aggiunto il disorientamento derivante dalla consapevolezza della pericolosità di una guerra alla magistratura. Sono diffidenti a trecentosessanta gradi e non sanno bene che fare.
È questo, a tutt’oggi, lo stato dell’opera. Il risultato è che, sia pure per ragioni molto diverse, buona parte del mondo politico mal sopporta i magistrati. La giustizia ne paga le conseguenze e continua a languire nella sua inefficienza.
Con quel tanto di provocazione che non guasta, ho suggerito, da tempo, un possibile percorso per uscire dall’impasse.
Supponiamo per un momento di condividere l’esigenza che postula la necessità di interventi destinati a contenere il potere dei magistrati. La riduzione della loro indipendenza e autonomia non è la strada da scegliere: presenta infatti così tante controindicazioni che non risulterà difficile trovare l’ascolto dei politici più attenti: se non degli agguerriti, quantomeno dei riflessivi insofferenti. A loro va fornita una soluzione praticabile per raggiungere l’obiettivo senza provocare danni. È sufficiente farli riflettere sul rapporto che lega il controllo repressivo della magistratura agli altri controlli, quelli per loro natura preventivi. Non sarà difficile spiegare che tanto meglio funzioneranno questi, tanto più saranno destinati a ridimensionarsi i settori di intervento degli «odiati» repressori, per l’ovvia ragione che molte forme di illegalità saranno individuate e fermate prima di diventare tali, con buona pace dei magistrati.
Gli esempi non mancano. Ne scelgo uno, quello che riguarda la nota vicenda Parmalat, trascinatasi per dieci anni senza che nessuna delle autorità di controllo abbia trovato nulla da ridire. Nel frattempo migliaia di ignari cittadini continuavano a fidarsi e investivano i propri risparmi nei titoli emessi da quella società, senza avere alcun motivo per sospettare che avrebbero perso tutto. Lo scandalo emerse solo quando un rapporto della guardia di finanza approdò finalmente sulla scrivania del procuratore della repubblica di Parma. La storia è andata, più o meno, così e conferma che, anche in quell’occasione, soltanto l’intervento della magistratura ha fermato il protrarsi di un’illegalità spaventosa (della quale ho ricordato solo la parte subita dai risparmiatori, per brevità, ma anche per sottolineare l’enormità della vicenda). Se solo uno dei tanti controlli preventivi previsti dalla legge fosse intervenuto per tempo, il danno sarebbe stato, se non evitato, certamente contenuto. E il ruolo della magistratura, se non escluso, di sicuro residuale.
Morale: se si vuole restringere l’alveo in cui scorre l’attività della magistratura, il modo più intelligente per farlo è rafforzarne gli argini, rendendo efficienti tutti gli interventi destinati a impedire che si formi la piena.
L’operazione sarebbe agevolata se in Italia funzionasse il controllo che sta alla base di qualunque altro, quello sociale, sempre decisivo nei paesi dotati di una forte etica pubblica. Tra i quali temo non rientri il nostro.
Qualche esempio a conferma del mio timore. È notorio che negli Stati Uniti la prima sanzione che scatta a carico di chi è accusato di evasione fiscale è quella inflitta dai suoi vicini: nessuno lo invita più a cena e, magari, gli toglie pure il saluto. Non si tratta di «bacchettonismo», ma di senso della realtà. L’evasore, sottraendo il dovuto al fisco, arreca un danno agli altri contribuenti, la cui aliquota comprenderà anche quel tanto in più che serve a compensare i mancati introiti provocati dall’evasione. In Italia, invece, è assai probabile che accada l’esatto contrario: l’evasore continuerà a ricevere inviti a cena proprio perché spieghi com’è riuscito a frodare l’erario.
In Inghilterra, nel 2009, si è scoperto che alcuni parlamentari avevano abusato dei rimborsi spese loro riconosciuti. Subito si è dimesso lo speaker della Camera dei Comuni, la terza carica istituzionale più importante, poi alcuni ministri, mentre il capo del governo Gordon Brown annunciava che i deputati laburisti coinvolti nello scandalo non sarebbero stati ricandidati.
Recentemente un ministro tedesco, giovane e di belle speranze, Karl Theodor zu Guttenberg, si è dimesso subito dopo la diffusione della notizia secondo la quale aveva copiato una settantina di pagine della sua tesi di dottorato.
Anni fa negli Stati Uniti un candidato alla Casa Bianca rinunciò alla corsa perché per un certo periodo non aveva versato i contributi alla colf, e si era saputo.
In tutti e tre i casi è stata sufficiente la reazione indignata dell’opinione pubblica per determinare quelle scelte. Nel nostro paese, invece, vengono eletti in Parlamento indagati e, addirittura, condannati, come se nulla fosse. Né mancano esponenti pubblici che rimangono coinvolti, durante il loro mandato, in vicende sospette, se non peggio. I giornali ne danno notizia, molta gente indubbiamente reagisce, ma le dimissioni languono. Conosciamo bene il copione della sceneggiata alla quale puntualmente assistiamo quando viene indagato il «potente» di turno. Nessuno conosce gli atti a suo carico, ma ciò non impedisce che sui giornali e attraverso le televisioni venga denunciato l’ennesimo «abuso della magistratura politicizzata al servizio di un chiaro disegno politico volto a scardinare la maggioranza democraticamente scelta dai cittadini con il loro voto». Segue la serena dichiarazione dell’interessato: «Saranno i magistrati ad accertare la verità. In quella sede dimostrerò la mia estraneità ai fatti che mi vengono addebitati». Quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase. Al punto che ormai la conosciamo a memoria.
Ridimensionare il problema non è difficile: basterebbe che i partiti politici si preoccupassero di selezionare i loro rappresentanti dopo avere dato un’occhiata all’articolo 54 della Costituzione, che recita: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore». Le occasioni di scontro con la magistratura si ridurrebbero sino al classico lumicino, e lo stato di salute della nostra democrazia si lascerebbe alle spalle l’attuale patologia che lo affligge.
Attenzione: che qualche caso di deprecabile «protagonismo» di questo o quel magistrato ci sia stato è indiscutibile. E meglio sarebbe per tutti che fosse sanzionato con celerità e severità. Ma che si debba sempre parlare di un «uso strumentale della funzione giudiziaria» mi pare, francamente, un’esagerazione che, a sua volta, sa molto di «uso strumentale» delle parole.
Non mi sento di escludere che tutto questo possa portare una parte dei magistrati a scegliere la prudenza, piuttosto che affrontare una fastidiosa esposizione mediatica. Sono donne e uomini, non macchine. La comprensione umana non cancella, però, la preoccupazione per le conseguenze che ne potrebbero derivare.
Non mancano poi, viceversa, le accuse di «lassismo». Un caso classico si verifica quando viene scarcerato qualcuno che successivamente viene riacciuffato perché sorpreso a commettere un reato, magari grave. Apriti cielo! E se il contenuto degli atti era tale da imporre quella scelta? Domanda senza risposta. Il giudice ha sbagliato perché ha liberato un delinquente, punto e basta. Magari talvolta ci può anche essere stata una superficiale sottovalutazione – come si può escluderlo a priori? – ma pensare che ciò avvenga sistematicamente mi pare francamente eccessivo.
Sintesi: è assai probabile che dalle nostre parti, ormai, la giustizia che risulta più gradita è quella debole con i forti e forte con i deboli.
Una conferma la si può ricavare dalla composizione della popolazione carceraria: il 60 per cento circa è costituito da tossicodipendenti ed extracomunitari. Ma vi pare possibile che siano davvero loro a commettere il 60 per cento dei reati che si registrano in Italia?
La sostanziale assenza di «controllo sociale» sposta perciò esclusivamente sul giudice l’accertamento della rilevanza penale di quei comportamenti. L’unica che conta, ormai. Il processo durerà anni e, comunque vada a finire, nel frattempo il cursus honorum del personaggio coinvolto procederà serenamente.
La percezione più diffusa è dunque diventata la seguente: tutto quello che non è accertato come reato, è lecito. Si può fare. Concetto assai discutibile che, comunque, non dovrebbe valere mai per chi ricopre cariche pubbliche, come ci ricorda l’articolo 54 della nostra Costituzione già richiamato. E, invece, siamo arrivati all’estremo opposto, con l’approvazione di leggi tendenti a impedire pure l’accertamento penale.
Il controllo dell’opinione pubblica è andato in soffitta anche perché ampi settori della cosiddetta «società civile» si sono adagiati in diffusi comportamenti favorevoli a furberie di ogni tipo, che si concretizzano nella pratica delle «mazzette», nell’evasione fiscale, nell’abusivismo edilizio, nei certificati medici di comodo, nella truffa alle assicurazioni, nelle frodi comunitarie. E chi più ne ha più ne metta. Non sono scivolato in una generalizzazione, sempre foriera di errori: tutti conosciamo tante persone serie, perbene e rispettose delle leggi, ma conosciamo anche gli altri. E non sono pochi. È come se si fosse stretto un patto non scritto fondato sulla complicità, una sorta di clausola ammiccante che potrebbe suonare così: «Con quello che combino io, come faccio a criticare quello che hai combinato tu?». Esponenti pubblici compresi.
La politica dovrebbe, però, dimostrare ugualmente di essere capace di riattivare tutti i controlli preventivi esistenti. A quel punto forse anche quello sociale riceverebbe una scossa. E, comunque, l’obiettivo sarebbe centrato due volte: il peso della magistratura risulterebbe ridimensionato, non a danno dell’interesse generale, ma in suo favore, perché sicuramente la legalità risulterebbe, nel complesso, meglio presidiata. L’esatto contrario rispetto a un disegno di indebolimento della magistratura, realizzato il quale non c’è dubbio che tutti i protagonisti di ogni attività illecita tirerebbero un bel sospiro di sollievo.
A proposito di questi ultimi, tanto per renderci conto della dimensione del problema, è opportuno richiamare i dati forniti dall’Istat e dall’Agenzia delle entrate sul fatturato annuale delle principali forme di illegalità che affliggono il paese: evasione fiscale, 120 miliardi di euro; riciclaggio, 150 miliardi di euro; mafie varie, 135 miliardi di euro. Colpisce il dato che riguarda la corruzione: 70 miliardi di euro; non per niente Transparency International colloca l’Italia al 67º posto, tra le 150 nazioni rilevate. Scusate se è poco, verrebbe da dire.
Ma com’è combinata la macchina della giustizia che tutto questo, oltre che altro, dovrebbe contrastare? Male. Anzi, malissimo. Il suo principale limite è l’inefficienza, da cui deriva una lentezza inaccettabile che, a sua volta, genera tutta una serie di altri problemi.
La classifica internazionale sui tempi processuali contenuta nel rapporto «Doing Business», che la Banca mondiale redige per fornire indicazioni alle imprese sui paesi in cui è più vantaggioso investire, ne prende atto e riserva all’Italia il 156º posto su 181. La precedono, tanto per capirci, l’Angola, il Gabon e la Guinea. I ritardi della nostra giustizia provocano, innanzitutto, un danno al sistema paese perché scoraggiano gli imprenditori stranieri a investire in Italia: una controversia si può sempre mettere in conto, ma l’attesa di una sentenza che si protrae per anni non è conciliabile con la velocità che caratterizza la circolazione dei capitali nel mondo globalizzato. Il «Doin...