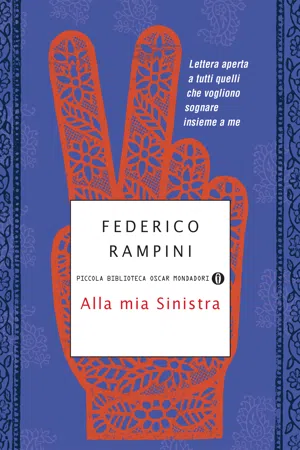Sanza Jiji oggi è una ragazza di 16 anni, suo fratello Seila ne ha 12. Ne avevano rispettivamente 10 e 6, quando mi hanno adottato. Sono sempre insieme alla loro amica del cuore, Cheguo Chihe, coetanea di Sanza. Un trio inseparabile, per loro fortuna: con quello che la vita gli ha riservato, la loro solidarietà è un tesoro prezioso. Era il 2005, l’anno del nostro primo incontro. Da Pechino in cinque ore di volo mi ero spinto nella punta meridionale del Sichuan; là, partendo dalla città di Xichang, avevo preso una jeep per arrivare in una zona montagnosa, a quasi 2000 metri di altitudine. Ero sulle tracce di una vicenda terribile di cui mi erano giunte voci: la storia del popolo Yi, le cui origini risalgono al XIII secolo. Vengono dalle montagne del Tibet, e i loro volti assomigliano a quelli dei tibetani: hanno la pelle più scura, gli zigomi più pronunciati dei cinesi Han. Oggi ne restano, si dice, circa sei milioni. Sono sparpagliati nelle zone più remote e misere del Sichuan e dello Yunnan. Quando mi sono imbattuto in Cheguo, Sanza e Seila, stavo arrancando nel fango per i sentieri del loro villaggio, tra casupole fatiscenti. In quella località, Jiudu, in molte case non c’erano né acqua potabile né la luce. Le fogne erano a cielo aperto, e i bambini ci sguazzavano dentro, giocando con qualche maiale e qualche gallina.
Un paesaggio più vicino all’Africa che alla Cina moderna della capitale in cui abitavo. Un’altra povertà era ben visibile: i giovani adulti erano quasi introvabili, e la prima impressione di Jiudu era questa, un villaggio di vecchi e bambini. Dov’era la generazione di mezzo? Stritolata dal progresso cinese, dall’avvento dell’economia di mercato, decimata dall’emigrazione, dall’eroina tagliata e scadente, dall’Aids. «I giovani» mi aveva detto il capo villaggio, il vecchio Quzhe Mu «vanno a cercare il lavoro e il denaro in città, non trovano né l’uno né l’altro e cercano scampo nella droga. L’eroina ha cominciato a circolare nel 1992, quelli che iniziarono a prenderla allora sono già morti tutti.» Una disgrazia di quelle montagne del Sichuan è quella di trovarsi lungo antiche vie di comunicazione collegate al «triangolo d’oro» degli oppiacei: Thailandia, Birmania e Laos.
Quando la Cina iniziò ad aprirsi al mondo esterno, cominciò a circolare di tutto. Me lo confermò Hou Yuangao, anche lui di origine Yi, che mi aveva accompagnato in quel primo viaggio. Ricercatore etnografico, fondatore di una Ong che cerca di aiutare il suo popolo, il quarantenne Hou era anche il mio indispensabile interprete: a condannare gli Yi alla marginalità contribuisce il fatto che non parlano il mandarino. «L’impatto della modernizzazione su queste minoranze etniche è stato tremendo» mi spiegava il professor Hou. «L’agricoltura non bastava più a mantenerli, nascevano nuovi bisogni, l’attrazione delle città era potente. Senza alcuna istruzione, gli Yi nelle città non potevano integrarsi nel mondo del lavoro, non reggevano i ritmi di produttività cinesi. Sono diventati ladruncoli, spacciatori, prostitute. L’Aids è stato fulminante, si è propagato alla velocità della luce.» Di quello sterminio furono vittime i genitori di Cheguo, Sanza e Seila, tutti morti a vent’anni; qualcuno, a quanto si dice, fu ucciso in scontri a fuoco con la polizia.
Quando i tre bambini si sono incollati a me, stringendomi la mano per tutta la mia visita al villaggio, stavano lottando per la sopravvivenza: vivevano soli e le loro case erano in rovina. Tra i vicini qualcuno li aiutava, altri rubavano loro i pochi utensili agricoli rimasti, o il magro raccolto di patate nel campicello ereditato dai genitori. È la dura legge della giungla: a quei livelli di povertà possono convivere gesti di solidarietà e ferocia. Il mio primo riflesso da occidentale è stato di portarli via, lontano, il più lontano possibile da quell’orrore. L’impulso era quello di ricostruire loro una vita subito, come la sogno io, a immagine e somiglianza del mondo da cui vengo. Il mio accompagnatore Hou era contrario all’adozione. Ho capito che una delle sue resistenze era «politica»: lui dedica la sua vita a salvare dall’estinzione il popolo derelitto degli Yi; le adozioni da parte di stranieri benestanti e benintenzionati non farebbero che accelerare la dissoluzione di questa minoranza. Ma Cheguo, Sanza e Seila avevano fatto la loro scelta, mi avevano preso la mano per non lasciarla più. È cominciata così la nostra storia insieme, fra mille difficoltà e un futuro ancora incerto.
La via dell’adozione ufficiale mi è stata preclusa in tanti modi. All’inizio, e per un paio d’anni, i tre ragazzini non avevano neppure documenti d’identità, non risultavano iscritti all’anagrafe. Non solo adottarli, ma anche farli viaggiare in treno o in aereo fino a Pechino era impossibile senza un pezzo di carta che dimostrasse la loro esistenza. Poi le nuove leggi cinesi sulle adozioni, via via più severe e restrittive (soprattutto per gli stranieri), hanno stabilito che mia moglie e io siamo già troppo vecchi. Allora li abbiamo trasferiti nella città-capoluogo di Xichang, in una scuola con pensionato, sempre con l’aiuto dell’Ong del professor Hou. La priorità assoluta è che imparino bene il mandarino, senza il quale saranno sempre degli esseri umani di serie B, in Cina. Poi, accompagnati da Hou, hanno cominciato i loro viaggi per venirmi a trovare a Pechino. Ognuna di quelle visite era una delizia. Ricordo la prima volta che videro piazza Tienanmen: la conoscevano solo in televisione, gli sembrava di essere sbarcati sulla luna. Per loro, venuti dal Sichuan, tutta Pechino era una rivelazione meravigliosa: l’aeroporto, il metrò, il giardino zoologico, i grattacieli, perfino il traffico o gli elettrodomestici della mia cucina. Qualche volta, quei viaggi erano anche l’occasione per vedermi con tutta la mia famiglia: mia moglie Stefania, i miei due figli ventenni Costanza e Jacopo in visita dagli Stati Uniti. Lungi dal sentirsi meno importanti, o marginali nella mia vita familiare preesistente, per Cheguo, Sanza e Seila lo spettacolo di una famiglia normale è un’esperienza rassicurante. Costanza e Jacopo sono diventati degli idoli per loro.
Ma quei ricongiungimenti a Pechino sono stati per me anche occasione di scoperte dolorose. Ricordo come fosse oggi il trauma del nostro primo pranzo in un fast food MacDonald’s: facciamo la fila tutti insieme di fronte al bancone, poi, quando arriva il nostro turno, voglio che siano i tre bambini a ordinare. Ma i camerieri cinesi non li guardano neppure. Io insisto. Appena i miei tre piccoli Yi aprono bocca, nel loro mandarino stentato e impreciso da provinciali, quelli del MacDonald’s gli scoppiano a ridere in faccia. Altre volte, portandoli ai grandi magazzini, mi accorgevo che erano oggetto di una vigilanza speciale, ostile e sospettosa, da parte delle commesse. Li redarguivano se si avvicinavano troppo alla merce, e guai se osavano toccarla (era forse come se in Italia portassi in giro per i reparti della Rinascente tre piccoli rom? Ma gli Yi, o i tibetani, non hanno fama di ladruncoli nel resto della Cina, e a Pechino sono praticamente sconosciuti).
Vedendoli sbeffeggiati o maltrattati senza una ragione – i tre ragazzini sono sorprendentemente cortesi, discreti e disciplinati, pur venendo da un mondo tanto diverso –, ho scoperto così, sulla loro pelle e di riflesso sulla mia, il razzismo dei cinesi Han. Molti di loro considerano le minoranze etniche geneticamente inferiori, e non fanno nulla per nasconderlo. Perfino dei carissimi amici cinesi, come la mia ex collaboratrice Zhang Yin, che pure è sempre stata generosa nell’aiutarmi in questa vicenda, ogni tanto tradiscono il loro pensiero. Per esempio, considerano inevitabile, naturale, il ritardo scolastico dei tre ragazzini, come se non fosse frutto della loro storia personale, ma di limiti congeniti.
Io stesso qualche volta ho avuto dei dubbi angosciosi: ricordo che il maschietto, Seila, quando lo conobbi, aveva uno sguardo spento, assente, ed ebbi il timore che fosse affetto da qualche problema psichico, uno sviluppo ritardato, magari legato all’Aids dei genitori. Mi sono ricreduto, per fortuna, perché negli anni seguenti l’ho visto sbocciare. Oggi Seila ha gli occhi vispi e furbi e, malgrado venga da un ambiente arretrato, la prima volta che mi ha visto in mano un iPhone ha imparato a maneggiarlo meglio di me. Quest’estate, quando ci siamo rivisti a Pechino dopo il mio trasloco a New York, siamo andati al cinema a vedere I Puffi (non un granché, però è tutto girato a Manhattan, ed è il film ideale per mostrare loro dove sono finito), e Seila si girava continuamente verso di me per controllare che capissi le battute, che ridessi anch’io. Erano fieri, quest’estate, perché per la prima volta sono venuti in aereo da soli, senza accompagnatore, con tanto di scalo e coincidenza a Chengdu. Quando li ho portati in una libreria internazionale, volevano prendersi chili di fiabe col testo a fronte, mandarino e inglese. I progressi in inglese sono lenti, stentati, perché nella loro scuola del Sichuan non ci sono insegnanti madrelingua (sono rari perfino a Pechino), però la frase che non si stancano di ripetere è «We miss you», ci manchi.
La distanza che ci separa è diventata ancora più grande, e tuttavia quei soggiorni insieme a Pechino mi hanno convinto della saggezza del professor Hou. Bisogna pensarci bene prima di strapparli alle loro radici, trapiantarli altrove. Quando provai a cercargli una scuola di qualità migliore, a Pechino, mi fu data una risposta spietata: «Qui dei bambini così verrebbero accettati solo da una scuola per handicappati». Soltanto ora, a 16 anni, Cheguo e Sanza vanno in prima media; per essere state delle figlie di nessuno quando le altre andavano alle elementari, hanno accumulato cinque anni di ritardo sulle loro coetanee cinesi. In un sistema scolastico selettivo, ipercompetitivo come quello cinese, li attenderebbero solo umiliazioni. I loro coetanei nati in famiglie benestanti a Pechino sono circondati di attenzioni da parte dei genitori, e dopo la scuola prendono lezioni private di matematica, inglese, pianoforte, arti marziali. Neppure l’avermi adottato può guarirli dal loro peccato originale: quello di essere nati nel posto sbagliato, da genitori sbagliati. È duro, per un occidentale della mia generazione e con le mie idee, vedere tre ragazzini così, avere la certezza che sono intelligenti, e dovermi rassegnare al fatto che molto probabilmente non andranno mai all’università. A 16 o a 12 anni, nella loro vita hanno già perso opportunità che non ripassano più.
Per quanto la Cina non sia tenera con loro, quando li porto in visita al nuovo Museo di storia nazionale di piazza Tienanmen li vedo gonfi di ammirazione per quell’ostentata glorificazione del progresso cinese. Anche se sono figli di un dio minore, ormai si sentono parte di quella grande nazione, e quando ci lasciamo all’aeroporto di Pechino, alla loro partenza per Xichang, non posso fare a meno di dirmi questo: a causa di Cheguo, Sanza e Seila, io ho bisogno che la Cina, oltre al progresso materiale, diventi un paese migliore, aperto e tollerante, inclusivo verso le minoranze. Gli Yi sono troppo pochi, dispersi e disperati per potersi ribellare. Ma tra altre minoranze più coese della loro – tibetani, uiguri, mongoli – le proteste sono continue, e la risposta è una dura repressione. Questa ingiustizia ora mi tocca nella carne viva; la prepotenza con cui i governanti di Pechino rispondono alle rivolte (non solo a quelle delle minoranze etniche) mi ricorda uno dei tratti peggiori del comunismo, un difetto che riconosco bene anche nel nostro album di famiglia: la certezza comunista che i leader siano i migliori interpreti dei bisogni «reali» delle masse, e che bisogna perseguire il vero interesse del popolo anche suo malgrado, anche quando il popolo sembra deciso a respingere i progetti illuminati delle avanguardie. Così il rullo compressore del progresso cinese viene imposto a tutti i diversi, e peggio per chi non ci sta.
Non arrivo però fino a condannare in blocco la modernizzazione della Repubblica popolare, come fanno certi occidentali che la osservano da lontano. Sarebbe assurdo idealizzare il passato degli Yi o dei tibetani, sognare per loro il ritorno a un’Arcadia che non è mai esistita. Mi vengono in mente le parole del premio Nobel cinese per la pace, il dissidente Liu Xiaobo, che sta scontando undici anni di carcere per le sue battaglie in difesa dei diritti umani. Liu ironizza sugli occidentali che rimpiangono una Cina povera, frugale, quasi fosse un paradiso perduto, e lo fa usando parole che mi riportano alla mente proprio il villaggio di Jiudu dove vivevano i tre bambini: «Visto da un aereo, arare con un bue ha un non so che di bucolico, ma lo spettatore, mentre si diverte, non dovrebbe dire ai contadini che devono continuare ad arare con questo mezzo primitivo per protrarre lo spettacolo all’infinito». Non so che mestieri finiranno per fare tra qualche anno Cheguo, Sanza e Seila, ma so che sarà più facile anche per loro trovare un lavoro se la Cina prosegue nel suo sviluppo. È il paradosso su cui mi fa riflettere il Dalai Lama, quando si rifiuta di condannare la grande ferrovia costruita dai cinesi per collegare Pechino a Lhasa, la capitale del suo popolo. «I cinesi opprimono l’identità culturale dei tibetani» dice il Dalai Lama «ma hanno anche liberato la mia terra dalla miseria.» Quando non hai quasi niente, il treno è meglio di quasi niente.
La prima volta che stavo per essere espulso dal Partito comunista italiano fu a causa dell’Asia, per reato di intesa col nemico. Accadde anche questo nel 1979, l’anno zero dei miei vagabondaggi globali. No, non fui colpevole di un’improvvisa deviazione maoista (era troppo tardi: Mao Zedong era già morto da tre anni, il suo fascino presso l’intellighenzia occidentale era già svanito, e perfino in Cina Deng Xiaoping lo stava silenziosamente ripudiando). No, la colpa di cui mi macchiai era il collaborazionismo con un altro nemico, quello di sempre: il grande capitale. Avevo accettato un invito della Nestlé, la multinazionale svizzera, per andare a fare una ricerca nelle sue fabbriche in Indonesia. Mi trasferii per qualche mese all’altro capo del mondo. Una breve sosta a Djakarta, poi l’immersione totale a Surabaya, a quei tempi, credetemi, una città veramente esotica, dove per intere giornate non vedevo altri bianchi, e mi pareva di essere finito in un romanzo di Joseph Conrad. L’antefatto era questo: la Nestlé si trovava seriamente nei guai, essendo diventata il bersaglio di una campagna internazionale di accuse da parte di diverse organizzazioni terzomondiste. «Nestlé kills babies», la Nestlé uccide i bambini, era lo slogan più pesante. E tutt’altro che ingiustificato.
Come altre sue concorrenti, la Nestlé stava muovendo i primi passi verso una globalizzazione ante litteram (quella parola non era ancora di uso corrente). Investiva in massicce campagne promozionali per diffondere i suoi prodotti nei paesi sottosviluppati. Tra quei prodotti spiccava il latte in polvere per i neonati, un alimento nient’affatto innocuo. La Nestlé ne promuoveva l’uso con una pubblicità sconsiderata, il cui messaggio subliminale era che i bambini sarebbero cresciuti più forti e più in fretta se le mamme avessero abbandonato l’allattamento al seno per adottare il prodotto industriale. Anche se questo non stava scritto a chiare lettere nei cartelloni pubblicitari che apparivano in Asia, in Africa e in America latina, i venditori sul campo pagati dalle multinazionali facevano pressione sulle mamme per convincerle che il latte in polvere era più «moderno». I loro figli – promettevano – sarebbero cresciuti robusti e paffuti, proprio come i bambini europei e nordamericani. Il problema è che il latte in polvere bisogna saperlo usare: occorre saper leggere le istruzioni, e tante madri dei paesi poveri erano (sono) analfabete. Per quei paesi è un prodotto caro, ma guai se si risparmia sul dosaggio: annacquandolo, i bambini sono esposti alla denutrizione. Infine, e soprattutto, bisogna scioglierlo in acqua potabile, un bene prezioso e rarissimo in tante campagne dell’emisfero Sud. Ecco perché alcune Ong umanitarie cominciarono a indagare sui pesanti costi umani di quel cambiamento di alimentazione. I neonati rischiavano davvero la morte, e di certo ne sono morti, perché quel latte in polvere finiva mescolato con acqua sporca e insalubre, non bollita prima. Un disastro umanitario provocato da un marketing dissennato. Quindi, grazie alle denunce delle Ong come Oxfam, l’immagine della Nestlé in Europa, additata all’opinione pubblica, subì un colpo duro.
Dal quartier generale svizzero di Vevey, sul lago di Losanna, qualcuno tentò di investire in una campagna non convenzionale per riabilitare il gruppo: contattarono giovani economisti di sinistra, in diversi paesi europei, proponendo che andassero a verificare sul campo l’impatto della Nestlé in alcune aree del Terzo Mondo. M’invitarono a partire per l’Indonesia in un periodo in cui, a 23 anni, facevo il pendolare tra la Bocconi e il centro studi di politica economica del Pci. Accettai di partire a patto che fossi libero di vedere chi volevo, e di scrivere quel che volevo al mio ritorno. M’incuriosiva andare a mettere il naso in quel fenomeno ancora recente, le grandi multinazionali che muovevano alla conquista dei paesi sottosviluppati (no, non si chiamavano ancora «emergenti», perché non lo erano). A Surabaya passai le mie giornate a intervistare operai, capomastri, tecnici, qualche rappresentante sindacale. Non fu facile: per via della mia pelle bianca, della mia faccia così simile a quella dei manager svizzeri, molti sospettavano che io fossi una spia dell’azienda; e sarebbe stato ancora peggio se avessi confessato a qualche operaio o sindacalista la mia appartenenza a un Partito comunista: in Indonesia, nel 1965 era andato al potere un dittatore militare, il generale Suharto, che aveva messo fuori legge il Partito comunista locale. Nelle purghe feroci seguite al golpe, i militari di Suharto uccisero 500.000 persone.
Al mio ritorno in Italia, i miei capi del Pci minacciarono provvedimenti disciplinari perché ero stato ospite della multinazionale in Indonesia; ci fu anche una protesta vigorosa del Partito comunista svizzero – di cui appresi l’esistenza in quella occasione – per la mia «frequentazione» della Nestlé.
Nel resoconto che scrissi al termine di quel soggiorno di studio a Surabaya, ero io stesso prigioniero di un dilemma: la tragica questione del latte in polvere non si poneva in Indonesia, dove le condizioni igieniche erano migliori che in Africa. In compenso, era evidente che le fabbriche della Nestlé offrivano condizioni di lavoro migliori rispetto a quelle dei capitalisti locali: salari più alti, pulizia dei reparti, orari decenti, un trattamento più umano degli operai e soprattutto delle operaie. Ero finito a contatto con una delle facce contraddittorie della globalizzazione. Non potevo negare che noi occidentali, attraverso una multinazionale come quella svizzera, stavamo esportando un nostro modello sociale (il capitalismo) più avanzato e più moderno. Il miglioramento delle condizioni di vita era indubbio, per chi aveva la fortuna di andare a lavorare in una grande impresa straniera. Rispetto allo sfruttamento dei padroni locali, insomma, i «nostri» erano il meno peggio, per almeno due ordini di ragioni: primo, perché le multinazionali occidentali ogni tanto dovevano pur rendere conto alle nostre opinioni pubbliche (vedi la campagna «Nestlé kills babies»); secondo, perché il nostro capitalismo, più avanzato, aveva scoperto dai tempi di Henry Ford che gli operai pagati meglio e formati meglio alla fine producono di più e generano maggiori profitti.
In Indonesia sono tornato solo nel 2010, al seguito di Barack Obama, che con quella visita ha reso omaggio al paese della sua infanzia. Obama ne ha approfittato per tessere gli elogi dell’Indonesia di oggi, non solo potenza economica emergente, ma la più grande nazione islamica del mondo, un modello di transizione democratica e di Stato laico e pluralista in un paese a maggioranza musulmana. «L’Indonesia è una parte di me» ha raccontato il presidente americano. «Ci arrivai nel 1967, quando mia madre sposò un uomo di qui, Lolo Soetoro. Da bambino scoprivo un mondo nuovo. Ma il popolo indonesiano mi fece sentire subito a casa.» Al presidente Susilo Bambang Yudhoyono ha detto: «Com’era diversa la mia Djakarta: i palazzi erano di pochi piani, su tutti svettava l’Hotel Indonesia, che oggi scompare tra i grattacieli». Ha ricordato un traffico già allora caotico ma fatto di betchak, i risciò locali. La madre e il patrigno vivevano a Menteng Dalam, «in una casupola con un albero di mango davanti alla porta». Di quel periodo Obama ha conservato la memoria di «corse tra le risaie a caccia di libellule, giochi con gli aquiloni, spiedini di saté comprati dagli ambulanti». E soprattutto della gente: «Gli anziani sorridenti, i bambini che fecero sentire a suo agio un piccolo straniero, i maestri che mi aprirono gli occhi su un mondo più vasto». Per la destra americana, anche quell’infanzia indonesiana è fonte di sospetti e contribuisce alla leggenda ostile sul «presidente straniero». L’essere cresciuto all’ombra dei minareti, per il 20 per cento dei suoi concittadini è una «prova» che Obama è musulmano. Per lui è il tassello di un mondo complicato, che i suoi concittadini stentano a capire e con cui l’America deve fare i conti: «Questa nazione» ha detto Obama «dove correvo nei campi tra i bufali d’acqua e le capre, oggi è una potenza nell’economia globale, con una nuova generazione tra le più “digitali” del pianeta».
Vent’anni dopo il mio primo viaggio in Estremo Oriente, nel 1999, la parola «globalizzazione» era entrata nel linguaggio corrente. Di prepotenza. Ed ebbe anche, fin dall’inizio, avversari risoluti. A Seattle, il 75° piano del grattacielo Columbia Tower offre la vista più spettacolare sulla baia di Puget Sound, le catene di montagne innevate, l’oceano Pacifico, la costa frastagliata verso Vancouver. Da lassù, il sindaco della «città color smeraldo», Paul Schell, nel 1999 pronunciò la fatidica frase: «Perché mai dovremmo avere paura di questi ragazzi?». Dalle vetrate del Columbia Tower Club, dove erano riuniti i maggiorenti della città per celebrare il vertice della World Trade Organization (Wto, ovvero Organizzazione mondiale del commercio, Omc in italiano), Schell osservava divertito i primi gruppi di manifestanti, i pittoreschi travestimenti verdi da tartaruga marina adottati da alcuni gruppi di animalisti. Il sindaco aveva deciso di proclamare Seattle «città aperta», dando ordine alla polizia di tollerare le proteste. In poco tempo i primi rivoli di contestatori si sarebbero ingrossati a dismisura, confl...