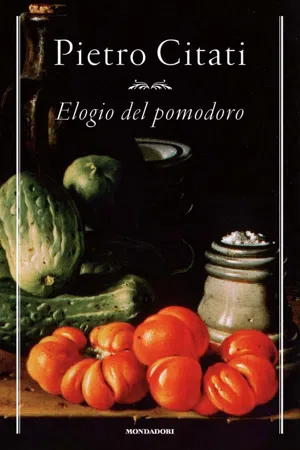
Questo libro è disponibile per la lettura fino al giorno 13º gennaio, 2026
- 276 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Disponibile fino al giorno 13 Jan |Scopri di più
Elogio del pomodoro
Informazioni su questo libro
Pietro Citati ha nostalgia dei pomodori che mangiava da bambino, durante le lunghe estati al mare. Il pomodoro era il frutto supremo di quelle vacanze, con le sue forme diverse, complicate, con le sue spaccature e screziature «e talvolta generosi aspetti barocchi, che piacevano ai pittori napoletani del diciassettesimo secolo». Il rimpianto per la propria felice infanzia ha fatto del Citati adulto un osservatore incomparabilmente acuto dei bambini tra i tre e i dieci anni. Passare il tempo con loro è per lui la cosa più divertente della vita: ama i loro pensieri vivaci e paradossali; ama guardarli mentre costruiscono castelli di sabbia e acqua, con torri e alti ponti levatoi, e poi li buttano giù, con le mani e con i piedi, senza nessuna ragione, esattamente come facevano i bambini nell'Iliade. Insieme ai pomodori e ai bambini, Citati ama i lunghi secoli della civiltà europea. Dai tempi dell'Odissea e di Erodoto - dice in questo libro in cui si combinano miracolosamente frivolezza e profondità - il volto dell'Europa non è molto cambiato. I nostri caratteri sono immutati: la pazienza, la tolleranza, l'ironia, la straordinaria capacità di trasformarci, recitare, diventare diversi, rimanendo sempre identici a noi stessi. Come pochi scrittori d'oggi, Citati conosce i miti elaborati sul nostro continente. Il più grandioso è quello della melanconia, che nasce in Grecia e si diffonde ovunque in Europa, come se fosse l'ombra dell'attiva e brillante luce occidentale: un grande nodo vibrante di contraddizioni e paradossi che minaccia di distruggerci se non lo accettiamo sino in fondo, senza incertezze e senza ritegni, sino a trarne, come hanno fatto tanti filosofi, poeti, artisti, le leggi e la salvezza del mondo. Citati non crede a tante interpretazioni moderne della società in cui viviamo. Ci parla della globalizzazione per dirci che in realtà in questi ultimi decenni è avvenuto il fenomeno opposto: il mondo è caduto preda della differenziazione, della frantumazione, della moltiplicazione. Percepisce il senso di decadimento e di vergogna oggi diffuso in Italia, ma subito osserva che il nostro è un paese pieno di eccezioni: al Nord, al Sud, al Centro c¿è sempre una piccola oasi, un paese, una cittadina polverosa di secoli, di cui uno, appena li vede, ama le strade, le case, gli orti, e persino i cittadini. A chi lamenta la morte dello spirito dei Vangeli, risponde che da secoli non esisteva nel cristianesimo un nucleo così puro e ardente come quello di oggi. Crede appassionatamente nel dono più vero dell¿Europa: quello di capire. Non gli importa, in fondo, se conosceremo la decadenza, se saremo più poveri e consumeremo di meno: è certo che la nostra civiltà continuerà a esistere fino a quando sapremo accogliere, come facciamo da ventiquattro secoli con ogni forza della mente, della fantasia, del corpo, tutte le tradizioni, tutti i miti, tutte le religioni, tutti o quasi tutti gli esseri umani.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Parte terza
VENTISETTE ANNI IN ITALIA
Il caso Calvi
Leggendo l’intelligente e divertentissimo libro che Gianfranco Piazzesi e Sandra Bonsanti hanno dedicato alla Storia di Roberto Calvi, ciascuno di noi conferma definitivamente un sospetto, che nutre da molto tempo. Chi ha inventato gli scandali italiani di questi anni – il caso Gelli, il caso Calvi, o innumerevoli altri – non è la cosiddetta «realtà», con i suoi banchieri, i suoi ladri, i suoi poliziotti e i suoi giudici, spesso così trasandati e noiosi. La realtà non bada alla perfezione letteraria delle proprie trame. Senza che nessuno di noi lo scorga o lo sospetti, è all’opera in questi anni in Italia un grande romanziere ottocentesco, che scrive con prodigiosa fecondità i suoi libri giallo-neri. Tutto lo tradisce: le perfette costruzioni romanzesche, ora chiuse ora aperte: lo stupore imprevedibile degli svolgimenti, l’inafferrabilità dei personaggi principali, l’arte raffinata con cui sono raffigurati i personaggi minori; e sopratutto la mescolanza di reale e irreale, verosimile e inverosimile, concreto e assurdo – questo minuzioso tuffarsi nell’oggettivo quotidiano per balzare a piedi uniti nel fantastico delle Mille e una notte.
Il grande romanziere sconosciuto ha un privilegio sui narratori di tutti i tempi. Come Dio, non scrive con le parole ma cogli eventi, coi corpi umani, colla materia fuggevole del tempo. Immaginate l’invidia di Dumas e di Dickens, che disponevano soltanto di cadaveri di carta: mentre il nostro artista possiede veri cadaveri, impiccati a regola d’arte, che muoiono in un determinato istante della notte, e scendono o risalgono lentamente dalle materne acque del Tamigi. Non possiamo mai sottrarci alla sensazione che tutto quanto leggiamo sui giornali sia doppio; e appartenga insieme alla realtà e alla letteratura fantastica. I milleduecento milioni di dollari sono stati truffati ad alcune migliaia di famiglie lombarde, e sono frutto di pura immaginazione: il cadavere è quello di un banchiere megalomane, losco e famigliare, che molti hanno conosciuto a Milano, ed è la copia del cadavere di Mr Merdle, che molti hanno incontrato nelle pagine di Dickens; mentre la corda dell’impiccagione, che qualcuno ha acquistato in un negozio di Londra, è uscita senza dubbio dall’Isola del tesoro. Così è perfettamente assurdo affidare la Loggia P2 all’esame del Parlamento e il delitto Calvi alle polizie inglese e italiana. Entrambi vanno recensiti dai critici letterari, esattamente come debbono venir recensiti Il conte di Montecristo e Delitto e castigo.
Non vorrei che qualcuno chiedesse al nostro romanziere sconosciuto delle doti che non possiede. Egli non ha il senso del tragico, e ignora l’atmosfera del male assoluto, che ritroviamo così spesso non solo in Balzac e Dostoevskij ma nelle storie nere inglesi e francesi. Il nostro scrittore non ha fatto che adeguarsi al suo ambiente. Spesso l’italiano non sa che cosa sia il male: lo compie e vi abita stabilmente, senza conoscerlo, senza immaginarlo e senza nemmeno lasciarsene contaminare. Taglia teste e le abbandona nelle automobili, come potrebbe tagliare meloni e cocomeri: ruba o dissipa milleduecento milioni di dollari, senza immaginare che un giorno dovrà renderne conto a qualcuno. Calvi non è mai tragico. Anche negli ultimi mesi della vita, quando viene taglieggiato da ogni parte e le sue macchinazioni stanno per ricadergli addosso, è soltanto patetico o ridicolo, come certi personaggi di farsa, che alla fine dello spettacolo vengono bastonati da tutti quanti.
La qualità che il nostro scrittore possiede in massimo grado è quel senso del casuale quotidiano, quell’imprevedibile oggettivo, che distingue tutti i romanzieri nati. Ecco tre casi. Egli doveva rappresentare tre tipi umani: «l’eminenza grigia», «il grande banchiere», «l’agente segreto». Che avrebbe fatto, se fosse stato soltanto uno scrittore di consumo? Nel primo caso, ci avrebbe descritto un uomo discreto e impassibile, gelido e ironico, lettore di Gobineau e dei classici cinesi: nel secondo, un banchiere olandese, col grosso sigaro e il boccale di birra, una collezione di giade e di miniature francesi del Quattrocento; nel terzo, avrebbe messo in scena qualche emulo di James Bond. Prendete, invece, il nostro romanziere. Con un tocco di verità impareggiabile, Licio Gelli – «l’eminenza grigia» – pare il maggiordomo di una maison de passe, che tende la mano in attesa di una mancia: Roberto Calvi – lo spirito delle combinazioni finanziarie – è un anonimo mezze-maniche, timido, terrorizzato, afflitto da complessi di persecuzione, preda di tutti i lestofanti che lo circondano; mentre «l’agente segreto» è un cialtrone che parla a voce altissima, spiffera tutti i segreti e compila classifiche di ristoranti alla moda. Un tratto di genio mi sembra l’ambiente che circonda gli ultimi giorni di Calvi. Il luogo dove il banchiere si è nascosto per partire verso la fuga e l’ignominia definitiva, non è il club elegantissimo e misterioso, o il rifugio degli abissi dickensiani di Londra – ma uno squallido residence a buon mercato, quasi senza finestre, con moquette sottili e bruciacchiate, corridoi strettissimi e bassissimi, e le immondizie abbandonate dappertutto.
Rispetto a Balzac e a Dickens, che costruiscono i loro libri attorno alla figura di un grande personaggio, il misterioso romanziere italiano capovolge le sue invenzioni. I protagonisti delle sue storie non sono i «grandi della terra», industriali, banchieri e politici: essi sono assenti, inerti, privi di intraprendenza e fantasia. I veri attori sono i mediatori, i «faccendieri», coloro che Plauto avrebbe chiamato ruffiani. Non sono mai stati così attivi, così fantasiosi, così estrosi: capaci di indossare tutte le vesti, di recitare tutte le parti, di ficcarsi in tutti i luoghi, di stringere tutte le amicizie, e di guidare dove vogliono gli ottusi politici o banchieri che hanno preso al laccio. Ecco Flavio Carboni, l’eroe del libro di Piazzesi. Questo sardo piccolo, aggraziato, educatissimo possiede mogli, amanti da ogni parte d’Europa, Rolls-Royce, bimotori e yacht e motoscafi che costano miliardi. Se deve andare da Zurigo ad Amsterdam, noleggia un aereo privato; e poi deve ricorrere agli strozzini per pagare il conto della spesa. Invita a cena editori, ambasciatori, deputati e sottosegretari; e intrattiene rapporti con i delinquenti e i lestofanti più infimi, come se il compito del ruffiano fosse quello di stringere e di coinvolgere insieme tutte le classi della società. Non c’è dubbio che il romanziere sconosciuto prediliga lui e i suoi compari. Nella loro fantasia losca e attivissima, vede un doppio della propria fantasia; e nella loro capacità di combinare intrighi la sua stessa dote di macchinare le più inverosimili combinazioni.
La fine della «storia Calvi» rimane enigmatica, e Piazzesi non prende partito. Gli ultimi giorni di Calvi sono misteriosi: non sappiamo a chi abbia telefonato a Londra, chi abbia visto, cosa sperasse, e se abbia infilato il collo nel cappio in preda alla disperazione definitiva, o se (più probabilmente) qualcuno l’abbia appeso e narcotizzato, al ponte dei Frati Neri. L’ultimo libro del romanziere misterioso è ancora da interpretare. Nessuno può assicurarci se abbia voluto scrivere un romanzo chiuso, con un suicidio che ricorda la fine di Mr Merdle: o se, invece, come i più credono, La storia di Roberto Calvi sia soltanto un episodio, una piccola pietra di quell’immenso romanzo a episodi che egli sta in questi anni scrivendo nella storia d’Italia.
1984
Il cavallo del progresso
Non posso ricordare gli ultimi anni Cinquanta senza gioia e tenerezza. Era il tempo in cui finiva la mia giovinezza e quella di Alberto Arbasino: l’Italia si scoprì fresca, vivace, mobile, senza quel torpore che l’aveva protetta e avvolta durante il fascismo. Cominciarono i viaggi – quei viaggi non vietati, ma che quasi nessuno aveva osato immaginare – verso le ultime chiese romaniche e barocche d’Italia, lungo il Reno, la Loira e il Danubio: la Grecia, l’Egitto, la Persia e via via più lontano, verso tutti i luoghi e i nomi del mondo, tutti belli e radiosi per l’immensa novità che li circondava. Si andava sempre più in là, sempre oltre, verso un luogo che nessuno aveva toccato, ma che doveva essere, senza dubbio, unico e meraviglioso. I giovani d’oggi che hanno la fortuna di avere a disposizione ogni libro e di abitare nella torre di Babele della letteratura, non possono immaginare come fu candida quella gioia di leggere, di scoprire, di avventurarsi, di fantasticare attorno ai libri e a sé stessi. Vivevamo in un’atmosfera di continua curiosità innamorata ed entusiasta, ogni giorno sull’orlo di una scoperta, certi di trovare ogni mattina un grande scrittore, che ci avrebbe rivelato i misteri dell’universo, ora Musil, ora Gadda ora Nabokov. Attendevamo. Speravamo. Forse il mondo futuro sarebbe diventato un immenso libro frusciante e sonoro, dove abitare come una parola o una sillaba o un punto interrogativo.
Intanto gli italiani scoprirono il piacere della ricchezza. Non ascoltarono chi raccontava loro che la virtù più sublime era quella di restare poveri: di vivere in immensi casamenti popolari, di mangiare in tetre cucine, di vestire divise, di chiudersi in casa, la sera, davanti alla radio. Furono avventurosi, ingegnosi, inventivi, quasi geniali. Certo, in quegli anni, furono commessi delitti: il volto di alcune città venne distrutto, la bellezza di una riviera di ulivi, pini e garofani fu cancellata da ignobili palazzi per villeggiatura. Molto venne fatto in fretta, con furia, con cecità e incompetenza. Ma di quel periodo ricordo con gratitudine almeno il dono di diventare ricchi. Quando penso alla rapidità con cui vennero fatte certe fortune, all’immensa cupidigia di denaro, al piacere fisico di guadagnare e di possedere, tutti quegli anni mi sembrano un grande spettacolo inscenato da bambini per altri bambini. Quale piacere sensuale, quale divertimento fantastico suscitava il denaro! Non era ancora entrato nelle casseforti, che accendeva il cervello e l’immaginazione, ed era, non posso dire speso, ma trasformato in piaceri leggeri come sogni. Nasceva dalla gioia, dava gioia, irradiava felicità su chi lo possedeva e su chi non lo possedeva. Il mondo sembrava lì lì per lievitare, fuggire, cambiare natura, trasformarsi in uno spettacolo di nubi e di luci.
Non durò. Non poteva durare. Il sogno dell’avida e gioiosa ricchezza generò, secondo un fatale capovolgimento, il sogno dell’angoscia, della desolazione, dell’ideologia, della miseria, della violenza, del terrore politico. Ora anche questo periodo è finito. Ne siamo usciti da qualche tempo. Gli italiani non sentono più la ricchezza come una colpa.
Alla fine di ogni anno, le grandi industrie private annunciano i loro bilanci: hanno investito diecimila miliardi, ne hanno guadagnati tremila, il prossimo anno guadagneranno e investiranno di più, e così via, in un’ascesa che non avrà fine. Non sono un nemico della ricchezza, e non vedo nulla di male nell’orgoglio dell’ingegner Romiti di aver portato i suoi bilanci in attivo. È il suo obbligo: non deve averne altri; non ci sono imprenditori più intollerabili di quelli divorati dal senso di colpa. Ma c’è nella musica delle sue parole qualcosa che mi preoccupa. L’idea che la società occidentale sia destinata a un indefinito progresso di arricchimento: che la linea della storia sia una freccia, indirizzata verso l’alto; che a tutti gli uomini debba appartenere in sorte una felicità sempre maggiore.
Nella storia non ho mai visto delle frecce vertiginose, o un progresso qualsiasi: piuttosto delle spirali, delle linee curve fittamente intrecciate, una curva che diventa una retta e poi si spezza, un passo avanti e due indietro, un eterno zigzag, un andare ora a destra ora a sinistra. Non credo che l’uomo politico e l’industriale debbano salire sopra il cavallo del progresso. Se corre troppo svelto, non bisogna lavorare di sproni: ma frenarlo, prendere una strada sassosa e piena di curve, fermarlo a una fontana per farlo abbeverare, mostrargli panorami capaci di affascinarlo e di fargli capire che non vale la pena di correre. La sapienza dell’uomo pubblico è quella di raffreddare la temperatura della società, di moderare il movimento, di deviare le speranze, per impedire che il surriscaldamento provochi disastri. In tutti i programmi illuministici di un progresso indefinito, mi terrorizza la sfida agli dèi, o addirittura il sogno di sostituire gli dèi. Ora qualche volta agli dèi amano essere temuti, qualche volta venerati, qualche volta dimenticati: ma non tollerano di essere sfidati dagli uomini. Se vengono sfidati, ci accecano, e così lasciano a noi stessi il compito di vendicarli.
L’avidità di guadagnare è una bramosità essenzialmente fantastica, che uccide tutti gli altri desideri e fantasie, e si concentra nel desiderio dell’oro. Allora l’oro diventa l’unico sogno di una vita. Chi insegue il denaro è il più romanzesco cavaliere d’avventure, il Parsifal inesausto, l’Astolfo incessante, l’Orlando delirante: l’oro è insieme una parte di lui stesso e qualcosa di perennemente remoto, qualcosa che non verrà mai raggiunto, per quanto se ne accumuli nei forzieri. Se guardiamo in viso i grandi accumulatori di ricchezza, come li hanno raccontati Balzac e Dickens, ci sorprende la febbre dei loro sguardi, la tensione delle loro speranze, il tremore delle loro bocche: qualcosa ci ricorda il volto dei poeti ispirati. Guadagnare denari è, per loro, come possedere un altro senso, più avido del gusto, più prensile del tatto, acuto come la vista, sottile come l’udito: è avere un’altra mano con cui toccare, tastare, sentire il mondo creato. Trent’anni dopo di loro, tutto è mutato: i figli, i nipoti, i bisnonni non hanno più nulla dei padri e degli avi, e assomigliano a personaggi di James. Quando è diventato un’abitudine e un’aura quotidiana, il denaro fa nascere un sangue più lento, una sensibilità più sottile, una duttilità e una malleabilità psicologica più ramificante, una distanza segreta dalle cose, un’estenuazione che si compiace delle ombre e degli indugi.
Con dolore e rimpianto, oggi non incontriamo quasi più dei ricchi divertenti e affascinanti. I ricchi di oggi non hanno né la bramosia e il delirio dei primi costruttori delle fortune, né la delicatezza misteriosa degli eredi, né la fantastica euforia degli anni Cinquanta. Una volta, la ricchezza rendeva più sottile la vita, oggi la rende più semplice: una volta creava psicologie stravaganti e anormali, oggi fa diventare simili alla norma. Avvolti dalla loro nube di assegni e di azioni e obbligazioni e di case, i ricchi sono diventati banali, come se il denaro ottundesse, invece che complicare le sensazioni. Nessun Balzac o James amerebbe raccontare la vita di uno di loro, nel 1986. Hanno sempre amato l’apparenza. Ma, una volta, la loro apparenza era il segreto delle grandi ville e delle ombre e delle amicizie ristrette. Oggi si direbbe che amino il denaro solo perché permette loro di partecipare allo spettacolo della televisione e dei rotocalchi, nel quale, per molti, si è concentrata la vita. Hanno perduto qualsiasi alone mitico, qualsiasi fascino, qualsiasi attrazione. Come si incarna in loro, il denaro non ha più risonanza. Non è altro che una somma scritta sopra un assegno.
La società nella quale viviamo ha questo privilegio e questa debolezza di fronte a tutte le società che l’hanno preceduta nella storia: non produce valori. Mentre la società aristocratica e quella borghese si sostenevano sopratutto grazie a una fittissima rete di idee sulla vita e la morte, sull’amore e la fede, di sentimenti, di sensazioni e di complicità psicologiche, la moderna società di massa è silenziosa. Offre ai suoi membri soltanto la possibilità di conquistare quello che vogliono. Ognuno deve creare dal nulla la propria vita: la propria religione, la propria etica, la propria psicologia, la propria arte. Questo vastissimo arco di possibilità ci attrae e ci incanta. Ma è la debolezza della società moderna. Gli uomini temono una libertà così vuota. Vorrebbero essere amati, educati, corretti, puniti, compresi in una grande architettura umana. Quando sono completamente liberi, non sanno che fare: cominciano a non amare più sé stessi e il proprio lavoro: si lasciano andare alle speranze vaghe, ai sogni a occhi aperti, alle rosee e sinistre fantasticherie, alle farneticazioni; vorrebbero essere diversi, possedere qualità che non hanno, o doni che non potrebbero mai appartenere loro. Non l’ingiustizia sociale, o i mille errori della vita quotidiana, ma l’immensa noia, che fermenta in ogni angolo dell’Occidente, è il vero pericolo per il cosiddetto «ordine costituito». Questa folta e indifferente massa di fantasticherie è la base odierna, come lo fu già nel 1968, di qualsiasi protesta o rivoluzione.
Sebbene abbia affrontato sfide e contestazioni, la nostra società – quella italiana, forse tutta la società occidentale – è fragile. Ogni tempesta o soffio di vento può farla vacillare e cadere. La sfida agli dèi promette soltanto disastri. La classe dirigente non offre garanzia di durata. I ricchi sono noiosi, e presto le loro vicende finiranno di incantare la fantasia dell’immensa piccola borghesia ancora soggiogata ai loro piedi. La società di massa è un congegno delicato e complicatissimo. Per ora, i vecchi professionisti della rivoluzione sembrano dei tenori sfiatati: passano il loro tempo a interrogarsi, a pentirsi, a dimostrare che, anche quando sbagliavano, erano più intelligenti di tutti. Ma la noia, col suo seguito di fantasticherie, serpeggia nell’atmosfera, come un gas ancora inavvertito. Non so far profezie. Forse basterà che qualcuno – più astuto e più candido – getti un fiammifero per le strade; e di nuovo le mani si leveranno a frantumare e a distruggere quello che altri hanno costruito.
1986
La corruzione
Come molti, credo che la degradazione della classe dirigente italiana sia arrivata all’estremo. Era e resta intimamente corrotta la classe politica; e una parte degli imprenditori. Sono corrotti molti magistrati, che indagano sulla corruzione, perché sono ossessionati dal desiderio di potere. Ma l’ombra non ha lasciato quasi nulla intatto. Persino le vittime sono corrotte, perché l’ombra macchia anche coloro che percepiscono pensioni non meritate, false indennità di disoccupazione, invalidità fraudolente, uno dei mille favori che la classe dirigente ha diffuso. Ciò che colpisce è il candore dei corrotti. Quando qualcuno di loro viene interrogato, spesso ha un timoroso sorriso di innocenza: «Tutti fanno così». Questo candore, che per certi aspetti riempie di strazio, rivela fino a che punto la corruzione sia diventata normale e naturale.
Un mio amico russo sostiene che la corruzione è benefica. Essa, egli dice, moltiplica la ricchezza, favorisce i poveri, lubrifica e rende gioiosi i meccanismi dello Stato. «Non Le porto ad esempio il mio infelice paese. Da noi la corruzione è sempre stata burocratica e triste. Ma pensi alla Cina del diciassettesimo e del diciottesimo secolo, quando l’intero paese, dal basso fino ai vertici dell’impero, era mosso dalla corruzione; e da questo squisito marciume nascevano una grandiosa amministrazione, una sapiente diplomazia, stupende ceramiche e paraventi e disegni di fantastici paesaggi montuosi e la Città proibita e un capolavoro della letteratura come Il sogno della camera rossa, tutto profumato di cielo, di giovani donne e di Tao.» Il mio amico aggiunse che noi italiani eravamo gli eredi dei cinesi, e mi guardava con ammirazione. Non ebbi la forza di disilluderlo. Non gli dissi che, mentre la corruzione cinese aveva generato l’imperatore K’ang-hsi – il quale riceveva nel suo palazzo d’estate i padri gesuiti che lasciavano ai suoi piedi i bei volumi rilegati d’Europa, gli orologi, le carte geografiche, gli astrolabi, i cannocchiali, i mappamondi e la saggezza di Seneca –, la corruzione italiana non aveva prodotto nulla più squisito di Paolo Cirino Pomicino.
Credo che le ragioni della degradazione italiana siano molto più profonde della corruzione politica. Soltanto da quindici o venti anni, si è stabilmente affermata, in Italia, la società di massa. La civiltà borghese è scomparsa, e ne è rimasta una vaga ombra crepuscolare. La civiltà borghese era il luogo delle leggi, dei padri, delle istituzioni, della famiglia: ognuno sapeva ciò che doveva fare; aveva la strada segnata, davanti a sé, da una serie di ammonimenti e di divieti, trasformati in voci interiori. Con la società di massa, tutte le leggi sono morte; e sopratutto quella del Padre. I valori e le uniformità di massa, che ci colpiscono tanto, sono illusori: non acquistano nessun valore interiore, e cambiano e si trasformano a ogni soffio di vento. La società offre a ciascuno libertà e possibilità illimitate: tutto il mondo è aperto davanti a lui, che deve soltanto possederlo. Ma l’individuo è solo: disegna da sé la propria legge, la propria strada, il proprio cosmo; e niente è più arduo che vivere così, nel deserto, estraendo tutto dalla propria mente e dal proprio cuore. Solo pochi hanno la forza di resistere a questa tensione.
Nessun...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Elogio del pomodoro
- Parte prima. BAMBINI E MARE
- Parte seconda. L’EUROPA
- Parte terza. VENTISETTE ANNI IN ITALIA
- Parte quarta. IL CRISTIANESIMO OGGI
- Parte quinta. PICCOLI E GRANDI VIAGGI
- Dello stesso autore
- Copyright
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Elogio del pomodoro di Pietro Citati in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Cultura e tradizioni. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.