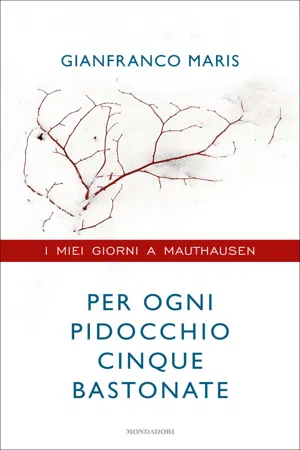![]()
Arrivai a Milano nei primi giorni di novembre del 1943 e andai subito in corso di Porta Nuova, dove sapevo che avrei potuto incontrare Salvatore Di Benedetto. La casa che cercavo era, apparentemente, l’abitazione di un nostro amico e compagno, Angelo Impiduglia ma, di fatto, era sempre stata la sede clandestina del Partito comunista italiano. Da quella casa erano passati Elio Vittorini, Renato Guttuso, Mario Alicata, Pompeo Colajanni, Pietro Ingrao, Ernesto Treccani, Gillo Pontecorvo, Celeste Negarville, Giancarlo Pajetta, Giansiro Ferrata...
Con tutti costoro, negli anni dal 1937 fino all’inizio della guerra, avevo condiviso sentimenti, sogni, impegno, attese e speranze. Poi, dal 1941 al 1943, io ero stato lontano, al fronte. Ora tornavo per riprendere una storia interrotta. Avevo saputo della grande manifestazione che Salvatore Di Benedetto aveva organizzato alla caduta del fascismo il 25 luglio, con Pietro Ingrao. Avevo saputo che era stato arrestato insieme a Vittorini e Ferrata. Sapevo che Di Benedetto stava ora organizzando la Resistenza in Lombardia e che era in contatto diretto con Luigi Longo. Lo cercai proprio perché volevo trovare la strada per la lotta nella Resistenza e volevo ritornare in contatto con Vittorio Bardini.
Vittorio Bardini, esponente di spicco del Pci, aveva combattuto in Spagna nelle Brigate Internazionali ed era stato a lungo in Russia, a Mosca, per svolgere attività per conto del partito. In quel novembre 1943 a Milano operava per la costituzione, l’addestramento e l’armamento delle brigate partigiane.
Ci incontrammo presto e nel corso di lunghissime camminate ragionammo su tutto quello che avrei potuto fare io nella Resistenza, tenendo conto anche delle mie esperienze di guerra e della mia appartenenza al Pci dal 1938 al 1940, prima della partenza per la Slovenia. Bardini mi affidò l’incarico di cercare zone idonee per l’insediamento delle brigate, valutando pregi e inconvenienti di ogni luogo e la possibilità di utilizzare rifugi di alta montagna, raggiungibili soltanto con percorsi di tratturi e piste sterrate, al di sopra delle strade di grande comunicazione. Era importante anche la possibilità di un rapido collegamento con Milano.
Iniziai con un giro nelle valli del lago di Como e del Lago Maggiore, soprattutto nella Val Cannobina. Ma, almeno in quell’inizio di novembre, mentre era facile l’individuazione di località logisticamente adatte, era difficile trovare e spostare uomini e armi. Non potevano bastare, infatti, quelli che erano già essi stessi abitanti delle valli e dei borghi di montagna: dovevamo mobilitare anche i giovani delle grandi città.
L’8 settembre aveva sicuramente acceso una spontanea rivolta popolare, soprattutto nelle metropoli, ma questa rivolta non aveva trovato l’appoggio dei comandi di corpo d’armata dell’esercito. Era quindi difficile reperire le armi. E così, una vera e diffusa rivolta stentava a partire. Inoltre, i tedeschi avevano reagito subito con grande violenza e crudeltà ai primi empiti di ribellione spontanea popolare dopo il loro arrivo e la loro occupazione. Ma in questo fuoco patriottico, nel largo spontaneismo di questa insurrezione, nulla era stato possibile costruire come solida organizzazione di lotta contro il nemico occupante del paese.
Già all’alba del 9 settembre 1943 scendeva dalla Germania e invadeva Verona la famosa Leibstandarte SS Adolf Hitler, una divisione corazzata che in tutta Europa aveva insegnato come massacrare e far tacere ogni anelito di libertà dei popoli e dei paesi occupati. Solo dieci giorni dopo l’arrivo a Verona, questa divisione aveva mandato i suoi uomini a bruciare i villaggi in provincia di Cuneo, ad assassinare i vecchi, i bambini, le donne, a stanare e uccidere gli ebrei che si erano rifugiati negli alberghi del Lago Maggiore.
Io, comunque, continuavo a girare alla ricerca di luoghi e uomini. Giravo con un documento falso. Una carta di identità intestata a un inesistente Gianfranco Lanati, nato a Caserta nel 1916. Era stato uno dei nostri, che si chiamava Calogero Marrone ed era capo dell’ufficio anagrafe del Comune di Varese, a darmi quel documento. Mi aveva fatto nascere a Caserta perché in quella città i nazisti non avrebbero potuto chiedere informazioni su di me e mi aveva invecchiato di cinque anni – 1916 anziché 1921 – per mettermi al sicuro dagli obblighi militari.
Marrone mi era stato indicato da Salvatore Di Benedetto, ma il tramite, quello che mi presentò direttamente a lui, fu Alfonso Montuoro, un siciliano della zona di Agrigento, come Di Benedetto e come lo stesso Marrone. Montuoro l’avrei ritrovato tempo dopo nel campo di prigionia di Fossoli e poi a Mauthausen. Dove lui, purtroppo, morì. Era stato lui, Montuoro, ad accompagnarmi nel municipio del Comune a Varese e a farmi incontrare Marrone, il quale aveva poi incaricato uno dei suoi collaboratori di fornirmi la carta di identità, passandogli un biglietto dove erano indicate le mie false generalità.
Anche Calogero Marrone pagò con la vita la sua attività nella Resistenza. Arrestato il 9 ottobre 1944, fu deportato a Dachau e poi nel campo di Linz a Mauthausen, dove morì il 15 febbraio 1945, poche settimane prima della liberazione.
Nel dicembre 1943 il mio itinerario di ricerche si fermò in Val Taleggio, una piccola valle laterale della Val Brembana, nella Bergamasca. Poi, negli ultimi giorni del gennaio 1944, il comando militare partigiano di Milano dispose che io mi trasferissi in Valtellina, per raggiungere un più consistente gruppo di partigiani. Doveva accompagnarmi nel viaggio Abele Saba, un pittore che faceva da intermediario tra me e il comando militare partigiano di Milano. L’incontro con Saba era previsto a Lecco.
Nella notte scesi dalla Val Taleggio a Milano e all’alba presi un treno per Lecco. Salito sul convoglio, sistemai alcuni pacchi, nei quali erano nascoste le armi, nel portabagagli di una carrozza; dopo di che andai a sistemarmi in un carro bestiame. Arrivato a Lecco, lasciai uscire tutti i passeggeri dal treno prima di recuperare i pacchi dalla carrozza in cui li avevo sistemati. Poi, quando fui certo che i controlli al binario erano finiti, mi avviai verso l’uscita, seguendo da lontano il cammino di Abele Saba.
Una cinquantina di metri fuori dalla stazione, improvvisamente io e Saba, che ci eravamo avvicinati, fummo circondati da SS in divisa e armate di mitra. Nel terrore generale suscitato in tutti i cittadini presenti in quel momento intorno a noi, e anche nel terrore mio, fui bloccato e caricato su un’automobile. Come avevano potuto scoprirci? Chi ci aveva tradito? Furono queste le prime domande che mi ponevo mentre mi allontanavo in auto, prigioniero delle SS. Non vedevo più Saba e per molti giorni non avrei più saputo dov’era finito.
Sicuramente io non ero stato seguito da nessuno. E a nessuno, proprio a nessuno, io avevo mai detto che dalla Val Taleggio sarei arrivato a Milano e che da Milano sarei partito per Lecco. Nessuno era informato sui miei movimenti.
Dopo un breve percorso sull’auto, fui portato in un edificio che non riconobbi, nel senso che non capivo se era una caserma, una prefettura o una questura o una sede di partito: so solo che, superato l’ingresso e attraversato un cortile, trovai la porta di una cella nella quale fui infilato. Nella cella c’era un lungo bancone di legno e nient’altro.
Le SS scomparvero ma, evidentemente, quella cella era nella disponibilità delle milizie fasciste della Repubblica sociale italiana perché, per lunghe ore, furono fascisti i personaggi con cui entrai in contatto. Non mi interrogavano, ma si mostravano aggressivi.
Non mi avevano perquisito. Strano, ma non mi avevano perquisito. Appena fui solo in cella, mi svuotai le tasche e mi mangiai tutti i pezzetti di carta sui quali avevo scritto o annotato qualcosa. Staccai e mangiai pure l’etichetta della mia giacca, una mia vecchia giacca, perché non volevo che vedessero il nome del sarto che l’aveva confezionata. Avrebbero potuto capire che ero di Milano. E io ero, dovevo essere, Gianfranco Lanati di Caserta.
Non avevo ancora finito di inghiottire quegli strani bocconi che la porta della cella si aprì. Quattro o cinque energumeni si precipitarono su di me e senza pronunciare una sola parola cominciarono a colpirmi con pugni e calci. Poi uscirono.
Passò poco tempo e la porta della cella si riaprì. Entrarono alcuni di questi fascisti, armati, mi afferrarono e mi trascinarono sulla porta, così vidi che nel cortile, a ridosso dell’entrata della cella, erano arrivati alcuni ragazzi. Erano poco più che bambini, dieci o dodici anni, forse i loro figli, e cominciarono a sputarmi addosso. Ogni sputo che mi raggiungeva veniva «pulito» da un manrovescio dei fascisti.
Fui rimesso in cella. Mi chiedevo chi potessero essere, a quale milizia potessero appartenere questi uomini ai quali ero stato affidato dalle SS in custodia temporanea. Erano, peraltro, strani custodi. Violenti, ma rispettosi di alcuni diritti elementari, come il cibo. Verso l’una mi portarono un piatto di riso.
Non avevo fame, non mi scendeva nella gola neppure un chicco. Ma non volevo che i generosi guardiani che mi avevano portato da mangiare pensassero che il mio digiuno fosse motivato dalla paura. Per cui cercai tutti gli spazi possibili e immaginabili fra il lungo bancone di legno e il muro, e pazientemente vi infilai, un chicco per volta, tutto il riso che mi avevano portato. Così facendo, i carcerieri avrebbero pensato che avevo mangiato tutto.
Nel tardo pomeriggio di quel mio primo giorno di detenzione venni di nuovo prelevato dalla cella e portato al secondo piano del palazzo: una grande sala, credo fosse l’ufficio prestigioso di qualche personaggio autorevole. Forse un podestà o un prefetto o un preside di provincia. Nella sala fui lasciato solo con il comandante del reparto delle SS. Ai miei piedi erano stati collocati i pacchi che avevo con me al momento della cattura. «Aprite quei pacchi!» mi ordinò il comandante. Io li aprii. «Mettete tutto su quel tavolo!» Misi tutto sul tavolo. Nei pacchi c’erano le armi. E il comandante delle SS già lo sapeva.
Mentre scartavo i pacchi accompagnava ogni mio gesto con uno sguardo che diventava sempre più feroce e quando spuntarono le armi mi si avventò contro prendendomi a pugni. Non mi parve che volesse farmi veramente male: era una scarica di cazzotti più che altro dimostrativa di odio. Poi, freddissimo, mi fissò negli occhi e in un italiano molto stentato mi disse che sarei stato fucilato.
Ma questo mi era già chiaro fin dal primo momento della mia cattura. Sarei stato fucilato, indipendentemente da ciò che le SS avrebbero potuto sapere, o immaginare, sulla mia attività e sui miei progetti. Sarei stato fucilato per il solo fatto che portavo con me armi.
Questa consapevolezza informò il mio comportamento nei rapporti con le SS in tutti i novanta giorni durante i quali mi tennero nelle loro mani e in tutti gli interrogatori ai quali mi sottoposero. Questa consapevolezza mi imponeva dignità e fermezza, anche se una vaga angoscia mi accompagnava nel giorno e nella notte, costantemente. Avevo fatto la guerra, avevo fatto il partigiano ma non riuscivo a rimuovere questa angoscia. Avrei voluto poterne parlare con qualcuno, anche solo per affidargli il mio nome e chiedergli di raccontare un giorno a mia madre dove ero stato fucilato e perché.
Arrivai a chiedere alle SS di potermi confessare con il prete del carcere, ma le SS non me lo consentirono, intuendo che a ispirare la mia richiesta non era la fede, ma la volontà di trovare un confidente che non mi tradisse. Il comandante chiamò le SS del suo gruppo. Ormai ero tornato nelle mani dei tedeschi. Mi caricarono su una macchina e mi trasferirono a Bergamo, in una prigione improvvisata nella cantina di una villa, dove iniziarono per me gli interrogatori notturni. Fui interrogato per undici notti.
Gli ufficiali dell’Aussen Kommando della Gestapo di Bergamo sembravano manichini apprestati per una sfilata di modelli della sartoria militare del Reich. Stivali lucidi, divise ben tagliate e ben stirate, portamento fiero e severo. Così il capitano che comandava il reparto, così l’interprete.
Il primo era un tedesco che non sapeva neppure mezza parola di italiano. Il secondo parlava un italiano perfetto, senza accento che non fosse quello di un colto cittadino italiano del Nord.
L’interprete si chiamava Strumengher. Già sapevo, prima della cattura, che nel comando della Gestapo delle SS c’era questo Strumengher, membro di una famiglia che da moltissimi anni viveva a Bergamo. Raccontavano che aveva un fratello con la fama di essere un uomo aperto alla solidarietà, un cattolico.
L’interprete Strumengher, non conducendo gli interrogatori, non uscì mai da un ruolo estremamente formale, piatto, direi quasi professionale: traduceva senza inflessioni, senza accanirsi, senza mai ingiuriare. Forse si preoccupava più di accreditare un proprio stile che di apparire come un collaboratore delle SS.
Nel corso di uno degli interrogatori terminò la traduzione che stava dettando rivolgendosi a me, per sottolineare che a lui non sfuggiva certamente né l’ambiguità né la falsità delle cose che stavo raccontando. Disse: «Vi conosco io, voi napoletani». Evidentemente faceva riferimento alla mia carta di identità, che collocava a Caserta la mia nascita. La cosa finì lì e io mi domandavo quale frequentazione potesse mai avere avuto questo interprete con i napoletani, se non riusciva a riconoscere la diversità della mia parlata, che era chiaramente quella di un italiano del Nord. Ma poco dopo, la notte stessa, accadde un fatto strano. Io venni riconsegnato ai fascisti, che mi chiusero in una cantina trasformata in una prigione, con più celle. A un certo punto della notte sentii una mano battere molto adagio alla porta della mia cella, che aveva uno spioncino. Mi avvicinai e vidi un milite in divisa fascista che mi chiamava e mi parlava in napoletano: «Paisà...». Continuava a parlare in dialetto e mi offriva una sigaretta.
Fratello mio, pensai, se apro bocca soltanto Strumengher può pensare che io sia un napoletano: ma poiché tu lo sei sul serio, se io apro bocca tu capisci subito che io a Napoli non ci sono mai stato.
Ebbi subito un dubbio: che si trattasse di un trucco architettato per smascherarmi, per vedere se davvero ero di Caserta? E allora ricorsi anch’io a un espediente. Invece di rispondere, mi limitai a mugugnare, a emettere un suono più che delle parole, come se non fossi in grado di parlare a causa delle botte che avevo preso, e conciato lo ero davvero, per cui il mio trucco poteva funzionare. Chi mi vedeva, aveva davanti una specie di ecce homo e poteva anche credere che non fossi effettivamente in condizione di esprimermi.
Ancora oggi sono nel dubbio. Era un vero napoletano che tentava, commosso, di fare una carezza a un proprio concittadino straziato dalle botte dei tedeschi, oppure era un perfido strumento di spionaggio? A distanza di tanti anni, voglio fortemente credere di essermi sbagliato. Voglio fortemente credere che in quell’inferno ci fosse spazio per un gesto di umanità e che, davvero, quel milite fascista cercasse solo un contatto umano. Voglio fortemente credere di avere simulato inutilmente l’incapacità di parlare, e di avere così soltanto deluso un uomo buono.
Dopo tre giorni trascorsi nella cantina di quella villa, fui affidato, perché mi custodissero, a un reparto fascista, lo stesso che mi aveva tenuto il giorno della cattura. Era il reparto della Guardia nazionale repubblicana (Gnr) di Bergamo, comandato da un certo Aldo Resmini. Mentre ero in custodia presso di loro, fui sottoposto ad altre otto notti di interrogatori, sempre da parte delle SS, in un’altra cantina, quella di un enorme edificio in una piazza di Bergamo vicino al tribunale.
In questa cantina erano state allestite alcune celle, con diversi banconi di legno per il sonno dei prigionieri. Fu una detenzione molto strana. Di giorno, nella mia cella, arrivavano solo uomini di questa banda Resmini, che mi picchiavano, urlando, ma senza mai interrogarmi, perché io non ero stato arrestato da loro, non ero un loro prigioniero, ma gli ero stato soltanto affidato in custodia dalle SS che, di notte, arrivavano e mi interrogavano. Naturalmente, picchiandomi pure loro.
Ma a godere del trattamento della banda Resmini non ero evidentemente il solo. Di giorno e soprattutto di notte, sentivo le urla e i lamenti che giungevano dalle altre celle e dalla stanza in cui i fascisti tenevano gli interrogatori dei propri prigionieri.
Una notte, dopo il mio interrogatorio da parte delle SS, gli uomini della banda Resmini fecero entrare nella mia cella un giovane massacrato di botte. Lo buttarono sul bancone accanto a me. Mi sembrò in stato comatoso. Feci ciò che chiunque avrebbe tentato di fare, anche se era evidente che non sarebbe servito a nulla: cercai di bagnare con la poca acqua che avevo un fazzoletto e gli inumidii le labbra, poi cercai di pulirgli gli occhi. Rantolando, mi disse che era uno svizzero: di più non riuscii a capire. Era un giovane alto, robusto, biondo.
Mentre cercavo di assisterlo per quanto potevo, si aprì nuovamente la cella ed entrò un gruppo numeroso di fascisti della banda Resmini, che ricominciar...