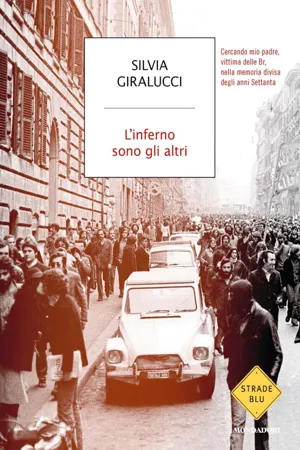![]()
Non saprei dire quando ho conosciuto Pietro Calogero. Il suo nome ha radici nei miei ricordi di bambina, nelle informazioni scambiate sottovoce tra mia madre e mio nonno, quando si aggiornavano sugli sviluppi dell’indagine per la morte di papà. Non capivo quasi nulla, ma ascoltavo. Quel nome l’ho ritrovato più tardi nei titoli delle pagine di giornale strappate e riposte in una scatola di legno verde nel cassettone della camera di mia madre. Un archivio che lei pensava segreto e dove io, segretamente, cercavo papà.
Calogero, per me, è il magistrato che ha tenacemente perseguito – con successo – l’obiettivo che per l’omicidio di papà e di Giuseppe Mazzola fossero condannati per concorso morale anche i capi storici delle Brigate rosse: Renato Curcio, Mario Moretti e Alberto Franceschini.
Per una parte dell’opinione pubblica, invece, è soprattutto il «Kalogero» delle scritte sui muri, l’autore del teorema Autonomia = Br, il magistrato che accusò Toni Negri di essere il capo delle Brigate rosse, e che con gli arresti del 7 aprile 1979 «criminalizzò il Movimento», spingendo diversi giovani verso la lotta armata.
Pietro Calogero ha l’aria svagata di un tenente Colombo. Dalla madre, di origine vietnamita, ha preso l’occhio leggermente allungato; dal padre, maestro elementare del paesino in cui è cresciuto, Pace del Mele, in provincia di Messina, un’algida compostezza. È una persona schiva, quasi timida. Lo si nota nella fatica che fa a guardare negli occhi l’interlocutore, e nella frequenza con cui si schiarisce la voce e si copre la bocca con la mano. Nonostante i trent’anni di vita nel Veneto, nella parlata rimane il siciliano della sua infanzia. Non è decisamente un magistrato «tecnologico»: nel suo studio non ha un computer, non usa la posta elettronica, legge quando capita gli sms del telefonino.
«Quando l’ho incontrato la prima volta» mi ha confessato Antonio Romito, l’ex militante di Potere operaio che, con la sua testimonianza, consentì a Calogero di comprendere dall’interno i meccanismi di funzionamento del gruppo di Toni Negri, «mi sono chiesto dove poteva andare uno così.» Trent’anni dopo, seduta al ristorante con lui per parlare del mio progetto sul 7 aprile, ho avuto anch’io – lo ammetto – lo stesso pensiero. Forse perché Calogero è sempre gentile, ma non fa nulla per compiacere l’interlocutore. La sua forza è tutta nella testa. Proverbiali erano i suoi interrogatori: sempre cortese con gli imputati, ma con un rigore che non conosceva soste o tentennamenti. «Mi ricordo quando andavamo a portargli i volantini degli autonomi» mi ha raccontato un amico che negli anni Settanta era un funzionario del Pci. «Li leggeva con estrema attenzione dalla prima all’ultima parola, pareva li scannerizzasse.» E forse era proprio così, perché anche oggi, quando parla degli anni Settanta, procede snocciolando date, nomi, citazioni da documenti come se stesse leggendo un testo scritto. Non è facile seguire il filo del suo pensiero, e mi chiedo quanto la sua scarsa attitudine alla comunicazione abbia contribuito a creare tante incomprensioni mediatiche sul caso «7 aprile».
Pur avendo alle spalle la mia storia, ho faticato non poco a guadagnarmi la sua fiducia. L’ho ottenuta offrendomi di aiutarlo a scrivere le sue memorie. Ho passato molte ore nel suo studio, raccogliendo puntigliosi racconti ricchissimi di nomi, date, dettagli. Mi ha aperto l’armadio dove conserva le sentenze, le requisitorie, e una piccola biblioteca sul terrorismo. Mi ha consegnato i suoi appunti. Ho trascorso interi pomeriggi ad ascoltarlo. In vent’anni di giornalismo non ho mai trovato un testimone che, pur non essendo reticente o ostile, è stato tanto restio a rispondere direttamente alle mie domande.
Quando lo incontro ha 69 anni. Dopo aver fatto parte del Consiglio superiore della magistratura, è tornato a Padova come capo della procura. Avrebbe l’età per la pensione, ma il voto unanime dei suoi colleghi per la nomina a procuratore generale della Corte d’appello di Venezia – arrivato proprio durante i nostri incontri – è per lui il coronamento di una carriera. È circondato da una fama di magistrato tenace e meticolosissimo, di rara onestà. Da quando lavora sulla laguna, potrebbe andare a Venezia con l’auto blu, ma preferisce prendere ogni giorno un treno regionale assieme ai ragazzi che vanno all’università.
Calogero arriva nel Veneto dalla provincia di Messina nel 1969, vincitore dello stesso concorso che portò in magistratura anche Emilio Alessandrini. Si mette subito in luce per l’inchiesta che portò alla scoperta della «pista nera» nella strage di piazza Fontana. Il magistrato, oggi ricordato come un nemico del Movimento, fu il primo in Italia a indagare sulla destra eversiva come autrice delle stragi del 1969, il primo a scontrarsi con uno Stato che faceva sistematicamente ostruzionismo alle indagini che andavano in quella direzione.
La vigilia di Natale del 1969 Calogero, ventinovenne magistrato di prima nomina a Treviso, è di turno – solo – in procura. Del tutto inatteso si presenta un avvocato, tale Alberto Steccanella, che gli annuncia di essere lì per riferire alcune dichiarazioni di un cliente timoroso di presentarsi direttamente. Questo cliente, Guido Lorenzon, professore di Maserada sul Piave, era rimasto spaventato dalle confidenze di un amico, un estremista di destra dalla testa un po’ calda. Pochi giorni prima aveva fatto discorsi che gli avevano fatto sorgere il terribile sospetto che fosse coinvolto in qualcosa di grosso: la strage di piazza Fontana.
Neppure due settimane prima, il 12 dicembre, nella sede milanese della Banca nazionale dell’agricoltura era scoppiata una bomba che aveva ucciso 17 persone e ne aveva ferite 88. Quasi alla stessa ora, tre ordigni erano esplosi a Roma provocando 17 feriti. E una quinta bomba era stata trovata inesplosa in una filiale della Banca commerciale italiana a Milano. Le indagini sembravano aver imboccato una direzione sicura nella pista anarchica. La polizia aveva arrestato Pietro Valpreda, riconosciuto da un tassista come colui che si era fatto accompagnare alla Banca nazionale dell’agricoltura con una valigetta identica a quella che conteneva la bomba inesplosa della Banca commerciale. Un altro degli anarchici fermati, Giuseppe Pinelli, si era – secondo la ricostruzione ufficiale della polizia – buttato dalla finestra della questura di Milano durante un interrogatorio. Un’evidente ammissione di colpevolezza, agli occhi del questore.
«Compresi subito» mi racconta Calogero «che se le informazioni riportate da quell’avvocato si fossero rivelate fondate, avrebbero mutato completamente il corso delle indagini. Decisi che valeva la pena di venire incontro alle richieste di questo possibile informatore, Guido Lorenzon.»
La mattina del giorno di Santo Stefano, di fronte al cimitero di Gaiarine, nei pressi di Conegliano Veneto, Calogero e Lorenzon si incontrano per la prima volta. Il secondo appuntamento avviene qualche giorno dopo in un piano bar di Spresiano. Chiacchierate informali in cui Lorenzon riferisce al magistrato il contenuto di alcuni strani discorsi che un amico, un libraio di Castelfranco Veneto, Giovanni Ventura, gli aveva fatto negli ultimi mesi: cenni ad alcuni dettagli tecnici sugli attentati ai treni dell’agosto 1969 e, poi, le confidenze fatte proprio il 13 dicembre, giorno successivo alla strage di piazza Fontana.
«Lorenzon» ricorda Calogero «mi raccontò che Ventura era sconvolto. Parlando della strage alla Banca nazionale dell’agricoltura, gli aveva detto che era stato commesso un errore che aveva provocato una carneficina. E aveva aggiunto che se la situazione non fosse cambiata, presto ci sarebbero stati altri “botti”.» Lorenzon spiega anche che l’amico da tempo si vantava di far parte di un’organizzazione militare di destra che mirava ad abbattere lo Stato. Affermazioni che fino a quel giorno gli erano sembrate solo millanterie.
Con grande fatica Calogero convince Lorenzon a verbalizzare i contenuti di quelle conversazioni. Dopo esserci riuscito, ottiene la sua piena collaborazione: il testimone accetta persino di andare a un colloquio con Ventura nascondendo sotto la camicia una microspia collegata con un registratore a bordo di un’auto di copertura della polizia, una rarità per l’epoca. Ma, a quel punto, Calogero incontra il primo scoglio. Quando Lorenzon e i poliziotti tornano nell’albergo dove il magistrato li aspetta per ascoltare la registrazione, trovano il nastro completamente vuoto. «Cose che capitano» pensa il magistrato.
Alla successiva occasione, Calogero si premura di controllare personalmente che la microspia e il registratore collegato funzionino a dovere. «Dopo l’incontro Lorenzon ci raggiunse in albergo raggiante: Ventura gli aveva parlato degli attentati sui treni della notte tra l’8 e il 9 agosto 1969, una decina di esplosioni in zone diverse del paese, prova della struttura organizzata e della capacità offensiva del gruppo. Ma quando andammo ad ascoltare la registrazione, la trovammo – incredibilmente – di nuovo muta. La polizia non poteva accampare di nuovo la scusa delle bobine mal posizionate, e ci fu un momento di forte imbarazzo. Feci finta di nulla, ma dentro di me era ormai assodato che c’era una resistenza passiva alle indagini che andavano in una direzione diversa dalla pista anarchica.» Per Calogero fu chiaro che erano due i fronti su cui doveva combattere: l’eversione nera e le forze interne allo Stato che non avevano interesse a far emergere le responsabilità dei veri artefici della strategia della tensione.
«Negli anni a cavallo tra i Sessanta e i Settanta il centro propulsore delle indagini in materia di terrorismo era l’ufficio Affari riservati del ministero dell’Interno. Questo centro riteneva che l’unica pista seria per gli attentati che avevano scosso l’Italia fosse quella anarchica, spingendo così, direttamente o indirettamente, la polizia giudiziaria a non collaborare con i magistrati che seguivano una pista diversa.»
Per superare l’impasse, Calogero decide di stravolgere il protocollo operativo e di condurre lui stesso le indagini. «Mi calo una coppola in testa e mi nascondo nel retro di una Nsu Prinz cui erano stati tolti i sedili. Era parcheggiata di fronte alla stazione di Mestre, a pochi metri dall’hotel Plaza dove Guido Lorenzon e Giovanni Ventura avevano appuntamento con un avvocato di Padova, amico di Ventura. Scoprimmo poi che era Franco Freda. Ascoltai e registrai oltre due ore di colloquio.»
Freda e Ventura erano entrambi membri di Ordine nuovo, un’organizzazione di estrema destra. In quell’incontro all’hotel Plaza parlano degli attentati sui treni dell’agosto 1969, dei timer utilizzati per quelli del 12 dicembre, del finanziamento ricevuto dai servizi segreti per stampare il «libretto rosso», una pubblicazione che sotto le apparenze maoiste propugnava l’unione di tutte le forze rivoluzionarie per abbattere con la violenza il sistema. Erano indizi che contrastavano totalmente con la pista seguita dalla procura di Roma, titolare delle indagini sulla strage di piazza Fontana e sugli altri attentati del 12 dicembre. A febbraio, appena tre mesi dopo la strage, tutti gli atti acquisiti a Treviso vennero trasmessi alla procura di Roma. «E lì» racconta Calogero «rimasero lettera morta. Ce li mandarono indietro un anno dopo dicendoci di procedere per calunnia nei confronti di Lorenzon.»
Nel frattempo il giovane procuratore continua a indagare su Ordine nuovo come responsabile degli attentati ai treni dell’agosto 1969. Comprende che uno snodo importante della trama eversiva era la libreria Ezzelino gestita da Franco Freda a Padova e decide di provare a scavare nella cronaca della violenza politica della città del Santo. Con un metodo che nell’inchiesta su Autonomia operaia diventerà la sua cifra, si affida ai documenti. Dalla questura di Padova si fa consegnare vecchi fascicoli di attentati rimasti senza colpevole, centinaia e centinaia di pagine che esamina con certosina pazienza. Si immerge con tanta passione da dimenticare tutto il resto. «Ho passato la vigilia del matrimonio in questura a Padova, a studiare. Alla sera, quando sono uscito, mi sono reso conto che non avevo le scarpe da cerimonia. Ho comprato quel che ho trovato nell’unico negozio aperto. Alle nozze ho patito tutto il giorno: quelle scarpe erano un numero in meno del mio.»
L’intuizione era giusta. In un fascicolo aperto e subito archiviato trova alcune bobine ancora sigillate, mai ascoltate. «Erano i nastri delle registrazioni di alcune intercettazioni fatte sul telefono di Freda in occasione delle indagini per due attentati dinamitardi compiuti nel 1969 al rettorato dell’università di Padova. C’erano conversazioni in cui diceva di volersi inserire nelle tensioni dell’autunno caldo con iniziative che avrebbero dovuto acuire la tensione e alzare il livello fino allo scontro armato: la teorizzazione della strategia della tensione. Un altro nastro conteneva la conversazione tra Freda e un elettricista. Freda gli chiedeva di andare a Bologna a ritirare 50 timer da 60 minuti del tipo «in deviazione», della ditta tedesca Diehl. Un dettaglio importantissimo: quei timer, appena usciti, avevano all’interno un lamierino particolare che fu ritrovato tra le macerie della Banca nazionale dell’agricoltura a piazza Fontana.»
È un tassello chiave, bisogna rintracciare l’elettricista. Ma come si fa, se Calogero non ne conosce neppure il nome? L’unico indizio è un moncone di parola nel saluto di Freda al termine della telefonata: «Ciao Fa…». Il magistrato prende le Pagine gialle della provincia di Padova, cerca alla voce «elettricisti», trova un Fabris. Era quello che aveva acquistato i timer per Freda? Calogero ha in mano molto poco, ma decide di fare un tentativo: gli manda a casa un carabiniere con una richiesta di convocazione. E quando il militare si presenta alla porta chiedendogli se è lui Tullio Fabris, l’uomo scoppia a piangere. Una porta sfondata con un dito.
«Fabris era già distrutto dal senso di colpa, crollò immediatamente: mi raccontò che Freda gli aveva chiesto di procurargli delle cassette di ferro, perché quelle di legno utilizzate in precedenza nelle esplosioni non avevano dato i risultati sperati. Era il passaggio che collegava Freda sia alle bombe sui treni del 1969, dove erano state usate cassette di legno, sia alla bomba di piazza Fontana, dove invece era stata utilizzata una cassetta di ferro, il nesso che riconduceva i vari episodi all’interno della medesima strategia, in un crescendo di obiettivi.»
La felice intuizione apre un’importante pista investigativa sulla destra eversiva, ma Calogero deve ancora una volta fare i conti con forze all’interno delle istituzioni che fanno di tutto per ostacolare la sua inchiesta. Il bidello Marco Pozzan, per esempio, era tra i più stretti collaboratori di Freda. Dopo l’arresto nel 1972, aveva cominciato a rivelare dettagli sulla pianificazione della strategia della tensione, e avrebbe potuto essere un teste chiave.
«Pozzan raccontò che il via alla pianificazione degli attentati era stato dato durante la riunione del 18 aprile 1969 a cui avevano partecipato anche Pino Rauti, allora a capo di Ordine nuovo, e un giornalista membro dei servizi segreti. Pozzan, però, si dileguò non appena il giudice istruttore gli concesse la libertà provvisoria. Fu un brutto colpo. Ma ancora peggio fu scoprire, tempo dopo, che il collaboratore di Freda era stato fatto sparire dal Sid, il servizio segreto italiano. Lo avevano rintracciato appena uscito di prigione e portato nella sede di via Sicilia, a Roma, e lo avevano interrogato non sul suo ruolo nella strategia eversiva, ma sul contenuto degli interrogatori a cui lo avevamo sottoposto noi. Venimmo a sapere che era stato proprio il Sid a fornirgli la carta d’identità falsa che gli aveva permesso di fuggire in Spagna. Posso parlare liberamente, perché per questo episodio sono stati condannati in via definitiva il capitano del Sid Antonio Labruna e il generale Gianadelio Maletti.»
Inquietante anche la vicenda di Guido Giannettini. «Uomo di destra,» ricorda il magistrato «ufficialmente giornalista, in realtà era l’elemento di coordinamento tra la cellula eversiva di Ordine nuovo e l’apparato deviato del Sid, ruolo per il quale viene condannato in primo grado dalla Corte d’assise di Catanzaro. A metà del 1972, anche Giannettini venne sospettato di complicità nella strage di piazza Fontana e negli altri attentati del 12 dicembre. Alla fine dell’anno, contro di lui fu emesso un mandato di cattura. Le forze dell’ordine non fecero però in tempo ad arrestarlo: il Sid gli aveva fornito un passaporto con falso nome che gli aveva permesso di espatriare in Francia. Nel periodo della latitanza, fu proprio il Sid a coprirlo e stipendiarlo.»
Sid e Giannettini sono due nomi che colpiscono il mio cuore di bambina, che emergono come insegne al neon in una nebbia di ricordi confusi. Sto andando a scuola in auto. Ho imparato a leggere da poco, ma la locandina gialla all’edicola, scritta in stampatello maiuscolo, è facile da capire. «Mamma, c’è scritto GIRALUCCI UN AGENTE DEL SID. Che cosa vuol dire?» La mamma non risponde. Dallo specchietto vedo quella smorfia dura che le viene ogni volta che si accenna a papà. «Sai che c’è Silvia? Oggi vai dalla nonna.» Gira l’auto e torniamo indietro.
Un altro frammento esce dalla scatola di legno verde: sono alcune pagine dell’«Europeo», un’inchiesta di Claudio Lazzaro e Claudio Serra, pubblicata due settimane dopo la morte di papà. C’è un testimone che dice di aver incontrato mio padre in un’osteria del centro, e di aver notato all’altezza della cintura qualcosa che luccicava, come una pistola. («E invece» dice la mamma «aveva una cintura con una grossa fibbia d’acciaio.») E poi, a dimostrazione dei legami di mio padre con il Sid ci sarebbero le reticenze di mia madre. Pochi giorni dopo il funerale avevano provato a intervistarla. Lei non se la sentiva di parlare, con nessuno. Le lasciarono un foglio con le domande nella cassetta della posta. Mi chiedo chi avrebbe risposto, pochi giorni dopo aver seppellito il marito, a giornalisti che chiedevano quanto pagava di bolletta del telefono, se mio padre aveva contatti con la Francia e via dicendo. Mia madre non ne comprese il senso, si sentì offesa e decise di non rispondere.
Con gli anni, pur non avendo motivo di dubitare di mia madre, mi è sempre rimasto un fondo di dubbio. Certo, se mio padre fosse stato davvero un uomo di Giannettini, la figlia che non lo ha praticamente conosciuto sarebbe stata l’ultima a saperlo. Avevo già raggiunto un buon grado di confidenza con Calogero quando ho deciso di chiederlo a lui. Con sollievo ho visto che la mia domanda non lo imbarazzava.
«Abbiamo scavato, abbiamo scavato molto indietro e molto a fondo nella destra padovana. Posso dirle con certezza che il nome di suo padre non è mai uscito, neppure marginalmente. Può stare tranquilla, suo padre non c’entrava nulla con quel giro.»
Il terzo episodio di ostruzionismo da parte dei servizi segreti deviati riguarda Giovanni Ventura. «Dopo l’arresto, all’inizio del 1972, Ventura cominciava a dare segni di inquietudine, mostrava di voler fare rivelazioni sulla strategia della tensione. Anche in questo caso il Sid intervenne, non per collaborare ma per intralciare le indagini. Attraverso un proprio emissario propose a Ventura un piano di fuga, gli mise a disposizione un passepartout in grado di aprire le celle del carcere di Monza dove era rinchiuso e due bombolette di sostanze narcotizzanti per stordire gli agenti di custodia. Ventura stesso raccontò questo episodio in un memoriale in cui dava conto dei suoi contatti, anche durante la carcerazione, con il Sid. Non credo sia solo una mia convinzione. A chiunque rilegga gli atti di questa inchiesta salta agli occhi che l’assoluzione per insufficienza di prove per Freda e Ventura fu frutto di pressioni enormi, o comunque di un errore giudiziario.»
Nella primavera del 1975, con l’inchiesta su Freda e Ventura alle spalle, Calogero arriva a Padova come sostituto procuratore. Mio padre e Giuseppe Mazzola erano stati uccisi quasi un anno prima. Il duplice omicidio era stato rivendicato con un volantino delle Brigate rosse, ma pochi vi avevano creduto, e le indagini erano in un vicolo cieco.
«La città» ricorda il magistrato «viveva in un clima di scontro squadristico, con esponenti di destra e dell’ultrasinistra che si attaccavano a vista.» Era successo anche a papà. L’ho scoperto da un frammento dei ricordi di mia madre: «Lo avevano colpito in testa con una spranga di ferro. Non gli erano ancora ricresciuti i capelli quando lo hanno ammazzato». Era la primavera del 1974, durante la campagna per il referendum per l’abrogazione della legge sul divorzio. Mio padre, da buon missino, faceva propaganda per il «Sì». Ho ritrovato la ricostruzione dell’aggressione negli archivi della Digos, nel verbale della testimonianza di un amico, Carlo Luni, un giovane estraneo all’ambiente politico, che condivideva con mio padre la passione per i «baracchini», come venivano chiamate negli anni Settanta le ricetrasmittenti installate sulle auto dei radioamatori.
Dice Luni rispondendo a una domanda della polizia: «Una mattina il Giralucci mi ha telefonato dall’ospedale civile di Padova, dove si trovava ricoverato, e mi ...