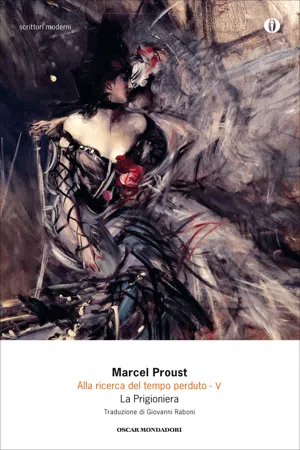
eBook - ePub
La Prigioniera
- 3,572 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La Prigioniera
Informazioni su questo libro
Quasi come in una tragedia classica, nel quinto libro della Recherche tutta l'azione si concentra attorno a due soli protagonisti, il Narratore e Albertine, in uno scenario di tempo e luogo - un appartamento borghese parigino - ben delimitato. Predomina quindi l'introspezione psicologica, la descrizione dell'amore, un amore quasi patologico, fatto di sofferenza e gelosia. La Prigioniera (1923) si configura come una grandiosa indagine sul sentimento erotico che demolisce miti e stereotipi romantici e ne inaugura una concezione moderna.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
LetteraturaCategoria
ClassiciLA PRIGIONIERA
La traduzione di Giovanni Raboni segue il testo francese pubblicato in quattro volumi sotto la direzione di Jean-Yves Tadié (M. Proust, À la recherche du temps perdu, vol. III, «Bibliothèque de la Pléiade», Gallimard, Paris 1988). Per La Prisonnière Tadié si è valso della collaborazione di Pierre-Edmond Robert.

Quando penso, adesso, che al nostro ritorno da Balbec la mia amica era venuta ad abitare a Parigi con me, sotto lo stesso tetto, rinunciando all’idea di recarsi in crociera, e aveva la sua camera a venti passi dalla mia, in fondo al corridoio, nello studio ornato d’arazzi di mio padre, e ogni sera, molto tardi, prima di lasciarmi, mi faceva scivolare in bocca la sua lingua come un pane quotidiano, come un cibo nutriente e dotato del carattere quasi sacro proprio d’ogni carne cui le sofferenze da noi patite per causa sua hanno finito col conferire una sorta di dolcezza morale, ciò che subito mi vien fatto d’evocare a paragone non è la notte che il capitano de Borodino mi permise di passare in caserma, concedendomi un favore che, in fin dei conti, mi guariva da un disagio effimero, ma quella in cui mio padre mandò la mamma a dormire nel lettino accanto al mio. È così che la vita, se deve liberarci una volta di più da sofferenze che sembravano inevitabili, lo fa in condizioni talmente diverse, o addirittura opposte, che sembra quasi di commettere un sacrilegio constatando l’identità della grazia ricevuta!
Quando Albertine sapeva da Françoise che, nel buio della mia camera con le tende ancora chiuse, io non stavo dormendo, non si dava pensiero se, lavandosi nel suo bagno, faceva un po’ di rumore. Spesso, allora, senza aspettare che fosse più tardi, andavo nel bagno contiguo al suo e assai gradevole. Un tempo, il direttore d’un teatro spendeva centinaia di migliaia di franchi per costellare di autentici smeraldi il trono della diva che sosteneva la parte di un’imperatrice. I balletti russi ci hanno insegnato che qualche semplice gioco di luce, disposto in modo opportuno, crea gioielli altrettanto sontuosi e più variati. Ma una decorazione siffatta, pur già apprezzabilmente immateriale, non è ancora graziosa come l’altra con cui, alle otto del mattino, il sole rimpiazza quella che eravamo abituati a vedere quando ci svegliavamo soltanto a mezzogiorno. Per evitare che ci vedessero da fuori, le finestre dei nostri due bagni non erano lisce, ma tutte increspate da una brina artificiale e fuori moda. Di colpo, il sole colorava di giallo quella mussola di vetro, la dorava e, scoprendo pian piano in me un giovane più antico che l’abitudine aveva a lungo nascosto, mi inebriava di ricordi, come se mi fossi trovato nel bel mezzo della natura davanti a un fogliame dorato cui non faceva difetto neppure la presenza d’un uccello. Sentivo, infatti, Albertine fischiettare senza posa:
I dolori son pazzi,
e chi li ascolta è pazzo più di loro.
La amavo troppo per non sorridere allegramente del suo cattivo gusto musicale. L’estate prima, del resto, quella canzone aveva affascinato Madame Bontemps, la quale, resa edotta della sua insulsaggine, smise ben presto di chiedere ad Albertine che la cantasse quando c’erano ospiti, sostituendola con
Dalle agitate fonti sgorga un canto d’addio,
che divenne a sua volta “quella vecchia solfa di Massenet con cui la piccina ci ossessiona”.
Passava una nuvola, nascondeva il sole, vedevo spegnersi e ritrarsi nel grigio la pudica e fronzuta cortina di vetro. I tramezzi che separavano i nostri due bagni (quello di Albertine, in tutto simile al mio, non era mai stato utilizzato dalla mamma, che ne aveva un altro dal lato opposto dell’appartamento, per non disturbarmi col rumore) erano così sottili da consentirci di parlare mentre ci lavavamo, ciascuno nel suo, proseguendo una conversazione interrotta solo dallo scrosciare dell’acqua, in quell’intimità favorita spesso, in albergo, dall’esiguità dell’alloggio e dalla prossimità delle stanze, ma così rara a Parigi.
Altre volte me ne restavo a letto, immerso in fantasticherie che duravano a mio piacere, giacché vi era l’ordine di non entrare mai nella mia stanza prima che avessi suonato: il che, a causa della scomoda posizione in cui si trovava, sopra il mio letto, la peretta del campanello, richiedeva tanto tempo da far sì che spesso, stanco di sforzarmi di raggiungerla e contento d’essere solo, io ricadessi quasi, per qualche istante, nel sonno. Non ch’io fossi del tutto indifferente alla presenza di Albertine in casa nostra. La sua separazione dalle amiche risparmiava nuove sofferenze al mio cuore, e gli consentiva un riposo, una quasi immobilità che l’avrebbero aiutato a guarire. Ma, in fin dei conti, questa calma procuratami dalla mia amica era piuttosto requie della sofferenza che non vera gioia. Il che non toglie che mi fosse possibile, grazie ad essa, gustarne non poche che il dolore troppo vivo mi aveva precluse; ma tali gioie, lungi dal doverle ad Albertine che, d’altronde, avevo smesso quasi del tutto di trovare bella, accanto alla quale mi annoiavo e che avevo la netta impressione di non amare, io le gustavo, al contrario, quando Albertine non era con me. Così, per cominciare la mia mattinata, evitavo, soprattutto se c’era bel tempo, di farla chiamare subito. Per qualche istante, e sapendo che m’avrebbe reso più felice di lei, restavo a tu per tu con quel piccolo personaggio interiore, nunzio canoro del sole, di cui ho già parlato. Fra quelli che compongono la nostra persona, non sono i più appariscenti ad essere i più essenziali. In me, quando la malattia avrà finito di atterrarli uno dopo l’altro, ne resteranno ancora due o tre più duri a morire, in particolare una specie di filosofo la cui unica felicità consiste nello scoprire fra due opere, fra due sensazioni, una parte comune. Ma l’ultimo fra tutti mi sono chiesto, più d’una volta, se non potrebbe essere un certo omino straordinariamente simile a quello che l’ottico di Combray aveva messo dietro la sua vetrina per indicare quale tempo facesse, e che si toglieva il cappuccio quando c’era il sole per rimetterselo quando minacciava di piovere. So bene, quell’omino, quanto sia egoista: ho un bel soffrire d’una crisi di soffocazione che solo l’arrivo della pioggia calmerà; lui non se ne cura e, alle prime gocce così impazientemente attese, perdendo tutta la sua allegria, si tira giù con stizza il cappuccio. In compenso, sono sicuro che durante la mia agonia, quando tutti i miei altri “io” saranno morti, basterà che un raggio di sole venga a brillare mentre io esalo il mio ultimo respiro perché quel barometrico personaggetto si rallegri e, togliendosi il cappuccio, si metta a canterellare: «Ah! finalmente un po’ di bel tempo».
Suonavo per Françoise. Aprivo il «Figaro». Cercavo, constatandone l’assenza, un articolo, o presunto tale, che avevo inviato a quel giornale e che altro non era se non, un po’ aggiustata, la pagina scritta quella volta nella carrozza del dottor Percepied, guardando i campanili di Martinville, e di recente ritrovata. Poi leggevo la lettera della mamma. Le sembrava strano, sconveniente, che una ragazza abitasse da sola assieme a me. Il primo giorno, al momento di lasciare Balbec, vedendomi così infelice, e non sentendosi tranquilla all’idea di lasciarmi solo, era stata forse felice nell’apprendere che Albertine sarebbe partita con noi e nello scorgere sul “tortiglione”, a fianco dei nostri bagagli (quei bagagli accanto ai quali, in albergo, avevo passato la notte piangendo), quelli, stretti e neri, di Albertine, la cui forma mi era parsa simile a quella delle bare e di cui ignoravo se m’avrebbero portato in casa la vita oppure la morte. Ma non me l’ero nemmeno domandato, tutto preso com’ero, nel mattino sfavillante, dopo il terrore d’esser bloccato a Balbec, dalla gioia di portare con me Albertine. Ma se a quel progetto la mamma, dapprima, non era stata ostile (e alla mia amica si rivolgeva con gentilezza, come una madre il cui figlio è stato gravemente ferito, e che è grata alla giovane amante la quale se ne prende devotamente cura), lo era diventata da quando esso si era troppo compiutamente realizzato e il soggiorno della fanciulla in casa nostra – in casa nostra e in assenza dei miei genitori – accennava a protrarsi. Non posso d’altronde dire che la mamma, quell’ostilità, la manifestasse mai in mia presenza. Come in altri tempi, quando non aveva più avuto il coraggio di rimproverarmi il mio nervosismo, la mia pigrizia, così adesso si faceva uno scrupolo – ch’io, sul momento, non ho forse del tutto intuito o voluto intuire – di rischiare, esprimendo qualche riserva sulla fanciulla con la quale le avevo detto che mi sarei fidanzato, di rattristarmi, di rendermi più tardi meno devoto a mia moglie, di seminare forse in me, per quando lei non ci fosse più stata, il rimorso d’averla fatta soffrire sposando Albertine. Preferiva far credere d’essere d’accordo su una scelta dalla quale non si sentiva in grado di farmi recedere. Ma tutti coloro che l’hanno frequentata in quel periodo mi hanno detto che al dolore d’aver perduto sua madre s’aggiungeva allora in lei un’incessante preoccupazione. Questa tensione mentale, questo dibattito interiore le davano un gran calore alle tempie, e apriva di continuo le finestre per avere più fresco. Ma decisioni non arrivava mai a prenderne, per paura di “influenzarmi” in modo negativo e di guastare quella che credeva la mia felicità. Né poteva risolversi a impedirmi di tenere Albertine, provvisoriamente, in casa nostra. Non voleva mostrarsi più severa di Madame Bontemps, che era la più direttamente interessata e che, con grande sorpresa di mia madre, non vedeva nella cosa nulla di sconveniente. In ogni caso, alla mamma dispiaceva d’esser stata costretta a lasciarci soli, noi due, partendo proprio allora per Combray dove era possibile che dovesse rimanere (e in effetti rimase) per mesi e mesi, durante i quali la mia prozia ebbe ininterrottamente bisogno di lei notte e giorno. Tutto, là, le fu reso facile dalla bontà, dalla devozione di Legrandin, il quale, non sottraendosi ad alcun disagio, rimandò di settimana in settimana il suo ritorno a Parigi, pur conoscendo appena mia zia, per il solo fatto, da principio, che era stata un’amica di sua madre, e poi perché si rese conto che la malata, che non aveva speranze di guarigione, apprezzava le sue cure e non poteva fare a meno di lui. Lo snobismo è una malattia dell’anima, una malattia grave ma localizzata e che, dunque, non la guasta per intero. Quanto a me, io ero, al contrario di mia madre, felicissimo del suo soggiorno a Combray, senza il quale avrei temuto (non potendo dire all’interessata di tenerla nascosta) ch’ella potesse scoprire l’amicizia fra Albertine e Mademoiselle Vinteuil. Sarebbe stato questo, per mia madre, un ostacolo assoluto non soltanto in rapporto a un matrimonio di cui per altro m’aveva chiesto di non parlare ancora definitivamente alla mia amica e la cui idea mi si faceva via via più intollerabile, ma al fatto stesso che Albertine rimanesse per qualche tempo a casa nostra. Fatta eccezione per un motivo così grave e di cui, del resto, non era al corrente, la mamma era adesso – per il doppio effetto dell’imitazione edificante e liberatoria della nonna, che ammirava George Sand e faceva consistere la virtù nella nobiltà del cuore, e, d’altro canto, della mia influenza corruttrice – indulgente nei confronti di donne il cui comportamento avrebbe giudicato severamente in passato, e forse anche oggi, se si fosse trattato di qualche sua amica borghese di Parigi o di Combray anziché di persone di cui io le vantavo la grandezza d’animo e alle quali perdonava molto perché molto mi amavano. A parte tutto, e al di là d’ogni questione di convenienza, credo che Albertine sarebbe riuscita insopportabile a mia madre, che aveva preso da Combray, da zia Léonie, da tutte le sue parenti certe abitudini d’ordine di cui la mia amica non aveva la minima nozione. Non le sarebbe mai venuto in mente di chiudere una porta e, in compenso, quando una porta era aperta, non si sarebbe fatta più scrupoli d’entrare di quanti se ne facciano un cane o un gatto. Il suo fascino un po’ inquietante consisteva, insomma, nel suo stare dentro casa, più che come una fanciulla, come un animale domestico, che entra in una stanza e ne esce e compare ovunque meno ci si aspetti di trovarlo, un animale che veniva (per me era un riposo profondo) a gettarsi sul mio letto accanto a me e ci si faceva una cuccia dalla quale non si muoveva più, senza disturbare come avrebbe fatto un essere umano. Finì tuttavia con l’adeguarsi alle mie ore di sonno, non solo non cercando più d’entrare in camera mia, ma anche sforzandosi di non far rumore fin tanto ch’io non avessi suonato. Fu Françoise ad imporle queste regole. Apparteneva, lei, alla razza delle domestiche di Combray, consapevoli del valore del loro padrone e ben decise a far rendere omaggio a quelli che ritengono essere i suoi meriti. Quando un visitatore non abituale le dava una mancia da spartire con la sguattera, faceva appena in tempo a mettergliela in mano che già Françoise, con rapidità pari alla discrezione e all’energia, aveva dato la “dritta” all’interessata, la quale si presentava a ringraziare il donatore e non a mezza bocca, bensì direttamente, apertamente, come Françoise le aveva detto che bisognava fare. Il parroco di Combray non era un genio, ma sapeva anche lui come ci si comporta. Sotto la sua guida, la figlia di certi cugini protestanti di Madame Sazerat si era convertita al cattolicesimo, e la famiglia s’era condotta, con lui, in maniera perfetta. Si parlò di matrimonio fra la ragazza e un nobile di Méséglise. I genitori del giovane scrissero, per avere informazioni, una lettera abbastanza insolente, e nella quale si alludeva con dispregio alle origini protestanti. Il parroco di Combray rispose in un tono tale che il nobile di Méséglise, piegato e domo, scrisse una seconda e assai diversa lettera per sollecitare il prezioso privilegio di potersi unire alla fanciulla.
Françoise non ebbe alcun merito nell’ottenere che Albertine rispettasse il mio sonno: era imbevuta di tradizione. Da un silenzio nel quale si chiuse, o dalla risposta perentoria con cui reagì alla proposta, innocentemente formulata da Albertine, di entrare nella mia stanza o di farmi chiedere qualcosa, la mia amica dedusse con stupore di trovarsi in uno strano mondo dalle usanze sconosciute, regolato da leggi di comportamento ch’era impensabile infrangere. Ne aveva già avuto un primo presentimento a Balbec; ma a Parigi non tentò nemmeno d’opporre resistenza, e ogni mattino attese con pazienza la mia scampanellata prima d’azzardarsi a fare rumore.
L’educazione impartitale da Françoise fu salutare, del resto, anche alla nostra vecchia domestica, calmando a poco a poco i gemiti che non aveva cessato di emettere dal momento del ritorno da Balbec. Mentre saliva in treno s’era accorta, infatti, di non aver salutato la “governante” dell’albergo, un personaggio baffuto, addetto alla sorveglianza dei piani, che conosceva appena Françoise ma era stato relativamente gentile con lei. Françoise voleva assolutamente tornare indietro, scendere dal treno, precipitarsi in albergo, salutare la governante e non ripartire prima dell’indomani. Il buon senso e, più ancora, il mio subitaneo orrore di Balbec mi impedirono di accordarle questa grazia; ma Françoise ne aveva contratto un malumore malaticcio e febbrile che il cambiamento d’aria non era bastato a far sparire e che perdurava quindi a Parigi. Secondo il suo codice, infatti, quale si trova illustrato nei bassorilievi di Saint-Andrédes-Champs, augurarsi la morte d’un nemico, e persino procurarla, non è proibito, mentre è orribile non fare ciò che è dovuto, non ricambiare una cortesia, omettere, come una vera zotica, di porgere i propri omaggi, prima di partire, alla governante del piano. Per l’intera durata del viaggio, il ricordo, incessantemente rinnovellato, di non essersi congedata da quella donna, aveva fatto salire alle guance di Françoise un preoccupante color vermiglio. E se si rifiutò, fino a Parigi, di bere e di mangiare, fu perché quel ricordo le metteva un “peso” reale “sullo stomaco” (ogni classe sociale ha la sua patologia) più ancora, forse, che per punirci.
Fra le ragioni che inducevano mia madre a inviarmi ogni giorno una lettera, e una lettera dalla quale non era mai assente qualche citazione di Madame de Sévigné, c’era il ricordo della nonna. Mi scriveva la mamma: “Madame Sazerat ci ha offerto una di quelle colazioni di cui possiede il segreto e che, come avrebbe detto la tua povera nonna citando Madame de Sévigné, ci tolgono alla solitudine senza darci la compagnia”. Nelle mie prime risposte, fui tanto stupido da scriverle: “Da queste citazioni, tua madre ti riconoscerebbe all’istante”. Il che mi valse, tre giorni dopo, questa battuta: “Mio povero ragazzo, se era per parlarmi di mia madre, invochi davvero a sproposito Madame de Sévigné, la quale ti avrebbe risposto, come quella volta a Madame de Grignan: ‘Non era dunque niente per voi? vi credevo parenti’”.

Si vedrà più tardi come, pur avendo conservato l’abitudine di certi modi di dire un po’ sciocchi, Albertine si fosse straordinariamente evoluta. La cosa mi lasciava del tutto indifferente, dal momento che le doti intellettuali di una donna mi hanno sempre interessato talmente poco che se mi è capitato di lodarle in qualcuna, l’ho fatto per pura e semplice educazione. Solo il singolare genio di Céleste mi sarebbe forse piaciuto. Senza volerlo, sorridevo per qualche istante quando, ad esempio, mettendo a profitto la notizia di qualche assenza di Albertine, mi abbordava con queste parole: «Divinità del cielo posata sopra un letto!». Io le dicevo: «Ma via, Céleste, perché mai “divinità del cielo”? – Ah, se pensate di assomigliare a coloro che viaggiano sulla nostra vile terra, vi sbagliate di grosso! – Ma perché “posata sopra un letto”? vedete bene che sono coricato. – Voi non siete mai coricato. Si è mai visto qualcuno coricato in quel modo? Siete venuto a posarvi lì dove siete. E il pigiama tutto bianco, con i movimenti che fa il vostro collo, in questo momento vi dà l’aspetto d’una colomba».
Anche a proposito di stupidaggini, Albertine si esprimeva ora ben diversamente dalla ragazzina che era stata, a Balbec, ancora pochi anni prima. Arrivava al punto di affermare, parlando d’un avvenimento politico che biasimava: «Lo trovo enorme», e non so se fu in quello stesso periodo che imparò a dire, per significare che un libro le pareva mal scritto: «È interessante, ma, in compenso, sembra scritto da un maiale».
La proibizione d’entrare in camera mia prima che avessi suonato la divertiva molto. Poiché aveva assimilato la nostra abitudine familiare delle citazioni e utilizzava all’uopo quelle dei drammi che aveva recitati in convento e che le avevo detto d’amare, mi paragonava sempre ad Assuero:
Et la mort est le prix de tout audacieux
Qui sans être appelé se présente à ses yeux.
Rien me met à l’abri de cet ordre fatal,
Ni le rang, ni le sexe, et le crime est égal.
Moi-même...
Je suis à cette loi comme une autre soumise,
Et sans le prévenir il faut pour lui parler
Qu’il me cherche ou du moins qu’il me fasse appeler.
Anche fisicamente, Albertine era mutata. I suoi lunghi occhi azzurri, allungandosi ancora di più, non avevano serbato la stessa forma; il colore, sì, era lo stesso, ma sembrava che fosse passato allo stato liquido. Così, quando li chiudeva, era come se qualcuno vi impedisse, tirando una tenda, di vedere il mare. Era questa, probabilmente, la parte di lei che ogni notte, lasciandola, mi restava più impressa nel ricordo. Perché, ad esempio, l’increspatura dei suoi capelli mi causò invece per molto tempo, ogni mattina, la stessa sorpresa, come se fosse stata qualcosa di nuovo che vedevo per la prima volta. Eppure, sopra lo sguardo sorridente d’una fanciulla, cosa c’è di più bello d’una tale corona inanellata di violette di tenebra? Il sorriso invoglia di più all’amicizia; ma i piccoli uncini smaltati dei capelli in fiore, più imparentati alla carne di cui sembrano una sorta d’ondosa trasposizione, attirano a sé con maggior forza il desiderio.
Appena entrata in camera mia, Albertine saltava sul letto e, a volte, enunciava qualche definizione del mio genere d’intelligenza, o giurava, con trasporto sincero, che avrebbe preferito morire piuttosto che lasciarmi; erano i giorni in cui, prima di farla entrare, mi ero rasato. Apparteneva a quella categoria di donne che non sanno distinguere la ragione di ciò che provano. Il piacere provocato in loro da un colorito fresco lo attribuiscono alle qualità morali di chi sembra prospettare qualche felicità al loro futuro, una felicità che, del resto, è destinata a diminuire e a farsi meno necessaria man mano che ci si lascia crescere la barba.
Le chiedevo dove pensa...
Indice dei contenuti
- Copertina
- di Marcel Proust
- La Prigioniera
- Nota Introduttiva di Luciano De Maria
- La Prigioniera o il «contratto perverso» di Luciano De Maria
- Due postille
- LA PRIGIONIERA
- Argomento Del Volume a cura di Giovanni Raboni
- Copyright
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a La Prigioniera di Marcel Proust, Luciano De Maria, Giovanni Raboni, Luciano De Maria,Giovanni Raboni in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Classici. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.