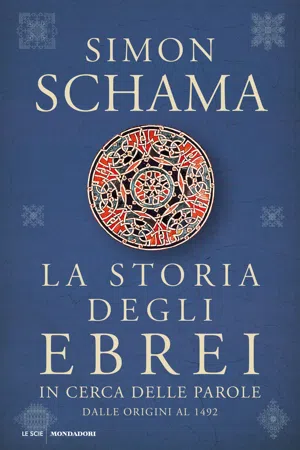![]()
![]()
I. Fianco a fianco
Novembre 1933: non un buon momento per gli ebrei, non a Berlino. Non un momento particolarmente felice neanche per essere americani. I disoccupati, tra la forza lavoro, erano uno su quattro, ancora di più in luoghi di disperazione come Chicago. Poteva il nuovo presidente essere il messia della depressione, o l’economia americana, speranza per milioni e milioni di persone, era spacciata? La crisi penetrò anche dove la vita continuava più o meno come prima del crollo: a Yale, per esempio, dove ragazzi con numeri romani posposti ai cognomi facevano baldoria bevendo un cocktail dopo l’altro.
Clark Hopkins non era uno di loro. Ciò cui si rivolgeva per tirarsi su d’umore in mezzo a tanta malinconia era l’archeologia. Se solo, pensava sfogliando le fotografie dei suoi scavi nel deserto siriano, si fosse materializzato qualcosa di sbalorditivo, qualcosa di spettacolare come il Tutankhamon di Carter, avrebbe potuto dare a quanti erano paralizzati nella disperazione un motivo per restare allibiti, un altro tempo e un altro luogo in cui rifugiarsi, lontano dal tetro abisso del presente. Che cosa ci sarebbe stato di male?
Era di un’ingenuità commovente, quella fede nell’elisir dell’archeologia. Ma Hopkins era un ottimista. Era divenuto direttore degli scavi a Dura Europos, antica città di frontiera fortificata lungo il corso superiore dell’Eufrate, nascosta da secoli sotto alti terrapieni di sabbia. Spazzata via la sabbia, nei tardi anni Venti era venuta alla luce una grande città, con strade e templi cinti di mura. Chiamare Dura «la Pompei del deserto» era abbindolare il pubblico per accenderne l’interesse, ma che fosse una meraviglia inaspettata era indubbio. Come vivevano quei soldati di frontiera! Fondata dai greci seleucidi intorno al 303 a.C. come roccaforte contro le minacce provenienti dall’Iran, situata esattamente sulla rotta commerciale fra Babilonia e la Palestina, «Europos», com’era nota, cadde alla fine del II secolo a.C. nelle mani dei parti di Persia. Com’era loro abitudine, quegli imperialisti persiani ultima versione non si fecero problemi per la fioritura dei culti più diversi, tanto che accanto ai loro sorsero templi dedicati a dèi siriani locali e templi ellenistici. Durante i secoli dei parti, alle porte di Dura bussò il nuovo potere nella regione, Roma, ma fu solo nel 165 d.C. che Lucio Vero, coimperatore con Marco Aurelio, sfondò. I romani, però, non tennero la città più di un secolo: nel 256 d.C., infatti, essa si arrese definitivamente e fatalmente all’immenso esercito del nuovo re persiano sassanide, Shapur I.
Da allora, a parte qualche occasionale eremita cristiano attratto dalle rovine appena sporgenti dalla sabbia e, ogni tanto, una carovana di muli e cammelli che arrancava lungo il fiume, Dura Europos rimase disabitata e inesplorata. Se i Sassanidi ne avessero fatto di nuovo una città persiana l’avrebbero radicalmente alterata, ma essa rimase a dormire intatta, così com’era, sotto il suo manto di polvere. La logistica degli ultimi assedi l’aveva sepolta viva. La città aveva cambiato di mano due volte fra romani e persiani, e tanto i difensori quanto gli attaccanti avevano innalzato enormi terrapieni a rampe, dentro e fuori le mura occidentali prospicienti il deserto, riempiendo di terra gli edifici abbandonati dai loro occupanti civili. Poi erano intervenute le tempeste di sabbia ad avvolgere quella che un tempo era stata la città, finché Dura Europos non divenne un’enorme, altissima duna tra l’Eufrate e il cielo siriano.
Nel 1920 C.M. Murphy, un ufficiale dell’esercito britannico, v’infilò spavaldamente il suo bastone e incontrò resistenza, cosicché furono ordinate pale imperiali, ed esse, messe in mano ai fellahin, i contadini e abitanti del villaggio, non tardarono a rivelare le forme erose delle fondamenta di edifici di fango e malta e, poi, mura ancora in piedi decorate da rudimentali pitture che, pensò Murphy, dovevano essere molto antiche. Il suo superiore, avvisato, mandò un telegramma alla straordinaria Gertrude Bell, allora occupata a mettere insieme una costituzione per la creazione britannica che era il regno dell’Iraq, e, grazie all’offerta di un sostegno ufficiale, alle solite condizioni parsimoniose e con i soliti uffa e tentennamenti, i lavori preliminari ebbero inizio. Ma Dura Europos, a metà strada fra la Mesopotamia e Palmira, ricadeva all’interno del territorio siriano posto per mandato della Società delle Nazioni sotto il controllo della Francia, e se i francesi, lenti a portare la mano alla fondina nei duelli archeologici coloniali, furono battuti in velocità da un egittologo americano, James Breasted, che nel 1921 iniziò a scavare sul serio, fecero ben presto valere i loro diritti e gli soffiarono il posto. Nel 1928, però, decisero di mettere in comune le proprie risorse con quelle americane in una spedizione congiunta organizzata sotto gli auspici dell’Università di Yale.
Cinque stagioni di scavi rivelarono meraviglie da lasciare a bocca aperta: undici templi e santuari pagani – romani, greci e mitriaci –, alcuni con affreschi. Man mano che un’abitazione dopo l’altra veniva liberata dalla sabbia e dalla terra, emersero armature, papiri, ceramiche, gioielli. Furono trovate iscrizioni in una babele di lingue: per lo più greco, ma anche aramaico (nei tanti dialetti locali), parto e persiano non parto, latino, arabo-semitico ed ebraico. Ma la scoperta più sorprendente fu quella del più antico edificio cristiano di qualunque genere mai riportato alla luce: una cappella-battistero degli inizi del III secolo d.C., ben anteriore, quindi, all’adozione del cristianesimo da parte dell’impero romano sotto Costantino. Anch’essa era dipinta, seppure rozzamente; vi si vedevano scene sia del Nuovo Testamento, come la guarigione del paralitico e le tre Marie al sepolcro di Cristo, sia dell’Antico: storie che, come l’uccisione di Golia a opera di Davide, venivano lette come prefigurazioni della venuta di Cristo e della vittoria del Vangelo.
Il direttore del progetto Dura Europos a Yale, professor Michael Rostoftzeff, era convinto, e certamente sperava, che la scoperta di iconografia cristiana prebizantina avrebbe lasciato di sasso il mondo. Ma, con suo sgomento, il mondo, al di là dei reconditi giardini dell’archeologia accademica, non sembrò farci molto caso. Le grandi attrazioni erano ancora la Grecia e Roma, e i titoli dei giornali erano tutti per l’Egitto, archeologicamente colonizzato dai britannici. Che cosa poteva importare di cristiani dalla mente ristretta e privi di fantasia? Gli ebrei, be’, gli ebrei erano un’altra storia... Se solo, confidò Rostoftzeff a Clark Hopkins, la successiva stagione di scavi, la sesta, avesse dissotterrato a Dura Europos una sinagoga, l’importanza fondamentale del sito sarebbe finalmente stata compresa, e gli scopritori debitamente applauditi.
Ed ecco, venne il novembre 1933.
Un po’ malauguratamente, Hopkins paragonò la propria epifania all’esperienza di un incidente ferroviario in cui era rimasto coinvolto:
Non avevo alcun ricordo dei momenti trascorsi fra l’urto, che mi aveva sbalzato dal mio posto, e quando avevo iniziato a rialzarmi dal fondo della vettura rovesciata. Lo stesso vale per Dura. Tutto ciò che riesco a ricordare, mentre emergeva alla vista una pittura dopo l’altra, è un senso di stupore, di incredulità. La parete ovest era rivolta verso il sole del mattino che, sorto trionfalmente dietro di noi, aveva rivelato uno strano fenomeno. Benché fossero rimaste incastonate in quella polvere secca per secoli, le pitture murali mantenevano una vivida brillantezza che aveva qualcosa di quasi miracoloso ... Era stata strofinata la lampada di Aladino e all’improvviso, dall’arido, nudo deserto color marrone, erano apparsi i dipinti, e non uno solo, né un pannello, né un muro, ma un intero edificio, scene dopo scene, tutte tratte dall’Antico Testamento, una cosa che non avevamo mai sognato prima.1
Che si trovassero in una sinagoga, una delle più antiche a noi note, risalente ad appena un secolo e mezzo dopo la distruzione romana del Tempio di Gerusalemme, sembrava inconcepibile. Perché in quell’edificio c’era qualcosa di ignoto a qualsiasi altra sinagoga antica: dipinti. Tutte e quattro le pareti di una vasta stanza, il più grande locale pubblico dell’intera città, erano ricoperte, da un capo all’altro, dal pavimento al soffitto, di affreschi. Com’era possibile? Gli ebrei, non c’era alcun dubbio, non dipingevano, soprattutto non nei luoghi di culto. Esodo 20,4, ribadito da Deuteronomio 5,8, lo aveva categoricamente vietato: «Non ti fare scultura, né immagine alcuna delle cose che sono nel cielo in alto o sulla terra in basso». E quel divieto trovava eco nelle parole di rabbini e critici della cultura, nonché nell’opinione comune di gran parte del mondo gentile e del mondo ebraico. L’unica eccezione, si usava dire (nonostante una delle più ricche tradizioni di manoscritti miniati del mondo, fra cui libri di preghiera per tutti i giorni e per le feste e il Talmud), era l’Haggadah pasquale, di cui del resto non si conosceva una copia risalente a prima del X secolo né, ovviamente, una copia a stampa anteriore al XVI. Sembra strano, a posteriori, che ben pochi studiosi si fossero mai presi la briga di riflettere sul preciso significato del testo ebraico del secondo comandamento.
Quando esattamente l’idea che la Torah proibisse categoricamente la rappresentazione, in particolare di forme umane, divenne un luogo comune sia all’interno sia all’esterno dell’opinione ebraica è difficile dirlo. Ancora nel IV secolo d.C. autori e codificatori del Talmud interpretavano il secondo comandamento come una messa al bando limitata agli oggetti, per lo più tridimensionali, di idolatria. E per buone ragioni. Esodo 20,4 e Deuteronomio 5,8 usano, per designare ciò che è proibito, due termini ebraici: phesel e temunah. Il primo, da una radice che significa «scolpire», fa riferimento senza alcun dubbio non a dipinti o mosaici, bensì a figure sagomate – sculture e rilievi –, proprio la categoria di oggetti di culto, comuni nell’antico Vicino Oriente e nel mondo classico, che una religione con una divinità senza forma voleva allontanare da sé. Temunah è un termine più complicato: esso deriva infatti da min, che designa una specie, una classe di cose che hanno in comune identiche caratteristiche essenziali. Estendendone un po’ il significato, sembra che esso finisse con l’essere usato nel senso di «somiglianza» o «copia», più o meno nelle accezioni del greco eikon, e che quindi il divieto andasse inteso come riferito a «somiglianze» di cose esistenti «nel cielo» e «in terra», il che suggerisce fortemente, ancora una volta, oggetti sagomati di devozione idolatra. Il versetto dell’Esodo immediatamente successivo (20,5) rende chiaro che a renderli offensivi era la loro capacità di indurre a un vano culto.
Una celebre e bella aggadah (storia esemplare) del codice giuridico della Mishnah del II-III secolo d.C., nel trattato che parla di oggetti idolatri, rende esattamente questa distinzione fra ornamento accessorio e immagine devozionale. Il saggio patriarca Rabban Gamaliel si sta lavando nel «Bagno di Afrodite» a Tolemaide (Acri) quando un sapientone greco, Peroqlos (Pericle) Pelosepos, lo richiama per non avere obbedito alla prescrizione toraica di evitare i luoghi in cui sono presenti statue. «Non si danno risposte in un bagno» obietta il rabbino continuando a strofinarsi. Ma, mentre escono, tirando fuori la sua sagacia, gli dice: «Io non sono mai andato nel suo [di Afrodite] bagno. È lei che è entrata nel mio! Non si dice “facciamo un bagno come ornamento per Afrodite”, ma “facciamo un’Afrodite come ornamento per il bagno”». E, nel caso non avesse messo abbastanza in chiaro che, non essendo il bagno un tempio, nessuno può accusarlo di idolatria, aggiunge: «Anche se ti dessero molto denaro, tu non entreresti mai in un tempio nudo ... e nemmeno orineresti in sua [della statua] presenza. Invece [la statua] è lì ... e tutti le orinano proprio di fronte».2 Complimenti, rabbino. In una cultura in cui le statue erano ovunque, era ben difficile evitarle nella vita quotidiana.
Ma i dipinti di Dura non erano in un bagno; erano in una sinagoga in cui immagini e testo biblico vivevano inseparabilmente assieme come oggetti di devozione. La Torah stessa era circondata di immagini. Dalla parete sud, cioè quella rivolta verso Gerusalemme come avveniva ormai in tutte le sinagoghe, aggettava una nicchia ad arco fiancheggiata da colonne tortili «salomoniche», quasi certamente sul modello di quelle del paganesimo classico e orientale. Al suo interno c’era un ripiano in pietra. La moglie di Clark Hopkins vi si sedette per una fotografia, immaginando che si trattasse di una sorta di sedile o trono. Ma, se nelle antiche sinagoghe si trova qualche esempio di «cattedra di Mosè», quello era probabilmente proprio un basso ripiano. Nei templi pagani sarebbe stato usato come piedistallo per la statua della divinità venerata. A Dura, invece, la nicchia fungeva da Arca e su quel ripiano erano posti i rotoli della Legge. Alcuni fori praticati nel muro sopra la nicchia fanno pensare che vi fossero appese davanti delle tende, in emulazione diretta del «velo» color porpora che proteggeva la sacralità impenetrabile del Santo dei Santi nel Tempio di Gerusalemme. Le superfici piane dell’«Arca» erano decorate con immagini intese a rafforzare la memoria del Tempio distrutto e la fede nella sua ricostruzione (forse a opera dei persiani in arrivo che, del resto, ne avevano già permesso la ricostruzione molto tempo prima!). Un portico a colonne in secondo piano raffigurava il Tempio stesso, né mancava un candelabro a sette braccia, pittoricamente recuperato dalla sua prigione romana e dipinto di giallo per suggerire l’oro. Vicini c’erano i simboli delle feste di pellegrinaggio: le «quattro specie», foglia di palma, cedro, rametti di mirto e di salice, che si portavano tanto tempo prima a Gerusalemme per celebrare la festa dei Tabernacoli. E, come altrove nelle prime sinagoghe, c’era l’akedah: il «legamento» del figlio Isacco da parte di Abramo in obbediente preparazione al terribile sacrificio richiesto da YHWH come prova di fedeltà. I centoventi ebrei che potevano facilmente trovare posto nella sinagoga di Dura avrebbero così potuto cogliere la complessa importanza del sacrificio, scongiurato dalla mano tesa di Dio e dalla provvidenziale presenza, come alternativa, di un «montone impigliato con le corna in un cespuglio». Il culto del sacrificio animale nel Tempio (come il divieto di consumare sangue animale) era un’affermazione della ripugnanza per il sacrificio umano, ma l’atto di fede cieca di Abramo sarebbe stato ripagato dal suggello di un’alleanza fra YHWH e il Suo popolo, simboleggiata dal taglio del coltello sul prepuzio. Era stata fatta una promessa. Se gli ebrei, per quanto li riguardava, l’avessero mantenuta, allora la realizzazione dell’ulteriore promessa di un messia liberatore e salvifico e della ricostruzione del Tempio era certa. Ai margini dell’impero romano, insomma, nei dipinti della sinagoga veniva disfatto ciò che Roma aveva fatto a Gerusalemme.
È possibile che molti dei soggetti biblici lungo le pareti fossero stati scelti proprio perché recavano questo messaggio: la promessa di un riscatto finale. Due figure chiave di tale promessa, Mosè e Davide, sono raffigurate agli esordi del loro ruolo profetico. Davide è unto da Samuele che, come lui, indossa una toga e porta i capelli tagliati alla romana.
In un meraviglioso dipinto la figlia del faraone, in piedi fra le acque del Nilo, dove canne e giunchi sono indicati da brevi pennellate a ricciolo, porta in braccio il piccolo Mosè. È un’immagine, come si addice a un momento così fatidico, al tempo stesso naturalistica, umanizzata, e formalmente cerimoniale. La giovane, che dopotutto si è immersa nel fiume, non indossa nulla di più che un himation fattosi, bagnandosi, trasparente, in contrasto con le figure modestamente vestite della madre di Mosè, Jochebed, e della sorella di lui, Maria, che osservano ansiose alle sue spalle. Davanti alla principessa è la culla a dondolo, a immagine di una piccola arca, anch’essa tipica delle culle di quel tempo e luogo, in cui è stato trovato il bambino. Per nulla realistici sono i gesti a braccia aperte, espansivi, della principessa e del piccolo Mosè, che si echeggiano reciprocamente, quasi prefigurando una Madonna con Bambino, solo che, in questo caso, l’apertura è alla consapevolezza del destino che, da questo momento nelle acque, si dispiegherà. È un’immagine al tempo stesso formale e informale, ieratica e popolare, misteriosa e accessibile, letteraria e iconica. A essere un padre o una madre ebrei a Dura Europos, e recarsi con i propri figli in quella sinagoga, c’era molto da insegnare loro, indicando questo e quello nel dipinto.
I due pilastri umani della storia giudaica ricompaiono più e più volte: c’è Mosè al roveto ardente e, come spiega un’iscrizione in aramaico, «che fende il mare»; c’è Davide in trono che, come un Orfeo ebreo, incanta la creato , e che sconfigge i filistei.
Il principale patrono-benefattore della comunità di Dura, il primo Mecenate della diaspora, era un certo Samuele; da qui il rilievo dato al suo omonimo nell’unzione di Davide. Come accadeva spesso a quella data antica, la sinagoga (al pari delle cappelle cristiane dell’epoca) fu inizialmente aperta all’interno della sua casa. Samuele doveva essere abbastanza ricco da permettere l’ambiziosa espansione che seguì, che richiese la demolizione di muri esterni e la creazione di un bel tetto-soffitto impreziosito da piastrelle di ceramica dipinte. Ma, socialmente, gli ebrei di Dura dovevano essere, non diversamente da quelli di Elefantina di mezzo millennio prima, un gruppo misto. Come i loro antenati egizi erano soldati mercenari, artigiani e mercanti, e alcuni persino funzionari locali ed esattori fiscali, anche se, a differenza di Elefantina, fra di loro c’erano anche schiavi o ex schiavi trasformati in servitori dai conquistatori romani. Pochi, tuttavia, dovevano essere ignoranti in materia biblica, tanto più che c’erano quegli splendenti, brillanti affreschi a offrire loro lezioni pratiche. A Dura essi disponevano, grazie alle immagini, di una sinagoga e di un centro di studi giudaici riuniti nello stesso edificio: un Beit Hamidrash del popolo, scuola nonché luogo di preghiera, ma scuola visiva, accessibile, spontanea.
Per quelli che ne sapevano di più, ognuna di quelle scene bibliche ben selezionate doveva fare risuonare specifici messaggi di consolazione e speranza. La visione di Ezechiele in cui ossa aride tornano a nuova vita era una profezia del momento in cui la Gerusalemme morta sarebbe risorta. L’umiliazione del giudeofobo persiano Aman, costretto a guidare il cavallo di Mardocheo (benché dipinto in luminosi colori persiani in una mano che colpisce per la sua diversità da quella responsabile del ritrovamento di Mosè), procede in una versione leggermente ritoccata di un trionfo romano, mentre una splendente regina Ester, dalle pesanti sopracciglia, siede in trono dietro un re Assuero in pantaloni persiani. Anche questa era un’immagine di speranza immediatamente riconoscibile. Se il dipinto fu quasi certamente eseguito mentre le legioni romane stavano ancora tenendo i persiani a distanza, essa costituiva un evidente richiamo al ruolo storico di questi ultimi nella ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. Ai Sassanidi in ascesa piaceva affermare di rappresentare il Secondo Avvento dell’antica dinastia achemenide di Ciro, Dario e Artaserse, per cui, se avessero avuto la meglio, la festa di Purim avrebbe potuto ancora rivelarsi profezia oltre che storia. Tutto si teneva, passato e presente, lutto e festa, esilio e ritorno.
E tutto ciò nel 240 d.C.: all’inizio, o quasi, di ciò che le sinagoghe sarebbero state per una comunità della diaspora post-distruzione. Dura, per di più, era situata esattamente fra i due poli della cultura rabbinica, la Palestina e la Mesopotamia; impossibile, quindi, che la sua sinagoga dipinta fosse una sorta di aberrazione eretica, disapprovata dai saggi. Tutto fa pensare, al contrario, che fosse una sinagoga esemplare.
Essa era anche una risposta alle religioni vicine, non meno fiorenti a Dura, e, di conseguenza, è una testimonianza di come ebrei osservanti vivessero in mezzo a pagani e cristiani. Dirimpetto alla sinagoga si ergeva un tempio di Adone,...