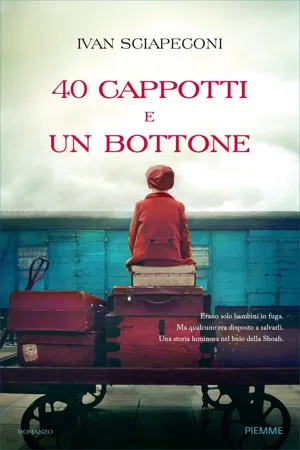«Natan, Natan caro, ricordi il mio amico Shlomo?»
«No papà.»
«Ma dai, come no? Quello senza denti, Shlomo l’ipocondriaco!»
«No, non lo ricordo.»
«Be’, è morto.»
«Mi dispiace.»
«Non fa niente. Non era neanche un vero amico. Lo sai che cosa ha fatto scrivere sulla sua tomba?»
«No papà.»
«IO VE L’AVEVO DETTO!»
Mio padre non sapeva che cosa sarebbe successo. Raccontava storie perché non lo immaginava neanche, che cosa sarebbe successo.
Io invece l’ho sempre temuto. Per questo corro. Non ho mai smesso, da quando sono nato. Sono corso fuori dalla pancia di mia madre appena ho potuto e lei non si è accorta di nulla.
Ha detto: «Eccolo» e io ero già là, tra le sue gambe. Mia nonna di bambini ne ha visti nascere tanti, ma con me non ha potuto prendere asciugamani e acqua calda. Non le ho dato il tempo.
Ho imparato a correre prima ancora di camminare. Spingevo con le mani e andavo. Mi trascinavo dietro il corpo. Poi ho puntato le ginocchia a terra. Sembravo un gatto, dicono. Quando mi sono messo in piedi, sapevo già come fare.
Ho corso per le vie di Charlottenburg. Passavo dalla vecchia Mizrachi, prendevo la cesta del pranzo e la portavo da zio Hermann. Correvo, contentissimo, anche per andare a scuola. Non sapevo che dentro ci avrei trovato la signora Meyer.
Sono corso alla finestra, quando ho visto i primi fuochi, tutto intorno a casa nostra. Era novembre, ma non era più freddo del solito. Non c’era alcun bisogno di accendere un fuoco così grande. Sono state le camicie scure.
«Perché?» ho chiesto.
«Perché hanno paura.»
Io non ho capito. Ero piccolo. Sono passati quattro anni da allora, quattro anni fanno la differenza.
«Ora sbrigati, vai a letto» ha detto mia madre.
Io corro, sempre, e nessuno è in grado di prendermi. Non è successo finora e non succederà mai perché io non mi fermo. Anche adesso che sono seduto, qui, in treno, in realtà sto correndo. Ho il fiato corto e il sudore alle tempie. I muscoli sono caldi. Al centro del petto sento il cuore battere. Il cuore fatica a stare al passo con il respiro. Batte forte, è strano che i miei vicini non se ne accorgano.
Tengo d’occhio la porta dello scompartimento. Ogni volta che si apre, il vagone si riempie di rumore. Sono pronto a rovesciare la valigia a terra. Le camicie scure non si muovono mai da sole. Se riesco a farne inciampare una, cadono tutte.
Mio padre ha smesso di ridere dopo gli incendi. Prima era un uomo divertente. A qualcuno capita un padre ricco, ad altri uno assente o severo. A me è toccato un padre divertente. Non avrei potuto chiedere di meglio.
Se ne stava seduto sulla poltrona di velluto verde, con i braccioli e il poggiatesta scoloriti dal tempo e dalle meditazioni del dopopranzo. In quei pomeriggi, dalla poltrona arrivava un sibilo lento e regolare. Io mi avvicinavo per studiare l’interno della sua bocca. Per vedere se nascondesse un meccanismo segreto, perché era da lì che uscivano le sue storie.
Quando non sonnecchiava, ascoltava la radio dei vicini.
«È una fortuna abitare in una catapecchia» diceva. «Lo sai? I ricchi hanno muri spessi che non lasciano passare i rumori. Pensa, sono costretti a comprare una radio per famiglia. I ricchi spendono un sacco di soldi, per essere ricchi. A noi invece basta avvicinare l’orecchio alla parete.»
E poi leggeva. Pile di libri appoggiati sullo sgabello o anche per terra, intorno alla poltrona, dove capitava. Leggeva di tutto, ma preferiva i romanzi d’amore e solo quelli che finivano bene. Le poesie invece no, le lasciava dov’erano. Ci aveva provato, ma non aveva mai trovato una poesia divertente.
Quando gli veniva in mente una storiella, un gioco di parole o una barzelletta, fermava tutto, e tutti si dovevano fermare.
«Non c’è da farle scappare le barzellette, ti fanno capire le persone come sono. Prendi tuo nonno, per esempio. Tuo nonno era ungherese e davanti a una barzelletta gli ungheresi ridono tre volte: la prima quando la sentono, la seconda quando la ripetono a qualcuno e la terza – ma questo solo dopo tanto tempo – quando finalmente l’hanno capita. Se invece la racconti al signor Mann, il vecchio del piano di sotto, che è un tedesco vero, tedesco da sempre, facci caso: lui ride solo due volte. La prima quando la sente e la seconda quando la racconta a qualcun altro. Poi basta, niente più. Perché lui la barzelletta non l’ha capita e non la capirà mai.»
Faceva così, mio padre: procedeva a tappe. E non c’era modo di sapere quanto poteva andare avanti, quanto durava lo spettacolo.
«I peggiori? Ah, i peggiori! I peggiori lo sai chi sono? I sovietici. I sovietici ridono una volta sola e solo quando la sentono, la tua barzelletta. Perché non c’è verso che la capiscano. E stai sicuro che non andranno mai a raccontarla in giro: un sovietico sa che è meglio farsi i fatti propri.»
Fine. Almeno in apparenza.
«E gli ebrei?» ho chiesto quella volta. «Noi ebrei quante volte ridiamo, papà?»
«Eh, noi ebrei, dici. Noi ebrei non ridiamo. Mai, ricordatelo. Nemmeno una volta. Perché noi ebrei le conosciamo già tutte!»
E a quel punto, quando arrivava in fondo, sì che rideva di gusto. Appoggiava entrambe le mani sulla pancia tonda e morbida e rideva. Le mani andavano su e giù, lottavano per tener fermo tutto il divertimento che aveva nella pancia.
Mio padre comprava e vendeva stoffe, ma non era per il suo lavoro che eravamo poveri. C’erano anche commercianti ricchi e c’erano commercianti di stoffe che semplicemente se la passavano meglio di noi. Noi no. Noi eravamo poveri, lo siamo sempre stati. Mio padre si rifiutava di ingannare gli altri, si rifiutava di seguire l’unica strada per guadagnare davvero. Con il lavoro non si diventa ricchi, non c’è mai riuscito nessuno. Con l’inganno sì, o con il cielo che ti fa cadere un dono dall’alto, ma non con il lavoro.
Da bambino aveva accompagnato sua madre da un rabbino. In quella circostanza, davanti all’uomo con la lunga barba bianca e gli occhi trasparenti, aveva capito che così sarebbe andata, che sarebbe rimasto povero. Il rabbino sembrava saggio anche a bocca chiusa e mio padre si era fatto coraggio, gli aveva rivolto una domanda. Aveva da poco litigato con un amico, una cosa stupida, da bambini, ma era un macigno pesante e non riusciva a liberarsene.
«Cosa devo fare, rabbi» aveva chiesto. «Come mi devo comportare…»
Il rabbino aveva risposto così: «Quello che ti è odioso, piccolo mio, non farlo agli altri».
Era una massima breve, semplice e rispettosa della logica. Poteva andar bene anche per uno poco attento alle cose dei santi, come mio padre.
Così, da quel giorno, gli era capitato di incontrare tanta gente e tutti, ma proprio tutti, finivano per ascoltare le sue storie buffe. Chi ride si fida, per questo aveva tanti amici in tutto il quartiere di Charlottenburg e anche fuori. Berlino ne era piena. Amici maschi, ci teneva a sottolinearlo, perché far ridere una donna è sempre pericoloso. «Ricorda, Natan: tutte vogliono un figlio da un uomo allegro, meglio evitare incomprensioni. Alle donne, solo storie tragiche. Prometti.»
«Promesso.»
«Bene.»
Mio padre passava il suo tempo per strada, con il carretto appoggiato di lato e gli amici che il caso gli consentiva di incontrare. Se la giornata andava così, poi tornava contento.
Molto meno contenta era mia madre, che faceva spesa a credito e rivoltava i vestiti per resuscitarli.
«I vestiti muoiono per sfregamento,» diceva «è questa la verità.» E poi protestava, spesso, specie all’ora di cena.
Diceva: «Eh, chissà che si prova a non dover contare i soldi prima di andare a far la spesa».
E lui rispondeva: «Nulla. Assolutamente nulla. Troveresti il modo di borbottare anche se fossi ricca come una regina, polpettina mia».
Mia madre si arrabbiava ancor di più, oppure faceva finta, perché lei lo aveva sposato per il suo modo leggero di vivere. Perché un animo leggero fa volare chi gli sta accanto. E anche perché le parlava dei libri che lei da sola non avrebbe mai letto e di quei libri conosceva a memoria le frasi più romantiche.
È andata così, per anni. Fino a quel mercoledì di novembre, quando sono corso alla finestra e ho visto le fiamme, in lontananza.
Il giorno dopo, il viso di mio padre era diventato pallido e rugoso. I pochi capelli in testa erano sottili come fili di una ragnatela rinsecchita dal gelo. Per tutta la notte, abbiamo sognato gli uomini con le camicie scure entrare e uscire dalle case, dai negozi, anche vicino a noi, a Charlottenburg. Io, mia madre e mio padre abbiamo fatto lo stesso sogno. Mio fratello Sami no, o comunque non ne ha parlato. Nel sogno, come nella realtà, quelli sono arrivati e hanno appiccato il fuoco a quanto ci faceva sentire più sicuri: sinagoghe, cimiteri, negozi. Tutto.
Hanno preso, frantumato, strappato, colpito, pestato, percosso, spinto, tirato, fracassato, trascinato, sferrato, lanciato. E bruciato.
A casa nostra non è successo nulla. Nulla di brutto. Nessuno è venuto da noi, nessuno ci ha minacciati. Eppure mio padre ha smesso di ridere.
Solo un quadro è caduto, inspiegabilmente, dalla parete che ci divideva dai vicini, quella che lasciava passare la voce della radio. Il quadro è caduto e ha lasciato un rettangolo scuro e umido. Mentre tutti quelli che conoscevamo piangevano devastazioni e incendi, noi avevamo visto un chiodo cedere spontaneamente e un quadro cadere. Solo questo.
Mio padre ha smesso di uscire di casa. È rimasto a fissare il rettangolo vuoto in mezzo a una parete che non parlava più. Era come se da quell’assenza e da quel silenzio si aspettasse di ricevere un segno, un suggerimento sulla cosa giusta da fare. Come se il quadro fosse lo spirito di un antenato su cui contare. La forza soprannaturale che ci avrebbe indicato la strada dall’aldilà.
Poi hanno bussato alla porta. Era notte, fuori era bellissimo. Bianco di neve e silenzioso: solo zoccoli di cavalli e ruote che scivolavano lungo la via. Eravamo già a letto, mio fratello Sami ha continuato a dormire, almeno all’inizio. Io ho sentito i colpi, li ho visti entrare. Erano quattro, uomini, due avevano un cappotto e gli stivali neri, gli altri non so. Ho visto solo i primi due, quelli davanti. Il resto è confusione. Uno urlava ordini, nessuno ci ha chiesto chi siete. Neanche noi l’abbiamo fatto. Hanno trascinato mio padre fuori, per strada, lo hanno caricato su un camion, a forza. Non che mio padre provasse a opporsi. Hanno fatto così perché così avevano detto loro di fare: erano i movimenti corretti, quelli che avevano visto e che cercavano di riprodurre. Un ballo, ecco.
Io ho urlato. Non è successo niente. Ho urlato di nuovo e ho continuato a urlare, per tutto il tempo. Urlo ancora adesso, nel sonno, specie se fuori nevica. Non c’erano angeli, quella notte, intorno a casa mia. A Berlino, o in qualsiasi altro posto. Solo finestre chiuse. E se qualcuno ha sentito, se qualcuno ha spiato da dietro le tende, non è stato per aiutare Salomon l’ebreo. L’omino che tanto li aveva divertiti con le sue storielle e le barzellette.
Ci siamo nascosti, abbiamo lasciato la nostra casa. siamo andati ad abitare al numero 13 della Lottumstrasse. C’erano altri disperati come noi, tutti insieme. Non siamo restati molto, abbiamo cambiato quasi subito e poi ancora e ancora. È così che sono passati i mesi e poi gli anni, almeno due. Forse tre.
Fino a quando hanno bussato di nuovo alla nostra porta. Mia madre mi ha fatto segno di star zitto. A mio fratello Sami ha messo una mano davanti alla bocca, lui è troppo piccolo per essere prudente da solo. Non c’era luce sul pianerottolo, chi ha bussato è salito al buio. Anche con mio padre hanno fatto così.
Una voce che non abbiamo saputo riconoscere ha pronunciato il cognome di mia madre, il cognome da ragazza.
Ha detto: «Sono qui per aiutarla…». Era una voce di donna, un sussurro lasciato passare tra la porta e il muro. Il primo spiffero dell’inverno che stava per arrivare.
«Sono Recha. Recha Freier. Non c’è tempo da perdere…»
Mia madre si è fatta ripetere quel nome che, ora lo so, ne sono certo, non sarà mai dimenticato. Poi ha aperto.
Quando la signora Freier è entrata, non si è seduta, è rimasta in piedi accanto alla porta e mia madre non ha usato nessuna delle sue cortesie. Non le ha chiesto il soprabito, non le ha offerto da bere. Ha solo ascoltato quello che c’era da ascoltare.
«La situazione è cambiata» ha detto la signora Freier. Ho capito che si conoscevano dal sì continuo con cui mia madre accompagnava le parole della signora Freier. Eppure non si erano mai viste prima, perché mia madre ha chiesto: «Come posso essere sicura? Lei potrebbe essere chiunque».
La signora Freier non si è stupita della diffidenza. Ci ha guardati con tenerezza, anzi, e ha risposto: «Loro non hanno bisogno di scuse. Non perdono tempo a discutere».
Lo sapevamo, l’avevamo già visto. Anche la signora Freier sapeva che sapevamo, ma non ha fatto riferimento a noi, a q...