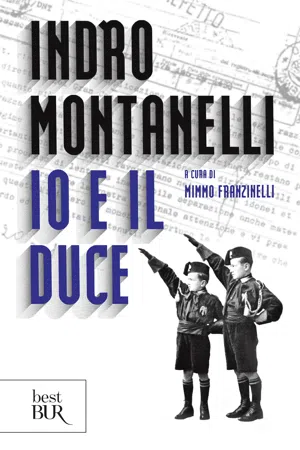![]()
PARTE PRIMA
Ascesa e caduta di Mussolini
![]()
Il giovane Benito
Quando sulla copertina di un libro leggiamo la parola «Mussolini», dentro di noi scatta immediatamente una soneria d’allarme. Sotto l’etichetta di questo nome si è fatto troppo contrabbando. Ma ad esser proprio sinceri, non so se contrabbandieri sono più coloro che scrivono o coloro che leggono.
Parlo, s’intende, o credo di parlare a nome degli uomini della mia generazione, gli ex figli della lupa; e la politica non c’entra. Sul piano ideologico, la nostra condanna del fascismo è ferma, risoluta, senz’appello, e solo qualche pazzo può sperare di rimetterla in discussione. Ma sul piano umano i nostri rapporti con Mussolini sono talmente complessi, sottili e sfumati che è molto difficile soddisfarne tutte le esigenze.
Credo che si tratti di questo, in sostanza. Mussolini apparve nella nostra vita quando i vent’anni ci mettevano a disposizione un grosso capitale di entusiasmi da investire. Era fatale che l’investissimo in lui. Oggi non è lui che rimpiangiamo. Ma rimpiangiamo quegli entusiasmi, che rappresentano ancora la parte migliore e più generosa di noi stessi. Non perdoniamo a Mussolini di averceli carpiti e sperperati. Ma nemmeno perdoniamo a chi cerca di ridicolizzarli, ridicolizzando Mussolini. Quanto ci avesse truffati, lo capimmo noi stessi, senza l’aiuto di nessuno, prima ancora che la sua catastrofe cominciasse. Ma non ci piace sentirci dire ch’era soltanto un truffatore. Un istinto di autodifesa, un bisogno di autogiustificazione ci spingono a rifiutare sia la sua caricatura che la sua apologia. La prima renderebbe spregevoli i nostri vent’anni, la seconda i nostri trenta. Come tutti i cornuti, vogliamo sentirci dire che siamo stati traditi da un Mussolini che però aveva le carte in regola per sedurci. Questo non accorcia le nostre corna, ma ne alleggerisce il peso. E spiega la soneria di allarme che ci scampanella in corpo, quando leggiamo il suo nome sulla copertina di un libro.
Ci è successo anche nel prendere in mano Il giovane Mussolini di Rino Alessi (Ed. Il Borghese, pagg. 257, L. 4000). Ma poche pagine son bastate a smontare la nostra diffidenza. Dice l’autore, in una concisa «Avvertenza»: «Questo è soltanto un libro di ricordi personali rifioriti nella memoria di uno che si sovvenne di essere stato, per tutto l’arco di una lunga vita, amico personale di Mussolini soltanto il giorno in cui l’esserlo stato divenne una colpa meritevole di punizioni politiche e di vendette personali».
Da quel che so di lui, mi pare che Alessi non menta. Giornalista di chiara fama era già prima del fascismo, e nient’altro che giornalista rimase per tutto il ventennio. Se in qualcosa la vecchia amicizia con Mussolini gli servì, fu nel consentirgli di dare al littorio un’adesione non senza riserve e condizioni come si vide al tempo delle leggi razziali, contro cui Alessi fu uno dei pochissimi a insorgere pubblicamente. Al gesto d’insubordinazione non pagò pedaggio: ma questa esenzione credo che sia stata il suo unico profitto di regime.
Mussolini non aveva molte tenerezze per i suoi vecchi compagni di gioventù e di scuola, forse perché con loro gli tornava più difficile fare la statua sul piedestallo e assumere le pose gladiatorie di cui si compiaceva. Un giorno tuttavia acconsentì a riceverli a palazzo Venezia, ma solo dopo averli tenuti per un pezzo in soggezione con uno sguardo intimidatorio, si decise a gratificarli di un sorriso e a chiamarli per nome. Però gli dette del voi, e non mantenne la promessa d’intervenire a un loro raduno nella Scuola Normale di Forlimpopoli, dove anche lui si era diplomato maestro.
Alessi, che fu per anni il suo vicino di banco, ce ne fornisce un’immagine che si discosta alquanto da quelle ricostruite sia dai suoi agiografi che dai suoi detrattori. Il nuovo allievo arrivò preceduto da una fama inquietante. Sebbene non avesse che undici anni, si era già fatto un nome accoltellando un suo compagno nel collegio salesiano di Faenza. Non c’è da meravigliarsi che fosse stato espulso. C’è da meravigliarsi, caso mai, che fosse stato ammesso alla Normale di Forlimpopoli. Sebbene si fosse in Romagna, dove il coltello fa parte dell’equipaggiamento di ordinanza, il precedente mise in allarme il direttore dell’istituto – ch’era Valfredo Carducci, fratello del poeta – nella stessa misura in cui incusse rispetto alla scolaresca. Benito se ne accorse, e ne approfittò per instaurare subito un piccolo culto della personalità. Ma questo gli riuscì perché di personalità realmente traboccava, e anche i condiscepoli più refrattari e protervi dovettero riconoscerla e inchinarvisi. Già allora teneva comizi citando autori e libri che non aveva letto. Ma nessuno reggeva il contraddittorio con lui. Un certo Compagnoni disse una cosa curiosa: «È soltanto un commediante. Però riesce a far recitare anche noi». Fu quello che poi doveva succedere a cinquanta milioni d’italiani.
Naturalmente è impossibile riassumere in due colonne di giornale un libro come questo, tutto fatti e aneddoti. Bisogna leggerlo. E non è tempo buttato via, perché secondo me rappresenta la testimonianza più attendibile, più genuina, più fresca che mai sia stata resa sull’uomo o per meglio dire sulla sua crisalide.
Alessi non lo vede né con gli occhi incantati del nostalgico né con quelli rancorosi dell’avversario. C’è solo, anche in fondo alle notazioni più negative, una sfumatura di tenerezza, di cui ci tornerebbe più difficile perdonare l’assenza. Si sente benissimo che anche lui, come tutto il resto della brigata, subì il fascino di quel demiurgo in erba dalle idee arruffate, che non sapeva quel che voleva, ma lo voleva subito, e riusciva a intimidire anche gl’insegnanti.
Nemmeno a quell’età, Mussolini conobbe gli abbandoni dell’amicizia, e non ne concesse a nessuno. Era indifferente agli uomini. A lui premeva soltanto il «pubblico», e non perdeva occasione per richiamarne attorno a sé. A una festicciola organizzata dalla scuola, il Carducci lo incaricò di leggere una commemorazione di Verdi concertata in precedenza. Ma Benito, lungi dall’attenersi al testo, non lo trasse nemmeno di tasca e, invece di parlare del musicista, parlò del ribelle che, nominato senatore, in Senato non ci aveva messo mai piede per non farsi complice dei detentori del potere borghese. In realtà non credo che il Maestro covasse di questi sentimenti protestatari e massimalisti. Ma a Mussolini, anche da ragazzo, tutto faceva brodo per pronunciare battute ad effetto, e infatti di effetto ne produsse parecchio sul povero Carducci e sulle autorità governative che presenziavano la cerimonia. Ma il pubblico lo applaudì calorosamente: e questo solo gli importava.
Un altro particolare Alessi rivela, che mi stupisce un po’: l’attaccamento di Mussolini al padre. Finora si era sempre detto che Benito non aveva nutrito per lui che disprezzo e rancore per i maltrattamenti a cui sottoponeva sua moglie. E invece pare di no. Benito amava molto sua madre. Ma per il padre nutriva una grande ammirazione. Ignorante, beone e puttaniere, Alessandro Mussolini aveva anche lui un certo piglio di arruffapopolo, in cui Benito si riconosceva. Da lui aveva derivato, oltre tutto, la propria mitologia, i cui posti d’onore eran tenuti da Orazio Coclite, Spartaco, Garibaldi e Amilcare Cipriani. E basta questo guazzabuglio di nomi a farci capire il guazzabuglio d’idee in cui fin d’allora annaspava: un po’ di Bakunin, un po’ di Marx, un po’ di Stirner, un po’ di Nietzsche, un po’ d’Ardigò, ma tutto orecchiato, di seconda mano e ridotto a libretto di melodramma.
Una cosa però aveva di autentico: la disperata ambizione del «mattatore». Questo cattivo conoscitore di uomini capiva la folla, al volo ne intuiva gli umori, con essa trovava subito una perfetta assonanza. Un commediante, senza dubbio. Ma specializzato in scene-madri e monologhi, e a tal punto immedesimato nella parte che, quando questa richiedeva le lacrime, riusciva a spremerne dai propri occhi di vere, come credo che sia capitato soltanto alla Duse. Si accendeva dei suoi propri furori, per autocombustione. Nel momento in cui le pronunciava, credeva nelle proprie menzogne. Non viveva di sé. Viveva, da vero attore, della propria immagine riflessa negli occhi degli altri, pronto a sacrificare al proprio «personaggio» anche le idee che non aveva. Forse, se ci fosse stato un pubblico a guardarlo, avrebbe trovato anche la forza di morire da eroe. Il suo vero dramma, il suo grande castigo fu di dover cadere dietro le quinte, senza poter fare anche di questo una scena madre.
Il delinearsi di questa vocazione gladiatoria, nel libro di Alessi risulta chiaro e senza contaminazioni polemiche. Alessi non condanna e non assolve. Racconta. Anche lui è un cornuto di Mussolini, anzi un precursore perché lo fu a undici anni. Ma erano compagni di scuola, entrambi romagnoli, entrambi figli di povera gente, entrambi socialisti. Traditore o no, Mussolini resta per lui, molto più che per noi, soprattutto questo: l’adolescenza, l’amore di una stagione fatta per l’amore.
![]()
La Marcia su Roma: colpo di Stato per telefono
La marcia su Roma fu soltanto un «bluff» ed ebbe successo non per merito degli squadristi, ma per demerito di coloro che non seppero impedirla. All’irresolutezza di Facta si era contrapposta l’abilità di manovra del «Duce». Il re su tutte le furie all’annuncio dello stato d’assedio deciso senza interpellarlo. Anche in quella occasione storica il fascismo non fu un’alternativa alla democrazia, ma si limitò a seppellirla.
D’Annunzio, il Vate
Il 28 ottobre era un sabato, pioveva come Dio la mandava, e le 40 o 50 mila camicie nere concentrate a Monterotondo, Santa Marinella e Tivoli, infreddolite e affamate, non sapevano se avrebbero marciato o no. Non lo sapevano nemmeno i loro tre comandanti di colonna, Bottai, Igliori e Perrone Compagni. Non lo sapeva il Quadrumvirato che da Perugia guidava, o meglio avrebbe dovuto dirigere l’operazione. Non lo sapeva neppure Mussolini, che si limitava a seguirla, e piuttosto distrattamente, da Milano.
La decisione era stata presa solo quattro giorni prima. E due dei quattro Quadrumviri, De Bono e De Vecchi, ch’erano anche militari, avevano protestato che per una mobilitazione quattro giorni erano troppo pochi. Ma Mussolini, spalleggiato dagli altri due – Balbo e Bianchi – aveva risposto: «Si tratta di fare una rivoluzione, non di sfilare in parata».
Era la prima volta ch’egli dava esempio di risolutezza. Anzi, dopo il successo ottenuto alle ultime elezioni che avevano mandato alla Camera 35 deputati fascisti, sembrava così disposto a inserirsi nel «sistema» e ad accettare le regole del giuoco parlamentare che due dei suoi più impazienti luogotenenti – Balbo e Grandi – avevano deciso di abbandonarlo al suo destino e di rivolgersi a D’Annunzio perché prendesse lui la testa del movimento. So di rivelare un episodio piuttosto inedito, ma di cui uno dei protagonisti sopravvive e può rendere testimonianza.
I due andarono a Gardone nel luglio del ’21 per esporre il loro piano al Vate. Vestito nel solito saio francescano, questi li ascoltò con benevolenza, meditò a lungo, e alla fine disse: «Prima di darvi una risposta, devo interrogare la stella Diana. Tornate domani». L’indomani essi tornarono, ma il Vate gli fece riferire che la stella Diana era rimasta coperta dalle nuvole, bisognava aspettare un’altra notte. Il dilatorio responso si ripeté per quattro giorni. Al quinto, i visitatori persero la pazienza, partirono per Milano e raccontarono tutto a Mussolini.
Questi seguitò tuttavia a tergiversare per molti mesi, sebbene gli squadristi fossero ormai padroni delle piazze, le forze armate e quelle di polizia fraternizzassero con loro e il regime desse segni sempre più evidenti d’impotenza. Quanto deteriorata fosse la situazione, lo dimostrò nel luglio del ’21 il totale fallimento dello sciopero generale di protesta indetto dall’Alleanza del Lavoro. I suoi stessi promotori – Turati, Treves, Prampolini – lo definirono «la Caporetto dell’antifascismo». Eppure, nemmeno questo fiasco vinse le riluttanze di Mussolini al gesto di forza. Come Paolo Monelli ha ricordato, Balbo si vantava di essere stato lui a imporglielo, e probabilmente lo diceva in piena buona fede. In realtà, a vincere le sue esitazioni fu ben altro.
Nell’agosto del ’22 si riunirono a Gardone alcuni fedeli di D’Annunzio, guidati da Alceste De Ambris, sindacalista e legionario fiumano, per proporre al Vate di divorziare decisamente da Mussolini, che con la scusa dei «blocchi nazionali» stava attirando sotto le proprie bandiere gli ex combattenti. Il piano era questo: il 4 novembre, anniversario della Vittoria, i reduci avrebbero indetto una grande adunata a Roma. Il Poeta li avrebbe arringati, ed essi gli avrebbero conferito il compito di ristabilire l’ordine. Insomma, una «marcia» che prevenisse quella fascista.
Stavolta il Vate trovò superfluo interrogare la stella Diana. Furente con Mussolini, di cui aveva compreso il subdolo giuoco, si disse pronto a una «dittatura» di tre mesi, al termine dei quali avrebbe restituito il potere alla democrazia per tornarsene a Gardone in veste di Cincinnato, salvatore della patria. A chi gli chiedeva cosa sarebbe stato del Re, rispose: «Non m’interessa. Inutile sostituirlo col Duca d’Aosta. Sono due imbecilli...».
Come in Italia tutti i segreti, anche questo fu presto risaputo, e preoccupò vivamente Mussolini. Sul piano politico, e forse non soltanto sul piano politico, egli disprezzava D’Annunzio. Ma non disprezzava affatto l’ascendente ch’egli seguitava a esercitare e le forze che potevano trovare in lui l’elemento di coagulo. A Gardone non andavano soltanto i dannunziani. Ci andava Orlando, il Presidente della Vittoria. Ci andava Lusignoli, il fiduciario di Giolitti. Ci andavano anche parecchi fascisti. Stava per andarci perfino l’arcinemico Nitti, l’ex-Cagoia. E tutto questo faceva pensare che lo stesso governo cominciasse a vedere in lui il contraltare di Mussolini, l’ultima àncora di salvezza.
Fu proprio mentre s’intensificava questo andirivieni che il Vate ruzzolò misteriosamente dalla finestra. Quando rinvenne, Mussolini era al suo capezzale con l’offerta di un nuovo patto di alleanza. Non si è mai saputo con esattezza cosa si dissero i due uomini nell’incontro dell’11 ottobre. Secondo qualcuno, il Poeta fu sottoposto a un vero e proprio «lavaggio del cervello» condito anche di minacce. Ma questo è poco credibile. Mussolini comprò la neutralità del suo rivale con le lusinghe e soprattutto con la promessa di mettere al riparo dalle squadre fasciste il capitano Giulietti. Giulietti era un estroso e impetuoso sindacalista che aveva organizzato una potente «Federazione del Mare», aveva fortemente contribuito col suo naviglio all’impresa di Fiume e da allora era sempre rimasto sotto l’ala protettrice del Poeta. I due si lasciarono con questo reciproco impegno: Mussolini avrebbe rispettato Giulietti e la sua organizzazione, D’Annunzio avrebbe rinunziato all’adunata di Roma. Parlando di lì a una settimana con Cesare Rossi, Mussolini gli disse: «I punti neri della situazione sono D’Annunzio e il Re». E appunto per non dar tempo a D’Annunzio di farne qualcuna delle sue, convocò lo stesso giorno 16 ottobre Balbo, De Vecchi, De Bono, Bianchi e due generali fascisti, Fara e Ceccherini, e l’incaricò di studiare un piano per l’occupazione di Roma, entro la fine del mese. Fu per questo che quando De Bono e De Vecchi chiesero una dilazione si arrabbiò, ma senza dire quello che veramente pensava, e su cui ormai ci sembra non sussistano più dubbi: e cioè ch’era prima del 4 novembre che occorreva non marciare, ma fare qualcosa che prevenisse altre marce.
Il «via» a questo qualcosa fu dato il 24 a Napoli, dove in occasione del Congresso del Partito convennero da ogni parte d’Italia 60 mila camicie nere. Lungi dall’impedirla, il governo aveva facilitato l’adunata mettendo a disposizione anche dei treni speciali. Come uniformi e disciplina, erano una specie di armata Brancaleone, in cui faceva spicco la «cavalleria» di Caradonna: una cinquantina di butteri pugliesi a bordo di altrettanti brocchi. Ma la sfilata con làbari e gagliardetti fu insieme un gesto di sfida e una dimostrazione di forza che la folla salutò con fiori e battimani.
Mussolini tenne due discorsi. Uno al teatro San Carlo, gremito dalla Napoli borghese e benpensante, cui si presentò come il difensore della legalità e il restauratore dell’ordine, riscuotendo grandi applausi anche da Benedetto Croce. L’altro in piazza del Plebiscito, dove salì sul podio con una vistosa sciarpa giallo-rossa (i colori di Roma) e arringò i gregari su tutt’altro registro: «Prenderemo per la gola la vecchia classe dirigente italiana» eccetera. E questo «doppio binario» rimase da allora la sua regola.
La sera riunì all’Hotel Vesuvio lo stato maggiore e impartì le seguenti direttive:
In tutta Italia le squadre dovevano essere messe in preallarme il 26. Il 27 sarebbe cominciata la mobilitazione. Alla mezzanotte dello stesso giorno il partito avrebbe ceduto tutti i poteri a un Quadrumvirato composto da Bianchi, De Vecchi, De Bono e Balbo, che avrebbero posto il loro quartier generale a Perugia. Il 28, in tutte le città, si doveva procedere all’occupazione di prefetture, questure, stazioni ferroviarie, centrali telegrafiche e telefoniche, camere del lavoro, giornali, circoli antifascisti. Subito dopo, concentramento delle squadre a Tivoli, Santa Marinella e Monterotondo e «scatto sincrono delle tre colonne sulla Capitale». Impartiti questi sommari ordini, Mussolini ripartì per Milano, lasciando al segretario del partito Bianchi il compito di sbrigare il congresso, diventato ormai del tutto superfluo.
Grandi costretto a rigar dritto
L’unico che tentò di aprire una discussione fu Grandi che, rientrato precipitosamente da Ginevra, si trovava di fronte al fatto compiuto e non intendeva accettarlo. Balbo, ch’era suo amico fraterno ma lo sapeva ostile alla marcia, lo aveva fatto nominare capo di stato maggiore del Quadrumvirato. «Così righerai dritto» gli disse. Ma Grandi volle ugualmente prendere la parola. «Perché ricorrere a una soluzione di forza – disse pressappoco –, che può spaccare il Paese, mettere le istituzioni in crisi e noi alle prese con l’esercito, quando ormai l’Italia è nostra? Costringiamo invece il governo alle elezioni.» Le sue parole caddero in un silenzio glaciale, e Bianchi strozzò la seduta con questa frase: «A Napoli ci piove, che ci stiamo a fare? Io vado a Roma».
Mentre tutto questo avveniva, Facta telegrafava al Re in vacanze a San Rossore: «Credo ormai tramontato il progetto della marcia su Roma». Facta era in carica da otto mesi. C’era arrivato per anzianità. Da trent’anni sedeva alla Camera, e la sua carriera la doveva a Giolitti di cui era un fedelissimo. La sua misura era quella di un bravo e onesto notabile di provincia, della provincia piemontese, devota alla dinastia e ai bilanci in pareggio. I colleghi e i giornalisti lo chiamavano «l’onorevole Nutrofiducia» perché questa era la formula con cui, anche nelle più gravi emergenze, chiudeva i suoi pallidi interventi, e nemmeno ora si smentiva.
Ma il 26, via via che sul suo tavolo si accumulavano i dispacci dei Prefetti che concordemente segnalavano i movimenti delle squadre fasciste, anche il suo proverbiale ottimismo venne meno. Non era uomo da tempeste, e anche se lo fosse stato, non avrebbe avuto i mezzi per farvi fronte. Nel governo di cui era a capo c’erano degli uomini di valore come Amendola, Soleri e Taddei, ma esso si reggeva su un labile compromesso fra liberali, democratici e «popolari» di Don Sturzo, minati da lotte interne personali e di corrente. Quanto all’opposizione socialcomunista, nemmeno i manganelli fascisti erano riusciti a ridurne il demagogico e parolaio massimalismo. Chiusa in una «conte...