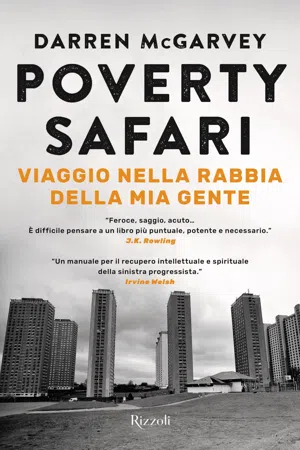Le donne entrano in fila indiana nello spazio dedicato alle arti performative, indossano tutte casacca viola e pantaloni della tuta grigi. È importante salutarle con sicurezza, guardarle negli occhi e porgere loro la mano, stando però attenti a non dare troppo a vedere se il gesto non viene ricambiato. Quando entra l’ultima di cinque, l’uomo alto e robusto in uniforme che le ha accompagnate fin qui si chiude rapidamente la porta alle spalle. Dopo essersi accertato che lo spazio è sicuro, raggiunge il suo collega in una sala di controllo sul retro, e io invito le donne ad accomodarsi sulle sedie disposte in cerchio davanti a una lavagna su cui ancora non c’è scritto niente.
Il centro per le arti performative, situato nel cuore del carcere, è veramente notevole. È un teatro pienamente funzionante che fa anche da sala prove e spazio per concerti, e può essere inoltre utilizzato per laboratori, seminari e proiezioni cinematografiche. L’ambiente è fresco e buio e, quando entri, ti colpisce subito il contrasto con il resto dell’edificio che, a seconda di dove ti trovi, è tutto grigio o bianco. In un angolo c’è una selezione di strumenti musicali, il più gettonato è la chitarra acustica. Sopra il piccolo palco rialzato, situato, entrando, in fondo alla sala, è montato un modesto impianto luci sotto il quale si trova quello acustico con diverse casse. Non ho mai visto niente di simile in una struttura pubblica. Di solito un equipaggiamento del genere si noleggia ma, per ovvie ragioni, in questo caso sarebbe piuttosto complicato: quando varchi il cancello principale della prigione ti sembra di attraversare la dogana. Anche il personale che lavora qui tutti i giorni deve sottostare quotidianamente ai medesimi controlli di sicurezza, sia in entrata che in uscita. Se sei un collaboratore esterno come me, è un’esperienza che ti può intimidire e mettere a disagio, specialmente se hai già avuto a che fare con la polizia o con il sistema giudiziario in altre circostanze. Arrivare in sala prove allevia un po’ della tensione palpabile che si respira in un ambiente oppressivo e potenzialmente ostile come questo, anche se bisogna dire che basta tornarci un paio di volte di seguito per farci l’abitudine e per cominciare a viverlo come un posto normale. Immagino che una buona parte delle donne che partecipano al mio workshop di rap si sia iscritta soprattutto per passare qualche ora qui dentro. Nel contesto della prigione, è una specie di oasi, e se durante una visita ti portassero solo qui, molto probabilmente non ti accorgeresti nemmeno di essere in un carcere.
Dopo aver fatto due chiacchiere banali sullo spazio, giusto per rompere il ghiaccio, provo a cominciare sul serio anche se, devo ammetterlo, mi sento piuttosto insicuro.
«Secondo voi, perché sono qui?» chiedo. Come prima mossa è efficace, l’ho già sperimentato altre volte, perché, sebbene sembri una domanda vaga e fin troppo semplice, in verità svolge diverse funzioni simultaneamente. Innanzitutto, mi leva immediatamente di dosso l’onere di essere io a dover parlare per primo; il che già di per sé torna utile, oggi in modo particolare, visto che non mi sono preparato come avrei dovuto. O meglio, visto che ho sottovalutato lo spaesamento che avrei provato trovandomi davanti un pubblico così diverso dal solito. Impreparato e confuso, rischio di incasinare inutilmente quella che, in realtà, dovrebbe essere una semplice introduzione.
La domanda: «Perché sono qui?» mi fa guadagnare qualche minuto prezioso per ritrovare il bandolo della matassa e per calmarmi, e mi serve anche a mascherare l’impreparazione e l’ansia. Svolge, però, anche un’altra funzione, molto più utile che salvarmi la pelle, ed è per questo che la uso sempre. La domanda: «Perché sono qui?», se viene raccolta, crea il potenziale per un’interazione che può aiutarmi a conoscere i partecipanti al workshop molto più in fretta di quanto accadrebbe altrimenti. Osservando le interazioni che stimola tra i miei interlocutori, riesco a cogliere le tipologie umane, le capacità comunicative e i modelli di apprendimento delle persone che ho davanti, così come le gerarchie all’interno del gruppo. E capisco cosa si aspettano da me, ammesso che si aspettino qualcosa.
In questa circostanza specifica, mi trovo in un carcere minorile pensato per accogliere ottocentotrenta ragazzi ma che in verità ne ospita di più. La maggior parte dei detenuti ha tra i sedici e i ventun anni. I detenuti o, come li chiamano in gergo, gli YO (Young Offenders), sono suddivisi in base all’età e al tipo di crimine commesso. C’è anche una sezione per chi è in attesa di giudizio, vale a dire chi deve ancora comparire in aula ma per cui il giudice ha deciso di applicare la custodia cautelare. Si riconoscono per il colore della maglietta che di solito è rossa. Quella degli altri è blu scura. Chi ha commesso reati di natura sessuale e chi è “sotto protezione” viene tenuto lontano dal resto della popolazione carceraria, per garantirne l’incolumità. Il regime di protezione è concesso a chi ha ricevuto minacce, a chi si sente in pericolo e a chi “ha cantato”. Ma siccome tutti questi sono segregati assieme a chi ha commesso reati di natura sessuale, anche loro vengono, per estensione, accomunati ai pedofili. Non si fa distinzione fra chi “canta” e chi commette reati sessuali. Per molti “non cantare” è l’ago della bussola morale: dare alla polizia informazioni che portano all’arresto di un’altra persona è considerato il crimine più infame.
La carenza di spazio dovuta al costante aumento dei detenuti fa sì che molti giovani che devono scontare condanne a breve termine per reati minori, come possesso di droga o taccheggio, siano messi gomito a gomito con i criminali più violenti, alcuni dei quali scontano condanne a lungo termine per omicidio, o tentato omicidio. La contaminazione tra criminali violenti e non violenti contribuisce ad accrescere il potenziale per ulteriore violenza, che in prigione è già elevatissimo. Ironia della sorte, i rei di crimini a sfondo sessuale sono i meno aggressivi e i più collaborativi di tutti, e il contrasto tra loro e gli altri detenuti è impressionante.
In un ambiente simile, la minima controversia può facilmente sfociare in brutalità. Le prigioni, sebbene siano pensate per la riabilitazione, oltre che per la punizione, sono di gran lunga il luogo più feroce della nostra società. La violenza è talmente pervasiva che basta anche una breve permanenza per venirne trasformati e deformati, ed è per questo che i carcerati tendono ad adattarvisi in fretta. Alcuni lo fanno diventando loro stessi più aggressivi e violenti, altri assumendo droghe come Valium, eroina, o, più di recente, Spice. Per i carcerati, però, la situazione non è così scioccante quanto può esserlo per chi la prigione la visita solo occasionalmente. L’aria da polveriera che si respira non fa che rispecchiare quella dei quartieri e delle case in cui molti detenuti sono cresciuti; luoghi dove le manifestazioni di violenza sono talmente frequenti da non essere più nemmeno avvertite come straordinarie: ci si scherza sopra e se ne parla più o meno come si parla del tempo.
Alcuni mesi fa, in mensa, un detenuto è stato sfregiato durante una lite per un pezzo di toast. In un clima così ostile, spesso la violenza è non solo una dimostrazione pratica di forza bruta, ma anche una forma di comunicazione. Chi non accetta lo scontro diventa presto oggetto di ulteriori minacce e affronti perché si è mostrato vulnerabile. Sfregiare qualcuno per un pezzo di toast può sembrare un atto bestiale, insensato e barbarico, ma in quest’ottica perversa può anche essere un tentativo di prevenire ulteriori aggressioni. È difficile che a qualcuno venga voglia di infastidire un tizio che è capace di sfigurarti per un pezzo di pane, e questa logica, costantemente all’opera nelle comunità violente, riguarda tanto la sopravvivenza quanto l’onore e la reputazione. Di fatto, l’onore e la spavalderia non sono che l’estensione sociale di un istinto di sopravvivenza più profondo. Indipendentemente dal contesto, la violenza svolge sempre la medesima funzione: non solo pratica, ma anche performativa, e volta tanto a eliminare la minaccia diretta quanto a tenere alla larga altri potenziali aggressori. Non tutti quelli che arrivano qui sono violenti, ma è difficile non diventarlo una volta dentro. Spesso escono di prigione più cattivi di quando ci sono entrati. Lo stesso vale per i problemi di droga, che di frequente aumentano sensibilmente quando la realtà della vita dietro le sbarre comincia a farsi sentire.
In generale, le donne sono meno brutali. Il gruppo di stamattina è stato trasferito qui a seguito della chiusura dell’unico carcere femminile di tutta la Scozia, Cornton Vale, che aveva un costo di mantenimento di dodici milioni di sterline l’anno e ospitava quattrocento detenute, minori comprese. Nel 2006, il novantotto percento delle detenute di Cornton Vale aveva problemi di droga, l’ottanta percento soffriva di disturbi psichici e il settantotto percento aveva alle spalle storie di abusi sessuali.
Sebbene ora si trovino in una struttura adibita alla riabilitazione di minori di sesso maschile, loro sono donne adulte. Alcune sono madri sole i cui figli, fuori dal carcere, vivono sotto la tutela di parenti o di istituti pubblici. Forse alcune di loro stanno pensando proprio a questo, mentre fissano il vuoto, confuse dalla mia domanda.
Devo ammettere che ho iniziato i miei workshop meglio di così. A volte riesco a uscire al volo dall’impasse dei primi scambi e a catturare immediatamente l’attenzione generale, ma stavolta mi sento inibito dalla stessa insicurezza che mi sembra di intravedere in loro. Faccio notare che non sono obbligate a rispondermi, ma dentro di me spero vivamente che lo facciano. Se qualcuna prendesse l’iniziativa, potrei capire qualcosa di essenziale su di lei e, di conseguenza, sull’intero gruppo. Per esempio, c’è chi alza la mano per chiedere la parola, e questo, a seconda del contesto, può essere indice di buona educazione o di sottomissione all’autorità. C’è chi comincia a parlare prima ancora che tu finisca la domanda, e questo può essere indice di entusiasmo, fiducia in se stessi, o della necessità di marcare bene il territorio. In ogni caso, è sempre meglio non trarre conclusioni affrettate in base al comportamento iniziale di qualsiasi gruppo o individuo. Se qualcuno ti interrompe in continuazione, può essere che abbia problemi di udito o difficoltà di apprendimento. Chiaramente, non posso evitare di avere dei pregiudizi, ma posso comunque scegliere di prenderli in considerazione, pur senza applicarli: rivelano qualcosa di me tanto quanto del soggetto con cui ho a che fare.
Quando conduco una conversazione in un ambiente carcerario, cerco di considerare valida qualsiasi forma di comunicazione verbale, quantomeno all’inizio. Evito di imporre regole troppo in fretta, almeno finché non ho raccolto alcune informazioni basilari sui miei interlocutori. Ciò che cerco di fare in questi primi momenti è costruire un rapporto, basato sul rispetto reciproco, che spero possa poi facilitarmi l’accesso al gruppo. E il modo migliore è riconoscere ogni persona in quanto individuo dotato di iniziativa.
La domanda: «Secondo voi, perché sono qui?» crea un’atmosfera di scambio e funge anche da dichiarazione di intenti. La maggior parte di queste donne (e della popolazione carceraria in generale) è abituata a ricevere ordini da figure autoritarie che esercitano un potere su di loro e ne è condizionata. Benché questo sia normale in un contesto carcerario, accade spesso che chi è in posizione di comando, col tempo, smetta di ascoltare davvero chi finisce per considerare socialmente o professionalmente inferiore. Tra l’autorità e chi vi è sottoposto si apre così un baratro che si colma facilmente di incomprensioni proprio nel momento in cui una delle due parti cerca di superarlo. Per questo la gente tende a chiudersi in se stessa e a conformarsi al proprio ruolo, indipendentemente dal fronte su cui si trova.
Cominciando il mio workshop con una domanda, dichiaro che queste dinamiche sono temporaneamente sospese, che il consueto rapporto di potere è stato interrotto. Invece di avere io tutte le risposte, in virtù del mio status più elevato, comunico che senza il loro input io non so nulla. Facendo loro questa domanda, sto riconoscendo il valore della loro esperienza e della loro intuizione.
«Tu sei quel rapper pazzo» dice una donna che ha una serie di cicatrici auto inflitte lungo tutto il braccio.
«Siamo qui per scrivere canzoni» dice un’altra, strascicando le parole in un modo che indica uso di metadone o sedativi.
A ogni risposta riesco a farmi un’idea sempre più chiara delle persone con cui sto per mettermi a lavorare.
«Esatto» rispondo io, prima di chiedere a ognuna di loro come si chiama e poi dare alcune informazioni basilari su di me, come faccio sempre attraverso una breve performance rap. La canzone che uso s’intitola Jump e l’ho scritta apposta per catturare velocemente l’attenzione dei gruppi, il che è cruciale quando lavori con persone che faticano a concentrarsi e che hanno una scarsa autostima. Prima sentono di aver capito con chi hanno a che fare, meglio è. Prima capiscono che quello che faccio le riguarda, meno è probabile che si ribellino o si chiudano nell’apatia. Prima vengono coinvolte dal libro, più troveranno difficile metterlo giù.
L’ansia o la paura associate a un’attività o a un compito si manifestano spesso sotto forma di svogliatezza o di ribellione. Nel corso degli anni, ho imparato diversi trucchetti per tenere la gente sintonizzata. Uno è dire una cosa positiva su di loro. Ogni interazione è importante perché offre la possibilità di capire qualcosa dei partecipanti. Questo approccio funziona al meglio quando dimostri di saper riconoscere determinate abilità o caratteristiche personali che già possiedono e che non devono imparare da altri. È più difficile chiamarsi fuori quando si ha qualcosa da perdere. Fare apprezzamenti sulla calligrafia di una persona, sul suo senso dell’umorismo, su un’osservazione interessante che ha fatto, o magari su una particolare espressione che ha utilizzato può portare molto lontano. Per quelli che non parlano, ci si può focalizzare invece su un tatuaggio curioso, o su un bell’abbinamento di colori nei vestiti. Sono tutti indici di profondità, di ricchezza interiore e di spirito d’iniziativa che meritano di essere sottolineati. Nel mondo della prigione, le piccole cose hanno un peso enorme, e come qualcuno può sfregiarti per un pezzo di toast, la giornata di qualcun altro può svoltare completamente anche solo grazie a un piccolo scambio di gentilezze.
«Hai una bella scrittura, molto ordinata.»
Nel momento stesso in cui fai un commento positivo, non importa quale, chi lo riceve istintivamente tenderà a scansarlo, per riaffermare una visione negativa di se stesso che gli è più familiare.
«Sì, certo, una bella scrittura io. Ma va. Sono stupida, non so scrivere.»
Se fai attenzione però, ti accorgi che non appena la persona cui hai rivolto il complimento crede che tu non la stia guardando, ecco che s’illumina. Se è una giornata buona, può darsi che più tardi ci torni su e si azzardi persino a pensare che quanto le hai detto possa essere vero. È questo genere di interazione che crea la chimica necessaria a instillare fiducia nel gruppo e che rende possibile una comunicazione profonda tra te e i partecipanti.
Chi ha difficoltà di apprendimento dovute a una scarsa alfabetizzazione o a una bassa considerazione di sé, in genere – ma non sempre –, proviene da un ambiente nel quale le sue capacità non vengono riconosciute e coltivate, e per questo fatica a correre rischi. Anche solo leggere ad alta voce, o esprimere un’opinione qualsiasi, può intimorire e frustrare un gruppo come quello di oggi. Di conseguenza, se vuoi incoraggiare qualcuno a uscire dalla propria zona di sicurezza, devi tenere le antenne ben alzate per riuscire a captare di cosa abbia bisogno. Per chi finisce in prigione è ancora più dura: le sue doti vengono soppresse, ridicolizzate o attivamente scoraggiate, e diventano motivo d’imbarazzo e di vergogna. Si fa presto a sviluppare la tendenza a celare quelle parti di sé che rivelano vulnerabilità, e a convincersi di essere stupidi. Se una lezione comincia in modo insoddisfacente, le persone perdono subito interesse, dando per scontato che sono loro a non essere abbastanza intelligenti, anche quando in realtà il problema nasce da un operatore impreparato come me. La convinzione inveterata che sono loro a non essere all’altezza si traduce spesso in un atteggiamento provocatorio, distruttivo o aggressivo, il cui scopo principale è prevenire l’interazione, perché questa potrebbe far emergere le loro paure, il loro senso di inadeguatezza o la loro vulnerabilità.
Jump, la canzone che uso per rompere il ghiaccio in queste situazioni, comincia così: “Crescendo, non sapevo mai di chi fidarmi, il mondo lo guardavo dal pulmino della scuola, con in bocca una grossa caramella; non era male andare a scuola, mi faceva uscire di casa”.
Il testo è autobiografico, parla dei miei anni di scuola e della morte improvvisa di mia madre, ed è scritto in un linguaggio basso, infarcito di immagini prese dalla vita dei quartieri poveri, con riferimenti a vini scadenti come l’MD 20/20 e il buckfast, e a rapper come Tupac Shakur. Famiglie in pezzi, abbandono, alcolismo e lutto sono temi che, uniti a una presa in giro della classe media e delle forze dell’ordine, riflettono le esperienze dei carcerati e, soprattutto, ne attestano la validità. Questa canzone, così come buona parte della cultura cui fa riferimento, normalmente avvertita come rozza, offensiva o priva di raffinatezza, li coinvolge perché rivela la ricchezza della loro esperienza, la poesia insita in quelle che la società spesso considera come esistenze abbruttite e volgari.
Infliggere il castigo è compito dello Stato. Il mio mestiere è aiutare la gente a esprimere la propria umanità in un ambiente nel quale farlo può costarti la vita.
In prigione, o in un qualsiasi altro luogo popolato da gente che proviene da situazioni disagiate, le persone in genere mi studiano attentamente mentre parlo per cercare di capire se possono fidarsi di me, se sono un tipo “ok”. Fanno attenzione al modo in cui dico le cose, alle parole che uso e al mio accento. Cercano istintivamente di misurare la distanza tra chi sono realmente io e come mi presento. Sono ambienti in cui il metro di misura delle persone è la loro autenticità.
Per questo è raro che gente altolocata, che usa un linguaggio alto, riesca a operare in questi contesti; a meno che non sia circondata da agenti di sicurezza o dotata di una autorità legale. Quando qualcuno viene a lavorare qui, di solito adotta una personalità che pensa possa piacere ai detenuti, dimenticandosi che la popolazione carceraria è estremamente intuitiva e capace, come poche altre, di manipolare il prossimo.
Anche se in prigione ci si finisce per le ragioni più disparate, l’esperienza che accomuna la maggior parte delle persone che stanno dietro le sbarre è quella dell’abuso – psicologico, emotivo, fisico o sessuale – subìto quasi sempre prima di aver commesso un crimine. Essere abbandonato o maltrattato da chi avrebbe il compito di occuparsi di te è la miccia scatenante di quei fattori che in seguito ...