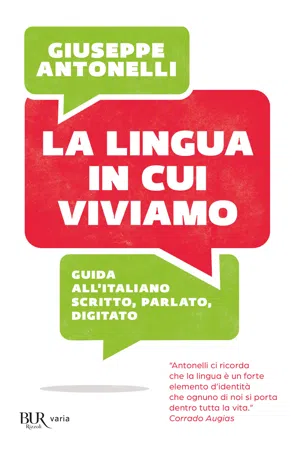![]()
Italiano
Piccola accademia d’arte grammatica
![]()
La grammatica è un diritto
In Umberto D., capolavoro di Vittorio De Sica, l’anziano protagonista dice a un certo punto alla giovanissima domestica, rimasta incinta di uno dei due militari che frequenta: «Certe cose avvengono perché non si sa la grammatica». Frase che – in un film bello e malinconico – fa un po’ sorridere, tanto più se si pensa che il protagonista era impersonato da un illustre professore di glottologia dell’Università di Firenze: Carlo Battisti.
Vedendo il film a più di sessant’anni dalla sua uscita, quella frase mi ha fatto tornare in mente uno dei tanti messaggi che hanno circolato su Twitter durante la prima Giornata ProGrammatica organizzata da Radio tre (insieme al Ministero dell’Università e della Ricerca, all’Associazione per la Storia della Lingua Italiana e all’Accademia della Crusca). Il messaggio diceva: «Dedicato a tutti quelli che pensano che la consecutio temporum sia una pratica sessuale». Ed era solo uno dei tanti, tantissimi, messaggi inviati in quell’occasione. Al punto che in ognuna delle tre edizioni realizzate fino a oggi, l’hashtag #giornataproGrammatica è arrivato a essere – per qualche ora – tra i più usati in Italia.
Una conferma clamorosa del bisogno di grammatica mostrato dagli italiani negli ultimi decenni: della diffusissima curiosità, ma anche «lealtà» (come l’ha chiamata Luca Serianni) nei confronti della propria lingua, percepita come un riferimento identitario fondamentale e per questo idealizzata nel nome di un astratto – e astrattamente immutabile – ordine normativo.
L’Italia, come si sa, è sempre stata un paese di navigatori, santi ed eroi. Ma anche di intransigenti grammatici. Secoli e secoli di dibattiti non ci hanno ancora sfiancato e sulle regole linguistiche siamo sempre pronti a riaprire la discussione.
«Perché continua a dire doppia vu doppia vu doppia vu? Non sa che per gli indirizzi Internet si usa vu vu vu?», mi domandava qualche tempo fa un interlocutore un po’ polemico. In effetti, di fronte alla forza dell’uso, cosa vale quella dell’occhio? E poi lo dice anche la canzone: «vu vu vu mi piaci tu». Ma allora sentendo Carmen Consoli che canta una «sàlubre autoironia» dovremmo adeguarci tutti e magari dire anche èdile e pùdico? Non c’è da scandalizzarsi più di tanto, in realtà: le stesse motivazioni (etimologiche) che sono alla base delle pronunce normative salùbre, edìle, pudìco ci dovrebbero far pronunciare anche guaìna (dal latino vaginam) e persino io valùto (proprio come l’euro è una valùta, non una vàluta). Eppure, provate a pronunciare in pubblico valùto (o sèparo, o esplèto) e vi accorgerete che le vostre quotazioni presso l’uditorio scenderanno immediatamente.
Per non parlare, appunto, della svalutazione portata dagli euri, che pure avrebbe dovuto essere in italiano il plurale naturale: un dollaro, due dollari; un euro, due euri (altro che invariabile: inglesi, francesi e spagnoli usano tutti – con pronunce diverse – euros). Fin dall’inizio, però, la tv ha preso a dire gli euro e a dileggiare gli euri. Nulla hanno contato prestigiose prese di posizione a favore di euri da parte non solo di linguisti, ma anche di giornalisti noti come Beppe Severgnini; nulla il fatto che fino al 2001 euri fosse stato regolarmente impiegato dalla Gazzetta Ufficiale. Dopo qualche mese di sguardi disgustati da parte di tutte le categorie di negozianti, anche i più tenaci (me compreso) si sono dovuti arrendere alla tirannia dell’uso. Che spesso è irrazionale, ma è pur sempre – come sosteneva Manzoni – «l’unica causa che faccia le parole buone, vere, legittime, parole di una lingua».
Un tempo bastava dire: «mangerei un sasso piuttosto che un animale» per far capire di essere vegetariani. Oggi rischieremmo di passare per eccentrici. L’amico che ci ripete «dormirei in una suite piuttosto che in campeggio» è uno snob o uno che si adatta? Uno snob, a rigor di norma, perché – usato correttamente – il piuttosto che indica una preferenza netta per quanto lo precede rispetto a quanto segue. Se dico «amo il ciclismo piuttosto che il calcio», vuol dire che di Messi non mi interessa niente. E allora perché mi sento rispondere: «vieni da me stasera a vedere il Barcellona?». Perché, ormai da qualche tempo, piuttosto che viene usato anche per mettere sullo stesso piano due o più elementi.
Siccome immobile – Quest’uso desta una giusta insofferenza. Non dobbiamo dimenticare, però, che la lingua cambia nel tempo. Reazioni simili a quelle che oggi provoca il piuttosto che al posto di oppure si avevano, nell’Ottocento, per il siccome usato al posto di poiché (invece che col valore etimologico di così come). «Sozzo gallicismo, che mi urta i nervi», annotava lo scrittore Vittorio Imbriani, alludendo al fatto che il costrutto era ricalcato sul francese: «figuratevi come li debba avere urtati, poiché veramente l’uso di questo siccome è divenuto universale».
Già. Quando un uso linguistico diventa davvero universale, ha buone probabilità di essere presto accettato dalla norma. Ma prima di quel momento si può – si deve – provare a resistere. Il che vale anche, ad esempio, per il comico siccome che di Anna Marchesini nei panni della signorina Carlo («che siccome che sono cecata»). E per molte altre espressioni che sempre più spesso sentiamo usare male o a sproposito.
Una cosa che mi fa senso – A un’altra lingua straniera, l’inglese, dobbiamo alcuni usi a cui ormai siamo tutti abituati: come realizzare per “capire” o cancellare per “annullare”, o come basico nel senso di “elementare” (in chimica basico è opposto ad acido, ma il contrario di una competenza basica non è una competenza acida). Negli ultimi anni ci si spinge oltre. Come nel caso di fa senso (da it makes sense), che in italiano non significa – come qualcuno vorrebbe – “è sensato”, ma semplicemente “fa schifo”. Grazie per non usarlo, potremmo dire facendo il verso a tanti cartelli che capita ultimamente di leggere. Con quel grazie per all’infinito che in italiano riguardava solo il passato (grazie per avermi ascoltato) e oggi si proietta anche sul presente: grazie per non fumare, rifatto su thank you for not smoking (risposta: prego per la lingua italiana).
Parla che – «Grazie di esistere» cantava Eros Ramazzotti in una canzone che parla di una coppia felice. Si parla di e si dice che. Eppure non è raro leggere o sentire frasi come questa che in rete commenta il trailer italiano di Spider-Man 2: «il film parla che Peter ha problemi con i suoi poteri». I verbi parlare e dire hanno un significato simile, ma non identico: «il libro parla della storia di Roma» ha un valore diverso rispetto a «il libro dice che Roma fu fondata nel 753 a.C.» (nel primo caso si fa riferimento al contenuto di tutto il libro; nel secondo se ne riporta un’affermazione). In alcuni casi l’errore nasce proprio da uno scambio tra i due verbi: «nell’intervista, Renzi parla che l’Italia è a una svolta». Parliamone!, potrebbe dire qualcuno; diciamolo!, avrebbe esclamato il La Russa imitato da Fiorello.
Auspichiamoci così – Il fatto è che nella vita bisogna decidersi: o si dice o si parla; o ci si augura o si auspica. Anche qui le due espressioni hanno più o meno lo stesso significato. L’auspicio (l’augurio) è che si smetta di mescolarle senza motivo, visto che il costrutto riflessivo è corretto in augurarsi ma non in auspicarsi. Qualcuno dovrebbe farlo sapere ai tanti politici che si ostinano a usare «mi auspico» come frase di circostanza buona per ogni occasione. E anche a Lapo Elkann, che – interpellato sulla notizia del possibile ritorno dell’Alfa Romeo in Formula 1 – ha detto: «io non posso che essere contento di averla letta e di averla sentita e mi auspico di vederla».
Viaggiando sugli articoli – È vero che si dice «ci vediamo lunedì prossimo», ma bisogna dire «la settimana prossima», «il mese prossimo». Non illudiamoci: il salto dell’articolo non ci farà guadagnare tempo. Tanto meno negli spostamenti su una città. «Stiamo viaggiando su Roma» sarebbe meglio lasciarlo dire al pilota mentre l’aereo sorvola la capitale. Perché in tutti gli altri casi si va, ci si sposta, ci si trasferisce o dirige a. Chi va a Roma perde la poltrona: chi va su Roma, la grammatica.
Escile! – Usi come piuttosto che, settimana prossima o mi sposto su Roma sembrano avere origine settentrionale; sono invece tipici dell’uso meridionale gli scambi tra usi transitivi e intransitivi. Dieci anni fa fece discutere uno spot elettorale di Michele Emiliano, poi sindaco di Bari, in cui si sentiva urlare: «Metti a Cassano!» (nel senso di “fai giocare Cassano”); lo scorso anno ha fatto molto parlare di sé l’hasthag #escile. Avanti di questo passo e – forti del congiuntivo alla Fantozzi: «eschi, ragioniere, se ne vadi» – si finirà col prendere anche Eschilo per un imperativo: una vera tragedia.
Fischi per fiaschi – Nel 1990, Umberto Eco dedicava un intero articolo ai Modi di non dire esatto; e molti sono, in effetti, anche i modi di non dire piuttosto che: invece di, ad esempio, o anziché, più che. Ma più interessanti dei modi di non dire sono senz’altro i modi di dire. Quelli che oggi vengono usati in maniera sbagliata sono tanti. Tra gli esempi classici l’occhio del ciclone, che in realtà è l’unico punto in cui la violenza del ciclone non si sente, o la virata a 360 gradi, che – ben lungi dall’essere decisiva – ci riporta precisamente al punto di partenza.
Ma ad essersi persa, negli ultimi anni, è soprattutto l’abitudine alle frasi idiomatiche. Quel tipo di frasi che un tempo erano – come scriveva Manzoni – «attitudini naturali d’una lingua», anche se – stando alla somma dei singoli vocaboli – potevano sembrare «indovinelli, singolarità, storpiature». Capita abbastanza spesso, ormai, di leggere articoli in cui essere di bocca buona è usato per “essere degli intenditori” e non, come dovrebbe, per “accontentarsi facilmente” o a mangiare la foglia si dà il valore di “lasciarsi ingannare”, mentre invece significa “intuire un inganno”. Ci ritroviamo davvero, come scrive più d’uno, tra la padella e la brace (ma non erano l’incudine e il martello?).
«La fortuna di un popolo dipende dallo stato della sua grammatica», scriveva Fernando Pessoa, ma la grammatica di una lingua viva non è mai statica: è sempre in equilibrio dinamico tra norma e uso. Basta pensare al recente dibattito, in Francia, su una riforma ortografica che intende modificare – tra l’altro – il ricorso all’accento circonflesso (“allenare”, per esempio, non si scriverebbe più entraîner ma entrainer).
In Italia una discussione simile ha riguardato l’uso dell’h nelle voci del verbo avere. La Società Ortografica Italiana consigliava, nel 1911, di limitare l’h alle sole interiezioni (ah, eh, ih, oh, uh) e di ammettere per il verbo avere solo le grafie accentate: le uniche forme corrette, dunque, sarebbero state io ò, tu ài, egli à, essi ànno. La soluzione – proposta già da diversi letterati fra Sei e Ottocento – non riuscì ad affermarsi, anche se nel 1969 il Dizionario di ortografia e pronunzia registrava ancora la grafia con l’accento come possibile (sia pure «rara»).
Ma non bisogna commettere l’errore di identificare la grammatica soltanto con l’ortografia o limitarla all’uso corretto dei pronomi e dei verbi. La grammatica è anche – e soprattutto, se non si vuole rimanere a un livello elementare – la capacità di costruire frasi e concatenarle tra loro: la capacità di organizzare testi chiari ed efficaci, adeguati al loro contesto e al loro scopo. Perché, come faceva dire Leonardo Sciascia a un vecchio professore di lettere, «l’italiano non è l’italiano: è il ragionare».
Qualche tempo fa circolava in rete la notizia che a Berlino si era tenuto il primo raduno di “grammar nazi”. La notizia si è poi rivelata una bufala: il sito da cui proveniva era quello di una rivista satirica irlandese. Ma ha contribuito a diffondere anche da noi una definizione che in ambito anglosassone è usata da oltre vent’anni.
Già nel 1996, David Foster Wallace – che al rapporto tra Autorità e uso della lingua ha dedicato un lungo saggio – si lamentava di essere chiamato così dai suoi studenti: «l’unico motivo per cui sono noto nello stato dell’Illinois è per essere un “grammar nazi”». Ed è vero che lui insegnava nel dipartimento di inglese della Illinois State University; però è difficile non pensare (che anche lui abbia pensato) alla celeberrima battuta del film Blues Brothers: «Io li odio i nazisti dell’Illinois», dice John Belushi a Dan Aykroyd quando i due s’imbattono in una ridicola parata neonazista.
Appunto: basta farsi un giro in rete – tra svastiche a forma di G e grottesche mascherate in divisa da SS – per capire quanto l’etichetta sia ambigua, oltre che di pessimo gusto. Ambigua tanto più in un paese come il nostro, che durante il ventennio fascista ha conosciuto il purismo di stato. E dunque tende a tacciare di fascismo qualunque tipo di attenzione per la lingua, ogni riferimento – anche il più blando – a forme di politica linguistica.
Pochi sanno che nell’Ottocento ci sono stati anche puristi di fede giacobina. Come il frusinate Luigi Angeloni, sostenitore con la stessa intransigenza delle idee repubblicane (che lo costrinsero a una vita da esule) e di un modello linguistico basato sugli «eccellenti scrittori» del Trecento. Una scelta criticata da Mazzini, che non condivideva quel suo modo di rivestire il pensiero «della lingua de’ morti e d’uno stile pedantesco»: il rischio era indebolire il messaggio rivoluzionario, esponendosi al ludibrio degli avversari.
La satira del pedante, d’altronde, era un pezzo forte già nella commedia cinquecentesca e non ha mai smesso di essere alla moda. Gli appassionati sostenitori della buona lingua potevano essere definiti parolai, logodedali o scrutinaparole. «Messi in croce», si lamentava Antonio Cesari, «e chiamati per istrazio Linguisti e Puristi» (fino a tutto l’Ottocento, le due definizioni erano sovrapponibili; ma Cesari – considerato il padre del purismo – se ne sentì dire di molto peggio: Vincenzo Monti arrivò ad evocarlo con l’epiteto di «grammuffastronzolo»)....