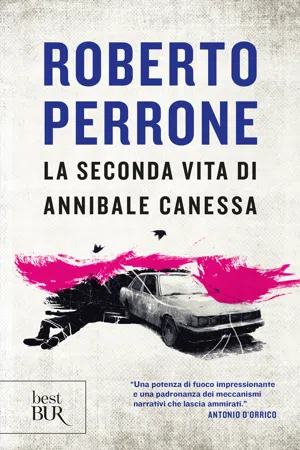![]()
1
Nel terzo millennio
1
La vedova Maggese maledisse l’età e si alzò a fatica dal letto. Più che alzarsi, però, era difficile scendere da quel catafalco. “Domani lo cambio” si ripeteva, “questa è l’ultima volta che ci dormo.” Ovviamente la notte successiva era di nuovo lì e ogni volta le sembrava di fare un salto da un’altezza maggiore. Era suggestione, certo, il letto era sempre lo stesso da almeno trent’anni. Era un vecchio letto che risaliva alla fine dell’Ottocento, già alto di suo, su cui il suo povero marito Aristide aveva fatto sistemare un materasso che pareva un palazzo a sei piani. Lei aveva cercato di spiegarglielo che così era troppo alto, ma lui, che non era certo un uomo autoritario, le aveva risposto con dolcezza che per la salute andava benissimo e che l’avrebbe apprezzato col tempo. «Per via dell’aria di montagna?» aveva ironizzato la vedova Maggese non ancora vedova.
Aristide era un pezzo d’uomo, e per scendere non doveva saltare, gli bastava semplicemente poggiare i piedi. Lei no, era così piccolina che quando si erano messi insieme i parenti dicevano che per baciarsi dovevano usare una scala. Comunque non si era mai lamentata e non aveva neanche cambiato il letto, per una forma di rispetto e nostalgia, nemmeno dopo che lui se n’era andato.
Qualcuno dei suoi studenti commentava, malevolo: «Sì, se n’è andato perché chiedeva il teorema di Pitagora anche a lui». La vedova Maggese aveva insegnato matematica per una vita. Era andata in pensione quando proprio non poteva più rimanere. Fosse dipeso da lei, sarebbe ancora là a insegnare, inutilmente nella maggior parte dei casi, equazioni e geometria. Era vedova e quattro volte nonna, grazie a due figli che vivevano a Bologna.
Non abitavano distante dalla sua zona residenziale di Reggio Emilia, ma li vedeva a stento a Natale e a Pasqua. “Eh, i giovani d’oggi” rifletteva, “non santificano le feste, non mangiano” – in effetti a Natale solo la buonanima onorava il suo ricco menu, mentre figli, nuore e nipoti si limitavano a spiluccare – “non onorano il padre e la madre.” Lei, giovane insegnante sul Delta del Po, si sobbarcava un viaggio in bus da tregenda per risalire l’Emilia fino a raggiungere la fattoria dei suoi, non appena poteva. «È più facile andare in America col piroscafo» aveva detto un giorno una signora che spesso faceva la strada con lei.
“Vabbe’” tagliò lì, “meglio lasciar perdere, sono pensieri da vecchia.” Saltò giù dal letto atterrando come sempre incerta e si diresse in bagno. Dopo, tornando, attirata dal chiarore di una notte di luna piena, fece un giro in tinello (lei lo chiamava così) e scostò la tendina per sbirciare fuori. Quasi le scappò un “oh” di sorpresa.
Dall’altra parte della strada, sotto il grande arancio selvatico che ricopriva quasi tutto il giardino della villetta gemella della sua (erano tutte gemelle in quella via, veramente), c’era il signore della casa di fronte seduto sull’altalena che aveva costruito per la sua bambina. La vedova Maggese guardò l’ora sul luminosissimo – forse anche troppo, doveva capire come si regolava la luce – orologio della cucina. Le quattro e trenta. Cosa ci faceva lì a quell’ora, a spingersi piano sull’altalena che si muoveva appena? Aveva litigato con la moglie? Strano, erano una coppia così affiatata e gentile. Tutti e tre educatissimi, anche la bambina: «Buongiorno, signora Maggese» aveva imparato a dire appena scesa dalla culla.
Lo fissò ancora un po’, cercando di capire che faccia avesse, ma i riflessi della luna le impedirono di vederlo bene in viso. Non le sembrava proprio il tipo da scappatelle.
“Speriamo che non sia nulla di irreparabile” concluse la vedova Maggese riprendendo la via del letto e preparandosi mentalmente all’ennesima scalata.
“Sono stato battezzato ed educato nella fede cristiana ortodossa.”
Quando rileggeva l’incipit della Confessione di Tolstoj si rivedeva bambino, con un altro libriccino simile, ma color avorio, in una grande chiesa, con i pantaloni corti e le calze bianche, mentre spingeva i pensieri disperatamente verso l’alto dei cieli, nel tentativo di essere puro, vicino a Dio, come gli avevano spiegato a catechismo. Chissà perché della sua infanzia ricordava con ampiezza di particolari solo la chiesa barocca nel centro di Genova, e lui sotto la volta con un vestito grigio, i pantaloni appena sotto il ginocchio, come si usava allora, le mani giunte, alle spalle uno zio annoiato a fargli da padrino, e quel piccolo libro di preghiere che si rigirava felice in mano perché era nuovo, lucido. Gli erano sempre piaciuti i libri, specialmente quelli nuovi.
Anche lui, come Tolstoj, era stato educato così, dentro una fede, poi tutto era finito, presto, non molto tempo dopo la sua cresima.
Aveva preso quel volumetto dalla biblioteca, trascinato dall’inquietudine che aveva addosso da quando aveva afferrato il telefono, alcune ore prima, rispondendo al terzo trillo. Così, per le quattro ore di treno che lo aspettavano, due all’andata, due al ritorno, aveva scelto quella lettura che per lui rappresentava, da sempre, l’anticamera di un cambiamento.
Era una copia di piccolo formato, un furto giovanile (ma a quei tempi li definivano “espropri proletari”) da qualche biblioteca occupata: prima edizione, dicembre 1979. Il disagio aumentò quando lesse la data e la collegò alla conversazione telefonica e al periodo della sua vita che aveva disseppellito. Eppure non era stato capace di negarsi. A omettere forse era bravo, ma a mentire non ce la faceva. Se fosse successo un giorno prima, giovedì, avrebbe potuto appellarsi al lavoro, all’impossibilità di ottenere un permesso senza preavviso dalla biblioteca pubblica di cui era sovrintendente. Strana legge del contrappasso, questa: lui che per anni i libri li aveva sottratti (indebitamente, ora ne era convinto, allora no), nella seconda parte della sua vita li curava e li difendeva. Ma non quel giorno, non di sabato.
Sara avrebbe portato la bambina agli scout e lui aveva pensato a una lunga giornata di ozio e lettura. Poi, all’ora di cena, era arrivata quella telefonata e così si era trovato lì, alle quattro e mezzo del mattino, a dondolarsi sull’altalena che aveva costruito per sua figlia in giardino sotto il loro albero di arance selvatiche.
Dall’altra parte della strada si accese una luce. La vedova Maggese scostò una tendina.
Napoleone Canessa sorrise e si accese una sigaretta. La luce del fiammifero brillò per un attimo nell’oscurità. Pensò a quell’incontro, al perché quell’uomo volesse vederlo a Milano, poco prima delle otto, perché avesse fretta, come se il tempo gli stesse sfuggendo di mano. Stava lì a riflettere, incerto, facendosi la stessa domanda che gli urgeva dentro da ore, che gli aveva impedito di trascorrere una serata tranquilla con sua moglie e sua figlia. “Perché proprio io?” Poi capì. “Forse sono solo un intermediario, un tramite per arrivare a qualcun altro.”
Il possibile ruolo di mediatore lo preoccupò ancora di più della telefonata in sé, del viaggio da intraprendere, delle incognite che quella voce tornata dal passato gli aveva consegnato. Se le sue previsioni si fossero rivelate esatte, gli sarebbe stato chiesto di affrontare l’unica persona al mondo che sperava di non incontrare mai più e che non vedeva da quasi trent’anni: suo fratello.
2
Il procuratore aggiunto Federico Astroni si accorse della presenza della donna solo quando questa gli fu alle spalle. Se avesse voluto ucciderlo – ogni tanto lo immaginava: ucciso da una donna, una pasionaria, come Marat con Charlotte Corday dentro il bagno del console – avrebbe potuto compiere l’omicidio in qualsiasi momento. Era silenziosissima, oltre che, naturalmente, efficientissima. Prevedeva qualunque cosa sempre, caratteristica che era di Astroni e che lui si compiaceva di aver rinvenuto, dopo molti esperimenti, prove e ricerche, in quella donna di un altro mondo e in generale in tutti i suoi collaboratori.
La domestica filippina posò il piccolo vassoio sulla scrivania e disse: «Signor, il caffè».
Il magistrato sorrise per quel “signor”: lei non diceva mai “signore”, solo “signor”. Una volta aveva cercato di convincerla a completare il vocabolo, ma non c’era stato verso di riuscirci. Quando si rivolgeva a qualche ospite, quel “signor” restava sospeso e gli interlocutori attendevano inutilmente che lei aggiungesse il nome o il cognome: “signor… Rossi”, “signor… Carlo”. E invece niente. Il “signor” galleggiava nell’aria e poi spariva con lei.
Astroni era stato portato a quei pensieri da glottologo dal lavoro che stava completando in quel mattino milanese tiepido e luminoso. Tornò, dunque, ai suoi fogli e prese il bianchetto per cancellare l’aggettivo “indissolubile”, che non gli piaceva. Afferrò il dizionario dei sinonimi e dei contrari e scelse “indivisibile”, che meglio si adattava alla tesi che voleva esporre: un capo vero esercita il potere e non lo spartisce, quindi decisioni supreme non potevano essere divise, o peggio delegate. Erano di una persona sola, dunque non poteva esserci che un colpevole.
Il giudice Astroni scriveva – per la verità lui dettava, scrivevano gli altri, i suoi collaboratori – le sue arringhe, i suoi discorsi, i suoi interventi al computer, ma poi li correggeva a penna, li limava con la sua nera, enorme e fallica Montblanc col pennino argentato. Si trattava di un prezioso regalo di una nobildonna meneghina di cui frequentava il salotto e, con molta circospezione, anche il letto. «Così, quando mandi tutta quella gente al rogo» gli aveva detto l’amante con melodrammatica ironia, «mi farà piacere pensare che anch’io sto collaborando.»
Era una cinquantenne ancora piacente che negli anni Settanta era stata una delle tante rivoluzionarie da operetta di cui si era popolato il Paese: percorrevano l’Italia vestite di paccottiglia colorata, con maglioni informi, gonne lunghe, capelli arruffati, nemiche della pulizia e della messa in piega che adesso perseguivano con ossessione maniacale in centri estetici costosissimi. Erano più cattive degli uomini, più estremiste. Partecipavano alle assemblee, ai cortei, alle “okkupazioni”, convinte di essere protagoniste di un momento storico, senza rendersi conto che si trattava solo di un hobby, di un passatempo che avrebbero abbandonato come si lasciano la pesca, il pizzo al tombolo, il restauro di mobili antichi, lo yoga. E così era avvenuto. Qualcuna, per la verità, era rimasta coerente alle idee di un tempo, qualcuna perfino all’abbigliamento e al distacco prolungato da bagni e docce, però avevano lasciato scantinati e centri sociali per tornare a stabilirsi nei palazzi, negli appartamenti, nelle case belle e comode che le loro famiglie si potevano permettere.
Sorrise, perché a quei tempi Astroni l’avrebbe allontanata con disprezzo: lui ci aveva provato per davvero a fare la rivoluzione, non aveva recitato una commedia. La sua battaglia, voleva credere con tutto se stesso, era ancora la stessa, ma i tempi erano cambiati. E soprattutto erano cambiati i mezzi. Allora non avrebbe mai immaginato che avrebbe avuto dalla sua quelli dello Stato, lo stesso Stato che aveva sognato di rovesciare e che adesso serviva, anche con l’appoggio di folle adoranti, che lui disprezzava con tutto il cuore.
E così aveva incluso anche lei in quel suo harem invisibile che tutti, compresi i giornalisti, al Palazzo di Giustizia, conoscevano, o almeno intuivano, ma che nessuno aveva il coraggio di svelare; per rispetto, pochi, per paura, la stragrande maggioranza. Perché lui era il procuratore aggiunto Federico Astroni, l’ex enfant prodige della Procura, il figlioccio del procuratore della Repubblica, l’ideologo di Mani Pulite, il vero leader del gruppo, il più colto, il più preparato, l’uomo che aveva “schienato” (participio orribile ma che accettava solo in questo caso perché nella sua volgarità lo divertiva assai) tutti, politici, imprenditori, piccoli e grandi funzionari di Stato, di partito, privati.
Tra i tanti che aveva fatto condurre nel suo ufficio in manette, piangenti, a mostrare le foto di figli piccoli, di madri anziane e vedove, raccontando di malattie incurabili nel tentativo di commuoverlo, qualcuno lo aveva perdonato, accusatore e giudice nella stessa persona. Altri li aveva distrutti anche per un peccato veniale. Dipendeva dal ruolo, dalla situazione, talvolta da un risentimento momentaneo. Ma c’era una cosa che, più delle altre, scatenava la sua rabbia fredda e determinata: la resistenza. Per quello aveva voluto trascinare in tribunale – e ci era riuscito – il leader del più importante partito di opposizione, il solo che non era arrivato davanti a lui strisciando ma che l’aveva sfidato, pubblicamente, sostenendo che si trattava di persecuzione politica, chiamandolo “terrorista”, scatenandogli contro i giornalisti amici, le tv dove poteva trovare asilo. Forse all’inizio il procuratore lo aveva messo sotto inchiesta perché lo considerava un rimasuglio di quella politica che riteneva nociva per il Paese e inoltre nemica delle sue idee e di quello che credeva di rappresentare, ma dopo non si era più trattato di questo, dopo – anche se non l’avrebbe mai ammesso – era subentrato un odio viscerale. Era ormai un fatto personale. O me o lui. Certo, qualche magagna il ricco politico ce l’aveva, ma nulla che giustificasse quell’attenzione, quell’impegno.
Alla fine tutto, nella sua vita, si era ridotto a questo e per questo lo avrebbe distrutto.
Si ricordò di un altro uomo che aveva odiato allo stesso modo, per diversi motivi. Poi ne scacciò l’immagine. Bevve il caffè e si alzò, andando alla finestra.
Sotto casa, in quella piazza del centro, non si poteva parcheggiare per causa sua. Quando l’inchiesta sulla corruzione era al suo apice e il pool di magistrati che la conduceva era sulla bocca di tutti e nelle case di tutti grazie a giornali e televisioni, talk show e dirette davanti al tribunale, uno dei suoi vicini gli aveva detto, incontrandolo per strada e quasi genuflettendosi: «Per te andrei a mettere la macchina a Pechino, ti darei anche casa mia».
In quel momento, sul tavolo dell’ingresso, dove poggiava la corrispondenza, c’era una petizione di cui l’ex pechinese era il primo firmatario. In sintesi, gli chiedevano di ritornare alla vita di prima, senza divieti (primo fra tutti, il divieto di parcheggio), senza controlli, senza quella presenza massiccia di forze dell’ordine. Se la sicurezza, nel suo caso, era necessaria, smammasse lui. Erano stanchi di quella vita blindata e di dover posteggiare duecento metri più in là.
Si sarebbe depresso se avesse fondato la sua fede, il suo convincimento, il suo lavoro, su questa gente. Servire il popolo: che stupidaggine. Per fortuna lui aveva fatto quello che aveva fatto solo per se stesso.
Astroni si sentiva bene, il riflesso del suo corpo nel vetro della finestra rimandava l’immagine di un uomo alto, con i capelli ricci ancora folti, occhi profondi dietro gli occhiali d’oro (che usava solo per leggere, si vantava di vederci ancora benissimo da lontano), ereditati da suo padre, magistrato regio, rimosso dall’incarico perché si era rifiutato di iscriversi al partito fascista. Per fortuna veniva da una famiglia ricca, altrimenti sarebbe finita male.
Giù in strada c’erano due auto posteggiate, la sua e quella della scorta. Uno dei carabinieri era appoggiato alla macchina, lo sguardo attento. Scrutava le finestre della piazza, fissava i tetti, rapidamente. Incrociarono gli sguardi. Il magistrato fece un cenno con la mano e venne ricambiato da un leggero movimento del capo dal carabiniere. Un altro fedele servitore scelto, anche quello, dopo molte prove.
Fu allora che un’ombra calò sulla giornata limpida, sul weekend di lavoro che lo attendeva e in generale sul suo tradizionale ottimismo. Quel gesto gli aveva risvegliato brutti ricordi, pessime sensazioni. Per un uomo che si vantava di saper prevedere ogni cosa, era stata una vera sorpresa trovarsi di fronte quel volto, due settimane prima, uscendo in macchina dal Palazzo di Giustizia. Erano fermi al semaforo, perché a lui non piaceva sfrecciare a sirene spiegate per le strade della città, a meno che non fosse proprio indispensabile. “Non è possibile” si era detto e aveva guardato meglio. La figura che avev...