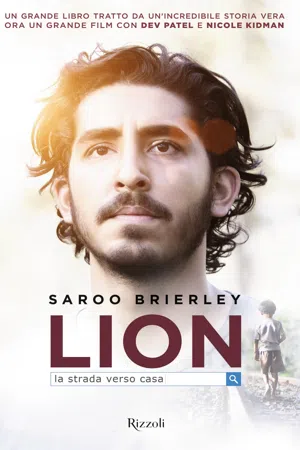![]()
1
Ricordare
Quando ero bambino, c’era una cartina dell’India appesa nella mia cameretta. Ce l’aveva messa mia madre – quella adottiva, «la mamma» – perché mi sentissi a casa anche a Hobart, in Australia. Ero arrivato lì nel 1987, a sei anni. Mi aveva anche dovuto spiegare cosa rappresentava: non ero mai andato a scuola e non sapevo neppure cosa fosse una cartina, men che meno che forma avesse l’India.
La mamma aveva riempito ogni stanza di oggetti indiani: statuette, campane, piccoli ornamenti di ottone e tantissimi elefanti in miniatura. All’epoca non immaginavo che, di solito, non ci sono queste cose nelle case australiane. Aveva anche messo sul comodino di camera mia delle stoffe stampate e un burattino di legno con un vestito dai colori sgargianti. Tutti oggetti che mi erano in qualche modo familiari, anche se non li avevo mai visti. Ero abbastanza piccolo, e la mamma avrebbe anche potuto farmi cominciare la mia vita in Australia partendo da zero, crescendomi senza mantenere alcun legame con il Paese da cui venivo. Ma il colore della pelle avrebbe sempre tradito le mie origini, e comunque lei e mio papà avevano scelto di adottare un bambino indiano per un motivo ben preciso.
Le centinaia di nomi sulla cartina mi fluttuarono davanti agli occhi per tutta l’infanzia. Anche molto prima che imparassi a leggere, sapevo che la grande V del subcontinente indiano era piena di città e villaggi, che c’erano deserti e montagne, fiumi e foreste – il Gange, l’Himalaya, le tigri e gli dèi! – e ne ero affascinato. Fissavo la mappa e mi perdevo a fantasticare. Da qualche parte lì in mezzo c’era anche il posto da cui venivo, il luogo in cui ero nato. Ricordavo un nome, «Ginestlay», ma non sapevo se fosse una città, un paese, un villaggio o magari solo una strada, e non avevo idea di dove cercarlo su quella cartina.
Non conoscevo neppure la mia età. Sui documenti c’era scritto che ero nato il 22 maggio 1981, ma l’anno era stato stimato dalle autorità indiane e la data corrispondeva al giorno in cui ero arrivato all’orfanotrofio. Ero un bambino confuso, senza istruzione, e non ero stato in grado di dire chi fossi né da dove venissi.
All’inizio mamma e papà non sapevano come avevo fatto a perdermi. Sapevano soltanto, come tutti, che ero stato trovato per le strade di Calcutta e che ero finito in un orfanotrofio perché non era stato possibile rintracciare la mia famiglia. Fortunatamente, fui adottato dai Brierley.
Per cominciare, mamma e papà mi indicarono Calcutta sulla cartina e mi dissero che io venivo da lì: era la prima volta che sentivo quel nome. Solo un anno dopo, grazie ai miei progressi con l’inglese, riuscii a spiegare che non ero di Calcutta: ci ero arrivato in treno da un posto vicino a «Ginestlay» che poteva chiamarsi «Bramapour», «Berampur»... o qualcosa del genere. Sapevo solo che era molto lontano da Calcutta e che nessuno era riuscito a farmi tornare indietro.
Ovviamente all’inizio era più importante il futuro del passato. Stavo cominciando una nuova vita in un mondo del tutto diverso da quello in cui ero nato e i miei nuovi genitori si impegnarono tantissimo per affrontare i problemi che ne derivavano. La mamma non era preoccupata dal fatto che non sapessi l’inglese, era certa che con la pratica quotidiana l’avrei imparato. La cosa più importante era confortarmi e prendersi cura di me, in modo da guadagnarsi la mia fiducia. E per queste cose non servono le parole. Conosceva una coppia indiana che abitava poco lontano, Saleen e Jacob: andavamo a trovarli regolarmente e mangiavamo tutti insieme cibo indiano. Loro mi parlavano nella mia lingua, l’hindi, facendomi qualche semplice domanda e traducendo tutto quello che mamma e papà volevano farmi sapere. Provenivo da un ambiente povero e non conoscevo bene nemmeno l’hindi, ma il fatto che qualcuno mi capisse mi aiutò moltissimo ad abituarmi a quel nuovo mondo. Io e i miei genitori non ci trovammo mai in difficoltà perché, quando non riuscivamo a comunicare a gesti e sorrisi, sapevamo di poter contare su Saleen e Jacob.
Come tutti i bambini, imparai la lingua abbastanza in fretta. All’inizio, però, parlavo poco del mio passato. I miei genitori non volevano obbligarmi a farlo finché non fossi stato pronto, e io non sembravo pensarci più di tanto. La mamma ricorda solo che una volta, a sette anni, all’improvviso urlai angosciato: «Sono menticato!». Soltanto dopo un po’ capì che mi ero spaventato perché avevo dimenticato la strada per raggiungere la scuola vicina alla mia casa in India, dove andavo spesso per spiare i bambini che entravano in classe. Decidemmo che forse in quel momento non era più così importante ricordarsela. Ma in fondo, per me, lo era: i ricordi erano tutto ciò che mi restava del mio passato e quando ero solo li facevo scorrere di continuo nella mente per essere sicuro di non «menticarmi».
Di fatto, il passato non mi abbandonava mai. La notte, i ricordi mi balenavano davanti agli occhi e calmarmi per riuscire a dormire non era facile. Di solito durante il giorno andava meglio, facevo un sacco di cose che mi distraevano, anche se la mia mente continuava a tornare lì. Ero così determinato a non dimenticare che ho sempre ricordato la mia infanzia in India molto chiaramente, come un quadro quasi completo: dei miei famigliari, della mia casa e degli eventi terribili che mi hanno separato da loro avevo immagini vive, a volte fin nei più piccoli dettagli. Alcune erano belle, alcune brutte, ma non potevo sceglierle, e non potevo nemmeno lasciarle andare.
Cominciare una nuova vita in un altro Paese e in un’altra cultura non fu difficile come ci si potrebbe aspettare, soprattutto perché, dopo tutto quello che avevo passato in India, stavo molto meglio in Australia. Certo, volevo ritrovare mia madre più di ogni cosa al mondo, ma non appena capii che era impossibile mi resi conto che avrei dovuto cogliere qualsiasi opportunità per sopravvivere e andare avanti. Mamma e papà mi volevano molto bene e me lo dimostrarono fin dal primo momento: mi riempivano di coccole e mi facevano sentire al sicuro, protetto, amato e, soprattutto, voluto. Per un bambino che si era perso e che sapeva cosa significa quando a nessuno importa di te, tutto questo era prezioso. Mi affezionai subito ai miei nuovi genitori e presto iniziai a fidarmi ciecamente di loro. Anche se avevo soltanto sei anni (ho sempre dato per buono il 1981 come data di nascita), capivo di aver ricevuto un premio raro: una seconda possibilità. Ben presto diventai Saroo Brierley.
Al sicuro nella mia nuova casa di Hobart, pensavo che in qualche modo fosse sbagliato rimuginare su quello che mi era successo, che la mia nuova vita volesse dire anche chiudere in un cassetto il passato, e per questo tenevo per me i pensieri notturni. E comunque, almeno all’inizio, non avrei nemmeno saputo come esprimerli in inglese. In parte non mi rendevo conto di quanto fosse insolita la mia storia: per me era stato sconvolgente, ma non credevo fosse speciale. Solo in seguito, quando iniziai ad aprirmi e a raccontare la mia esperienza, capii dalle reazioni delle persone che era davvero straordinaria.
Ogni tanto i pensieri notturni mi inseguivano anche di giorno. Ricordo che una volta mamma e papà mi portarono a vedere un film indiano, Salaam Bombay! Raccontava di un bambino che cercava di sopravvivere da solo per le strade di una città enorme, sperando di ritrovare la madre. Scoppiai a piangere nel buio del cinema, senza che i miei genitori, pur con tutte le buone intenzioni, ne capissero il motivo.
Una musica triste (in particolare la musica classica) poteva innescare un ricordo doloroso, e non sopportavo di vedere o sentir piangere un bambino. Ma la cosa che più mi commuoveva erano le famiglie con tanti figli: nonostante la fortuna che avevo avuto, mi ricordavano quello che avevo perso.
A un certo punto, lentamente, cominciai a parlare del mio passato. Dopo un mese o poco più dal mio arrivo, descrissi per sommi capi a Saleen la mia famiglia indiana – madre, sorella, due fratelli – e le raccontai che un giorno avevo perso di vista mio fratello e mi ero smarrito. Non ero in grado di spiegare tutto, e Saleen, con grande dolcezza, mi seguì dove volevo portarla senza fare pressioni. A mano a mano che miglioravo con la lingua, dissi a mamma e papà altre cose, per esempio che mio padre ci aveva lasciati quando ero molto piccolo. Per la maggior parte del tempo, però, ero concentrato sul presente: andare a scuola, farmi degli amici e coltivare la mia passione per lo sport.
Poi, in un weekend piovoso, sorpresi la mamma – e anche me stesso – descrivendole la mia vita in India. Era trascorso poco più di un anno dal mio arrivo a Hobart: forse mi sentivo più a mio agio nel nuovo ambiente, forse riuscivo finalmente a esprimermi meglio. Le raccontai moltissime cose sulla mia famiglia indiana: eravamo così poveri che spesso soffrivamo la fame, e io andavo in giro per il vicinato con una ciotola in mano per elemosinare un po’ di cibo. Mentre mi ascoltava, la mamma mi strinse a sé, e io scoppiai in un pianto dirotto. Quel giorno mi propose di fare insieme una mappa del posto da cui venivo: mentre lei disegnava, io le indicavo in che punto della strada si trovava casa mia, da che parte si doveva andare per raggiungere il fiume dove giocavano i bambini e dove c’era il sottopassaggio che portava in stazione. Seguimmo il percorso con le dita, poi tracciammo nel dettaglio una piantina della casa. Segnammo dove dormivamo io, mia madre e i miei fratelli, persino nell’ordine in cui andavamo a letto la sera. Via via che il mio inglese migliorava, ritornavamo sulla mappa. E, nel vortice dei ricordi, presto arrivai a raccontare come mi ero perso. Lei mi guardava a bocca aperta e prendeva appunti. Abbozzò sulla cartina una linea ondulata che puntava verso Calcutta e scrisse: «Un viaggio lunghissimo».
Un paio di mesi dopo andammo a Melbourne per incontrare altri bambini adottati che provenivano dal mio stesso orfanotrofio. Parlare in hindi con loro riportò a galla nuovi ricordi. Dissi alla mamma che la mia città si chiamava «Ginestlay» e, quando lei mi chiese dove fosse, con grande sicurezza le risposi: «Se mi ci porti, te lo faccio vedere. Conosco la strada».
Pronunciare a voce alta quel nome per la prima volta da quando ero arrivato in Australia fu come aprire un rubinetto. Poco tempo dopo raccontai una versione ancora più dettagliata della mia storia a una maestra che mi piaceva molto. Anche lei prese appunti, per un’ora e mezzo, e dal suo viso non scomparve mai un’espressione di stupore e costernazione. Pensai che, visto quanto sembrava strana a me l’Australia, per la mamma e la maestra sentirmi parlare dell’India doveva essere come ascoltare un racconto d’avventura ambientato su un altro pianeta.
Il mio racconto parlava di persone e luoghi a cui avevo pensato e ripensato parecchio, e a cui avrei continuato a pensare spesso anche crescendo. Ovviamente qua e là ci sono dei buchi. A volte non sono sicuro di qualche dettaglio, dell’ordine esatto in cui sono successe le cose, di quanti giorni siano passati tra un evento e l’altro. E mi è difficile distinguere quello che credevo e sentivo allora, da bambino, da quello che ho creduto e sentito nel corso dei ventisei anni successivi. Ma, anche se ripercorrere il passato all’infinito in cerca di indizi può aver cambiato alcuni particolari, il ricordo di gran parte di ciò che mi è accaduto da piccolo è ancora straordinariamente vivido.
All’epoca raccontare la mia storia a chi mi stava accanto fu un enorme sollievo. Oggi, dopo la conclusione incredibile che ha avuto, spero che raccontarla a quanta più gente possibile serva a ridare speranza, qualunque speranza, a chi sente di non averne più alcuna.
![]()
2
Perdersi
Il faccino sporco e sorridente della mia sorellina Shekila mentre giocavamo a cucù. È questo il mio primo ricordo. E le lunghe notti estive, quando ci ritrovavamo in cortile con le persone con cui dividevamo la casa. Qualcuno suonava l’armonium, altri cantavano, poi le donne portavano fuori lenzuola e coperte, e noi ci raggomitolavamo l’uno accanto all’altro a guardare le stelle prima di chiudere gli occhi. Era bello essere lì, mi addormentavo sempre con il cuore colmo di serenità.
A quei tempi abitavamo nella nostra prima casa, quella in cui sono nato e che spartivamo con un’altra famiglia indù. Ogni famiglia occupava una parte della grande stanza centrale con i muri di mattoni e il pavimento di sterco di mucca, paglia e fango. Era un’abitazione molto umile, ma di certo non un chawl, quegli edifici in cui sono costretti a vivere i più poveri nelle baraccopoli di città come Bombay e Delhi. Anche se lo spazio era poco, stavamo bene. Eravamo felici.
Mia madre era induista e mio padre musulmano, un’unione insolita all’epoca. Infatti non durò a lungo. Lui prese una seconda moglie ed ebbe un altro figlio, e noi non lo vedemmo praticamente più, se non in rarissime occasioni. Quando se ne andò, mia madre si trovò a crescere quattro figli da sola. Nei miei ricordi, era la donna più bella del mondo, magra e con una cascata di lunghi capelli lucidissimi. Poi c’erano la mia sorellina e i miei fratelli maggiori, Guddu e Kallu. Per me erano due eroi: avrei dato qualunque cosa per diventare come loro, e niente mi piaceva di più che passare del tempo insieme, in giro a cercare di procurarsi del cibo o nelle loro piccole scorribande.
Anche se non avevamo ricevuto un’educazione islamica, ci trasferimmo nel quartiere musulmano, dove passai gran parte dell’infanzia. Nella nuova casa vivevamo soltanto noi, ma in uno spazio assai più ristretto. Stavamo al piano terra di un edificio di mattoni rossi, con il solito pavimento di sterco di mucca e fango. Anche qui avevamo una sola stanza: in un angolo c’era un piccolo focolare e in un altro un serbatoio di argilla per l’acqua che usavamo per bere e, a volte, per lavarci. C’era un unico scaffale, su cui tenevamo le coperte. I muri erano un po’ cadenti, tanto che io e i miei fratelli spesso toglievamo un mattone per sbirciare fuori e poi lo rimettevamo al suo posto.
Faceva sempre caldo e non pioveva mai, tranne nel periodo dei monsoni. Dalle grandi colline in lontananza nasceva il fiume che scorreva oltre le vecchie mura e che, durante i monsoni, rompeva gli argini inondando i campi. Una volta finite le piogge, aspettavamo che si ritirasse per poter tornare a pescare nelle sue acque basse. In quel periodo si allagava anche il sottopassaggio della ferrovia: era il nostro posto preferito per giocare, nonostante la polvere e i sassolini che ci cadevano addosso quando arrivava il treno.
Il nostro quartiere era molto povero. All’epoca in cui correvo per le sue strade sterrate ci vivevano gli operai della ferrovia, e per gli abitanti più ricchi della città stare lì significava essere letteralmente finiti sul binario sbagliato della vita. C’erano pochi edifici nuovi, la maggior parte cadeva a pezzi. Chi non abitava nelle case comuni stava in vicoli stretti e tortuosi, in case come la nostra, di un paio di stanze al massimo e con pochissimi mobili: qualche scaffale, un letto basso di legno e, per i più fortunati, un rubinetto con un buco sotto.
Oltre a noi bambini, per le vie c’erano tantissime mucche che vagavano libere, anche in centro, e a volte succedeva che si mettessero a dormire nel bel mezzo delle strade più trafficate. I maiali vivevano in branco: per tutta la giornata andavano in giro a caccia di cibo e poi, proprio come se facessero un lavoro d’ufficio, non appena scendeva la sera «staccavano» e si rannicchiavano in un angolo a riposare. C’erano capre di proprietà delle famiglie musulmane, e galline che becchettavano nella polvere. E c’erano anche parecchi cani. Alcuni erano socievoli, ma la maggior parte era imprevedibile e aggressiva. Io cercavo sempre di girargli alla larga: mi facevano paura, e poi mia madre mi aveva detto che potevano attaccarti una malattia mortale, anche solo con un piccolo morso. Un giorno, mentre gironzolavo per il quartiere, mi trovai di fronte un randagio. Mi bloccai all’istante e lo fissai con timore. Il cane iniziò a ringhiare, mentre si avvicinava minaccioso. Mi spaventai da morire, mi girai e mi misi a correre più forte che potevo, ma sentivo il cane abbaiare alle mie spalle. Corsi a perdifiato per cinque minuti buoni prima di trovare il coraggio di voltarmi a vedere se mi stava inseguendo, ma inciampai e picchiai la testa contro una mattonella rotta. Il cane non c’era più, ma mi feci una brutta ferita sul sopracciglio. Mentre tornavo a casa incontrai Baba, il nostro capo religioso: mi chiese cosa mi fosse successo e mi disse che non dovevo aver paura dei cani perché loro ti mordono solo se sentono che sei spaventato. Quel consiglio mi sarebbe tornato utile, tanto tempo dopo, come pure la cicatrice che mi rimase sopra l’occhio in ricordo di quella brutta avventura. Quando arrivai a casa corsi ad abbracciare mia madre con il fiato ancora affannato per la corsa e con il sapore del sangue sulle labbra. Lei mi strinse a sé, mi consolò con un bacio e mi portò dal vicino per farmi medicare. Per me lei era la persona da cui correre per sentirsi protetti e al sicuro.
Purtroppo, spesso era fuori casa. Quando mio padre se ne era andato, mia madre aveva dovuto cercarsi un lavoro per mantenerci. Poco dopo la nascita di Shekila, era finita a fare l’operaia nei cantieri: trasportava pietre pesantissime sulla testa da mattina a sera, sotto il sole cocente, sei giorni su sette. In più doveva spostarsi di frequente in altre città e capitava che stesse via anche per diversi giorni di seguito. Certe settimane la vedevamo solo un paio di volte. Eppure, nonostante quel lavoro massacrante, non riusciva a guadagnare abbastanza per sfamare tutta la famiglia. Per aiutarla, a circa dieci anni Guddu iniziò a fare il lavapiatti in un ristorante. Anche così, però, soffrivamo spesso la fame ed eravamo costretti a vivere alla giornata. Molte volte dovevamo chiedere qualcosa da mangiare ai vicini oppure elemosinare soldi o cibo al mercato e alla stazione. Uscivamo di casa all’alba e raccattavamo qualsiasi cosa riuscissimo a trovare, poi la sera mettevamo tutto quello che avevamo raccolto sul tavolo per dividerlo tra di noi. Così, in un modo o nell’altro, si tirava avanti. Ricordo la fame come una presenza quasi costante, ma per quanto possa sembrare strano non ne soffrivo troppo: faceva parte della mia vita e l’avevo accettata. Io e i miei fratelli eravamo pelle e ossa, con le pance gonfie, ma in giro si vedevano tanti altri ragazzini come noi, quindi non ci facevamo caso.
Come tutti i bambini del quartiere, escogitavamo modi sempre nuovi per trovare da mangiare. A volte tiravamo semplicemente dei sassi contro un albero di mango per far cadere i frutti; altre, invece, ci lanciavamo in qualcosa di più avventuroso. Un giorno decidemmo di prendere una strada diversa per tornare a casa, attraverso i campi, e ci imbattemmo in un grande allevamento di polli. Era protetto da guardie armate, ma Guddu pensò che mettere le mani su qualche uovo non sarebbe stato troppo difficile, perciò elaborammo un piano. Saremmo rimasti nascosti finché i sorveglianti non fossero andati in pausa, poi io, che ero più piccolo e dunque più difficile da individuare, sarei entrato per primo, seguito dai miei fratelli. Guddu ci disse di arrotolare la maglietta per usarla come cestino. Avremmo raccolto quante più uova, poi saremmo filati dritto a casa.
Aspettammo che le guardie andassero a sedersi con i braccianti per mangiare pane roti e bere chai, il tè speziato. Non c’era tempo da perdere. Mi infilai dentro e iniziai ad arraffare le uova; Guddu e Kallu mi raggiunsero poco dopo e si misero a fare lo stesso. Ma le galline, innervosite dalla nostra presenza, cominciarono a starnazzare fortissimo, mettendo in allerta la sorveglianza. Schizzammo fuori proprio mentre le sentinelle sfrecciavano verso di noi. «Scappiamo!» urlò Guddu, e noi iniziammo a correre più veloci che potevamo in direzioni diverse. Fortunatamente, le guardie decisero di non sparare e, dopo qualche minuto, mi resi conto di averle seminate. Potevo rallentare il passo e riprendere fiato.
Purtroppo, le uova non uscirono indenni dalla fuga e, delle nove che avevo raccolto, se ne salvarono solo due: quando arrivai a casa, le altre colavano miseramente giù dalla maglietta. I miei fratelli erano arrivati prima di me e mia madre aveva già messo la padella sul fuoco. In totale ne erano rimaste dieci: abbastanza per tutti. La prima porzione toccò a Shekila, ma io avevo così tanta fame che non riuscii a resistere: rubai un uovo fritto dal piatto di mia sorella e corsi fuori, ignorando le sue urla. Ancora adesso mi vergogno.
Un’altra volta mi svegliai presto, affamato, e in casa non trovai niente da mangiare. Lì vicino c’era un campo di pomodori, così uscii per prenderne qualcuno. Dato che a quell’ora l’aria era ancora fredda, portai con me la coperta e mi ci avvolsi per bene. Raggiunto l’orto, mi infilai in un’apertura nel recinto di filo spinato e cominciai a raccogliere i pomodori. Ne mangiai un paio subito, gustando la polpa morbida. Poi sentii all’improvviso un fischio fortissimo e vidi un gruppo di cinque o sei ragazzi più grandi correre nella mia direzione. Schizzai verso la recinzione e sgusciai in un buco che avevo notato prima e che sapevo essere troppo piccolo per loro. La mia preziosa coperta rossa, però, rimase impigliata nel filo spinato e, con quelli alle calcagna, non ebbi altra scelta che lasciarla lì. Quando tornai a casa, mia madre fu contenta dei pomodor...