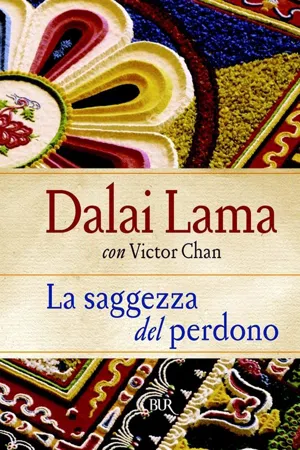![]()
1
Una barbetta alla Fu Man Chu
La sveglia suonò alle quattro in punto. La spensi con un senso di sollievo. Avevo acquistato questa sveglietta da viaggio il giorno prima al bazar ed ero preoccupato perché non sapevo se avrebbe funzionato. Avevo avuto molte esperienze frustranti con orologi «made in India».
Mi vestii in fretta, afferrai la mia videocamera e mi avviai fuori dall’ostello. Potevo scorgere il profilo scuro della catena del Dhauladhar, l’Himalaya meridionale, che si innalzava al di sopra della piccola stazione collinare di Dharamsala. Era molto tranquillo; ci sarebbero volute un paio d’ore prima che la città si svegliasse. Non si vedeva anima viva. Attraversai velocemente la piazzola degli autobus vuota, poi mi misi a correre lungo la strada serpeggiante che conduceva alla residenza del Dalai Lama.
Tenzin Taklha, uno dei segretari di Sua Santità, mi
stava aspettando presso il cancello. Portava una maglietta a maniche corte e lunghi pantaloni grigi, appariva fresco e riposato a quell’ora del mattino. Io ero agitato, con la camicia madida di sudore fastidiosamente appiccicata alla schiena nonostante la temperatura fresca.
«Mi spiace che si sia dovuto alzare così presto» mi scusai.
«Non si preoccupi. Mi capita raramente di stare con il Dalai Lama quando medita di mattina presto. È un privilegio per me» rispose con un lieve sorriso Tenzin, un bell’uomo sulla trentina.
Avevo cominciato i colloqui con il leader tibetano per il nostro progetto editoriale un anno prima, nel 1999, ma questa era la prima volta che mi era permesso di stare con lui la mattina presto.
Perfino a quell’ora, una mezza dozzina di soldati indiani e un paio di guardie tibetane ciondolavano intorno all’entrata. Tenzin mi condusse direttamente attraverso i grandi cancelli metallici. Ero sorpreso. Sebbene ormai fossi una faccia conosciuta – nell’ultimo anno avevo intervistato il Dalai Lama una mezza dozzina di volte – ero sempre dovuto passare attraverso una serie di metal detector per poi essere perquisito da una guardia del corpo tibetana. Ogni visitatore doveva sottoporsi a questa trafila, non si facevano eccezioni. Quella mattina mi sembrò di aver oltrepassato una linea invisibile. Facevo parte del gruppo dei pochissimi non tibetani, fidati confidenti del Dalai Lama. Mi sarebbe stato concesso di entrare nei suoi appartamenti privati senza essere perquisito alla ricerca di armi nascoste.
dp n="21" folio="21" ?
Ripensai a quando avevo varcato questi stessi cancelli nel marzo del 1972. All’epoca c’era una sola sentinella indiana a guardia dell’entrata. Mi sarà sempre molto caro il ricordo di quel giorno di primavera quando incontrai il Dalai Lama per la prima volta. Avevo ventisette anni.
In quell’occasione, vestendomi con cura, avevo indossato un paio di calzoni aderenti di velluto nero. Il fondo dei pantaloni mi dava qualche pensiero; erano così lisi che ci si poteva vedere attraverso. La mia camicia di cotone nero, comprata a Kabul, era soffice e leggera, con i polsini ornati da sottili strisce di pizzo lavorato a mano. Il vero pezzo forte del mio abbigliamento, però, era un mantello nero con cappuccio che avevo comprato a Marrakech. Gli ero molto affezionato e, a meno che non facesse molto caldo, me lo drappeggiavo sempre addosso come Zorro.
Quel completo tutto nero si accordava bene con la mia barbetta alla Fu Man Chu, pensavo. L’avevo pazientemente coltivata nell’ultimo paio di anni mentre viaggiavo attraverso l’Europa e l’Asia. Ma cominciavo a provare un senso di frustrazione. Era rada e cresceva a ciuffi, di certo non folta come avrei voluto. E, tra l’altro, aveva la tendenza a curvarsi verso il mio pomo d’Adamo. Nonostante le mie pratiche quotidiane – la tiravo in continuazione per incoraggiarla a conformarsi alla forza di gravità - non palesava altra intenzione che quella di nascondersi.
I miei capelli erano lucenti e mi arrivavano quasi fino al fondoschiena. Li pettinai con cura e li legai a coda di
cavallo. Con i miei abiti migliori, con il mantello che ricadeva morbidamente nascondendo il buco che avevo sul retro dei pantaloni, ero pronto per la mia udienza con il cosiddetto dio-re del Tibet.
Sapevo molto poco del Dalai Lama e del suo Paese. Avevo trascorso i primi vent’anni della mia vita a Hong Kong. Il Tibet non era affatto contemplato nei programmi scolastici della colonia della Corona Britannica. L’attenzione dei miei compagni cinesi era decisamente focalizzata sull’Occidente, sulle sue grandi scuole di economia e medicina e i suoi gloriosi progressi tecnologici. Il gelido e proibitivo tratto di terra noto come il Tetto del Mondo non era un luogo che stimolasse la loro immaginazione.
Io non ero diverso, se non in una cosa: alle superiori divoravo i libri di Jin Yong, il più grande narratore che avessi mai conosciuto nella mia giovane vita. Il Tibet della mia immaginazione era quello concepito dalla fervida fantasia di Jin Yong. Fu nei suoi racconti di kung fu che appresi per la prima volta dell’esistenza di misteriosi lama tibetani che avevano sviluppato poteri soprannaturali dopo aver meditato per anni nei loro eremi sulle cime dei monti. Questa immagine romantica dei monaci tibetani, incarnazione di spiritualità e prestanza fisica, mi era rimasta impressa.
Cheryl Crosby, una buddhista di New York, fu la ragione per cui incontrai il Dalai Lama. Una sua amica, la signora Dorje Yuthok, la matriarca di una famiglia aristocratica di Lhasa, le aveva scritto una lettera di presencazione
per il leader tibetano. Cheryl aveva solo qualche anno più di me, ma era molto più matura. Era sicura di sé e faceva amicizia facilmente. Perfino durante il nostro sequestro a Kabul, ebbe la presenza di spirito di mantenere una parvenza di comunicazione con i rapitori. Dopo la nostra fuga, avevamo viaggiato insieme fino a Dharamsala.
Lì incontrai i primi tibetani: vidi uomini e donne passeggiare lungo le strade anguste facendo girare le ruote di preghiera. Molti indossavano ancora la veste tradizionale e i colorati stivali di feltro alti fino al ginocchio. Ammiravo i loro volti miti e gentili, trasmettevano un calore genuino, sorridevano con facilità e in ogni incontro si creava sempre una sensazione di gioco, di allegria. Non c’è alcun dubbio: Dharamsala – nota anche come la Piccola Lhasa – era il luogo più dolce in cui fossi mai stato.
Il pomeriggio dell’udienza, Cheryl e io seguimmo un custode tibetano di mezz’età attraverso i cancelli del palazzo. All’interno, un soldato indiano appoggiato al fucile stava fumando una bidi. Ci guardò appena mentre percorrevamo la breve corsia che portava alla sala delle udienze. Era tutto qui il dispiegamento di forze per la sicurezza del Dalai Lama in quei giorni.
La sala delle udienze, dipinta di giallo acceso, era spaziosa e luminosa. Alle pareti erano appesi alcuni rotoli tibetani. Ci sedemmo su semplici ma comode poltrone indiane e aspettammo. Ero eccitato all’idea di incontrare qualcuno considerato da molti un dio e un re. Ma provavo anche una certa apprensione. Sebbene per molti
versi non conoscessi il Tibet, una cosa la sapevo bene: i cinesi avevano invaso il Paese del Dalai Lama negli anni Cinquanta, avevano ucciso molti dei suoi sudditi e lo avevano costretto a rifugiarsi in India. Il trattamento che i cinesi riservarono ai tibetani durante occupazione fu disumano. E io, pura stirpe dell’Imperatore Giallo, stavo per trovarmi faccia a faccia con il capo supremo dei tibetani. Era improbabile che il Dalai Lama avesse incontrato molti cinesi dopo il suo esilio nel 1959: temevo che potesse essere ostile con me.
Mentre consideravo i possibili sviluppi della situazione, entrarono due giovani monaci con identiche vesti color porpora. Riconobbi immediatamente il Dalai Lama. Aveva trentasette anni, ma con i suoi occhiali e il viso privo di rughe, sembrava molto più giovane. A differenza di molti suoi connazionali, era pallido e aveva tratti delicati. Il suo contegno gentile e modesto fu un’altra sorpresa. Era esile, quasi scarno, come il monaco vicino a lui, considerevolmente più basso. In seguito venni a sapere che si chiamava Tenzin Geyche Tethong, discendente di una rinomata famiglia di Lhasa nonché interprete e segretario personale del Dalai Lama.
Mentre stava per sedersi, il Dalai Lama gettò un’occhiata verso di noi. Mi osservò per la prima volta. Fissò la mia barbetta e iniziò a ridacchiare. Non scoppiò in quella risata fragorosa che in seguito avrei conosciuto così bene: era un risolino acuto e prolungato. Non riusciva a controllarsi, si piegava in due per lo sforzo. Nel frattempo, Cheryl aveva cominciato a prostrarsi. Era
sbigottita per quel riso inatteso, ma era determinata a finire le prostrazioni.
Rimasi lì in piedi quel pomeriggio di marzo, in totale imbarazzo. Non sapevo come comportarmi. Non sapevo come fare la prostrazione. A ogni modo, non mi sentivo in vena di toccare il suolo con la fronte davanti a questo giovane uomo che si sbellicava per il mio aspetto.
Alla fine il Dalai Lama riprese il controllo. Sorrise timidamente a Cheryl mentre lei gli faceva dono di un khata, la sciarpa votiva bianca. Io spiegai la mia e mi avvicinai a lui. Mi lanciò un’altra occhiata e ricominciò a ridacchiare. Perfino il solenne Tenzin Geyche adesso sghignazzava sguaiatamente.
La mezz’ora successiva è un ricordo sfuocato. Non rammento come ebbe inizio la conversazione. Ricordo vagamente che Cheryl gli raccontava di sé, del fatto che praticava il buddhismo tibetano ed era amica della signora Dorje Yuthok a New York. Cheryl aveva alcune domande per il Dalai Lama, principalmente riguardanti la sua pratica del buddhismo. Non mi ricordo assolutamente più che cosa volesse sapere e quali furono le risposte. Tenzin Geyche tradusse scrupolosamente. A quel tempo l’inglese del Dalai Lama era peggiore del pidgin english parlato da molti indiani. Senza il suo interprete sarebbe stato perduto. Di tanto in tanto, tuttavia, azzardava qualche semplice frase in inglese.
Poi si girò e mi guardò. Avevo cercato a lungo di trovare qualche domanda intelligente, ma sapevo ben poco del Tibet e ancora meno del buddhismo tibetano. Perciò
gli domandai una cosa che mi tormentava da quando avevo messo piede nella sala delle udienze.
Gli chiesi se odiava i cinesi.
Il Dalai Lama sembrava tranquillo nel suo colloquio con Cheryl. Ora si raddrizzò sulla sua sedia. La sua risposta fu immediata e concisa. E fu in inglese.
«No» disse.
Mi guardò negli occhi. La sua espressione era solenne. Non c’era più traccia di allegria. Distolsi lo sguardo e fissai il pavimento ricoperto di tappeti.
Dopo un interminabile silenzio, parlò in modo tranquillo e lento a Tenzin Geyche in tibetano.
Il segretario personale tradusse: «Sua Santità non nutre alcun cattivo sentimento nei confronti dei cinesi. Noi tibetani abbiamo sofferto molto a causa dell’invasione cinese. E, mentre noi parliamo, i cinesi stanno sistematicamente smantellando i grandi monasteri del Tibet, pietra dopo pietra. Quasi ogni famiglia a Dharamsala ha una storia triste da raccontare; la maggior parte ha perso almeno un membro a causa delle atrocità dei cinesi. Ma Sua Santità ha detto che il suo dissidio è con il Partito Comunista Cinese, non con i cinesi. Li considera tuttora suoi fratelli e sue sorelle. Sua Santità non odia i cinesi. In realtà, li perdona senza riserve».
È sorprendente con quanta chiarezza io ricordi questo frammento di conversazione a distanza di trent’anni. Forse è perché la risposta fu così inaspettata, così difforme dal quadro che Jin Yong aveva tratteggiato nelle sue storie. Tutti i suoi racconti hanno la vendetta come tema ricorrente.
L’onore di un uomo è definito da un credo eroico e semplice: occhio per occhio – molto simile al codice samurai del Giappone feudale. Mi stupiva che il Dalai Lama perdonasse i cinesi per quello che avevano fatto al suo popolo.
Cheryl piangeva sommessamente, emozionata da quell’incontro. Mentre ci apprestavamo ad andare, il Dalai Lama si avvicinò e la consolò. Poi mi strinse la mano con aria seria.
Quando lasciai la sala delle udienze non ero particolarmente impressionato. Mi ero aspettato di vedere un re, ma egli era la persona meno regale che avessi incontrato. Sebbene fosse piuttosto cordiale, era troppo prosaico, un po’ troppo umile. Aveva una piccola aura di santità e ridacchiava troppo. In seguito, proseguendo verso est alla volta di Burma, Hong Kong e poi degli Stati Uniti, sarei giunto a considerare il breve tempo passato a Dharamsala come l’apice dei miei viaggi intorno al mondo. I tibetani avevano lasciato in me un’impronta indelebile.
Dieci anni dopo, il Tibet era ancora ben presente nella mia mente. Risvegliò anche i miei sopiti istinti di nomade. Dal 1984, usando Kathmandu come base, girovagai attraverso i suoi immensi spazi aperti per quattro anni, alla ricerca di materiale per una guida sugli antichi luoghi di pellegrinaggio.
Il paesaggio dell’altopiano era sbalorditivo, diverso da qualunque altro avessi visto nei miei primi anni di vagabondaggio. I tibetani erano come li ricordavo a Dharamsala:
gentili, generosi e inclini alla risata. Il fatto che fossi cinese non impedì loro di aiutarmi.
E il volto sorridente del Dalai Lama non mancava mai. Tutte le case dei villaggi e i monasteri che visitai avevano la sua fotografia sull’altare. Ogni tibetano che incontravo mi chiedeva sue notizie, spesso con le lacrime agli occhi. Improvvisamente il Dalai Lama, e ciò che rappresentava, assunsero un significato sempre più profondo per me. Mi colpì il fatto che lui e i suoi connazionali praticassero una religione molto semplice: essere gentili gli uni con gli altri.
Quando i cancelli di metallo della residenza del Dalai Lama si chiusero alle nostre spalle, Tenzin Taklha e io ci incamminammo lungo l’ampio percorso di cemento fino al complesso della sala delle udienze, dove avevano avuto luogo tutti i miei colloqui con il leader tibetano. Girammo intorno al complesso e a una piccola sala destinata al canto sacro e poi attraversammo una fitta macchia di alberi. Dietro di essa vi erano giardini e il bell’edificio a due piani dove il Dalai Lama dorme e medita. Era la prima volta che mi spingevo così lontano all’interno del recinto.
Un soldato indiano con un’arma automatica sorvegliava l’area esterna all’entrata. Un altro indiano, un uomo in abiti borghesi, con i lembi bianchi della camicia che gli penzolavano fuori dai pantaloni, ci guardò impassibile. Tre o quattro guardie del corpo tibetane
camminavano in silenzio. Quando ci fermammo davanti alla casa mi sentii a disagio, un intruso nel più recondito santuario del Dalai Lama.
Con perfetto tempismo, il leader tibetano uscì dall’edificio, mi scrutò, sorrise e disse: «Ni hao?» nel suo tipico tono baritonale. Con me ama usare il saluto cinese. Dopo avermi stretto la mano vigorosamente, si avviò per il sentiero che attraversa i giardini. Avanzò velocemente lungo il lieve pendio, per circa cinquanta metri, e poi si girò. Ridacchiava mentre mi veniva incontro; si stava mettendo in mostra. Alcuni mesi prima avevamo parlato dell’importanza dell’esercizio fisico. In quella occasione mi confessò che non lo amava e che era terribilmente pigro sotto questo aspetto. Gli feci promettere che avrebbe portato la sua quota giornaliera di prostrazioni da trenta a cento. Adesso era desideroso di mostrarmi quanto prendesse sul serio il suo esercizio mattutino.
A gesti fece segno a Tenzin e a me di seguirlo. Salimmo su una scala esterna di cemento fino al luminoso secondo piano, un ampio spazio aperto con alcuni comodi divani e poltrone sparsi qua e là. Tappeti orientali coprivano parte del parquet e l’intera parete di destra era occupata da finestroni alti fino al soffitto. Potevo vedere il profilo affilato della valle di Kangra digradare, le cime dei monti addolcirsi sotto la luce dell’alba.
Poi il Dalai Lama ci condusse nella sua sala di meditazione.
![]()
2
Due monaci al balcone
La sala di meditazione del Dalai Lama era inondata dalla tenue luce del mattino. Lungo la parete erano disposte vetrinette di legno accuratamente intagliato; al loro interno potevo vedere numerose statuette di bronzo e un’infinità di manufatti religiosi. Pile di testi sacri avvolti in stoffa gialla e ricchi broccati erano ordinatamente disposte su scaffali fatti su misura. Nel centro della stanza troneggiava un altare riccamente ornato. Una statua, alta non più di sessanta centimetri, racchiusa in un tempio in miniatura di vetro e legno, occupava il posto d’onore. Lo spazio era di un’eleganza sobria, sontuoso e al tempo stesso semplice.
Tenzin Taklha mi fece cenno di sedermi vicino all’ingresso su un piccolo tappeto quadrato tibetano. Sistemai la mia videocamera su un treppiede. Senza dire una parola, il Dalai Lama andò dietro la sua semplice scrivania di mogano. Si sfilò le infradito di plastica e sedette nella posizione del loto, con la schiena appoggiata alla parete rivestita di legno. Si sistemò le vesti, chiuse gli occhi e iniziò a meditare. Accesi la videocamera e ne udii il debole ronzio mentre catturava le immagini in digitale del monaco tibetano.
Il Dalai Lama mi aveva raccontato qualcosa sulle sue abitudini mattutine: «Appena mi sveglio, in questi giorni esattamente alle tre e trenta, recito alcuni mantra o delle preghiere. Il mio primo pensiero: il Buddha e il suo insegnamento di compassione, di interdipendenza. Ecco che cosa faccio sempre... tutte le mie giornate sono improntate a questi due principi: altruismo e interdipendenza. Poi qualche prostrazione. Cerco di fare contemporaneamente prostrazioni e qualche esercizio, per circa trenta minuti. Dopo faccio sempre il bagno o la doccia. Poi intorno alle cinque o talvolta alle quattro e quaranta la colazione. Mio fratello minore mi prende sempre in giro: il vero scopo dell’alzarsi presto è la colazione. Normalmente, essendo un monaco buddhista, niente pasto serale».
Quando il Dalai Lama cominciò la sua meditazione, i miei occhi si adattarono alla luce fioca. Dall’altra parte della stanza, proprio di fronte a me, c’era una parete dipinta, protetta da una lastra di vetro. Mostrava la figura di un Buddha con semplici vesti color ocra, sullo sfondo c’erano lussureggianti montagne verdi e insenature serpeggianti. La testa del Buddha aveva le proporzioni tradizionali, con i lobi delle orecchie allungati e una protuberanza sul capo che simboleggia l’illuminazione. Aveva uno sguardo indefinibile, sorridente e calmo allo stesso tempo. Tutto il volto – le guance leggermente paffute, il piccolo mento, gli occhi – trasmetteva un senso di gioia nascente.
Il Dalai Lama aveva chiaramente raggiunto, molto rapidamente, una sorta di profondo stato interiore. Al suo esterno non esisteva più nulla: né la stanza, né Te...