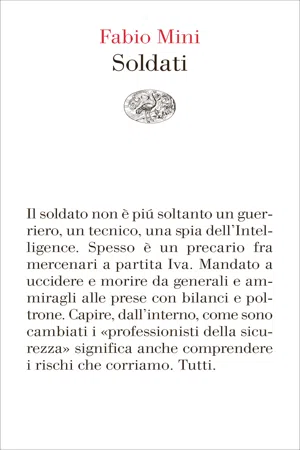![]()
La scoperta di un altro mondo è sempre importante, e fa piacere aver fatto parte dell’equipaggio che l’ha favorita. Ma scoprire non è capire. Anzi, un nuovo mondo è sempre denso d’incognite e di paure. Anche se il mondo dei soldati comprende tutti e il loro tempo coinvolge tutti, è difficile capirli e accettarli. Perché il mondo dei soldati è quello della guerra, e il tempo dei soldati, per definizione, è il tempo della guerra. Oggi non siamo in tempo di guerra, perché non è vero che tutto il mondo è in guerra, e forse mai come oggi ci sono state poche guerre e soprattutto pochissimi conflitti internazionali. Fatichiamo a considerare nostre perfino le guerre che vediamo e combattiamo. Le guerre per le risorse non ci appartengono, anche se viviamo di risorse. Le guerre di civiltà non ci toccano proprio perché preferiamo non abbandonare la nostra civiltà, che è fatta di rispetto di se stessi e quindi degli altri. La stessa guerra al terrorismo non ci appartiene se finisce per far decadere i nostri valori di libertà e democrazia e fa prevalere l’ingiustizia, l’odio e la barbarie.
È, invece, il tempo della guerra, perché in questi ultimi anni essa è diventata l’idea portante di ogni attività umana, di ogni posizione politica, di ogni prospettiva futura. La guerra pervade il pensiero e lo monopolizza. Invade la politica, la diplomazia, assorbe l’economia e blocca ogni attività che non sia utile o strumentale a essa. Blocca lo stesso pensiero della pace, ne ammutolisce gli attivisti e, per fortuna, azzera anche coloro che della pace hanno fatto zimbello trasformandola in una ideologia estremista e consentendo che diventasse elusione, alibi e giustificazione della guerra.
La guerra non si limita piú a essere lo strumento o la prosecuzione della politica cosí cara a Carl von Clausewitz, ma ne è diventata la rivelazione, la giustificazione e persino la sostituzione. Non è piú neppure limitata e selettiva. Che sia simmetrica, come nei rari casi di guerre tra Stati, o asimmetrica, come la guerra preventiva, le guerre intrastatali, etniche, di religione e il terrorismo, è sempre devastante. È dominata dal principio dell’eccesso di potenza e di capacità distruttiva in relazione agli obiettivi da colpire. Un eccesso che nel caso del terrorismo tende ad amplificare l’effetto del terrore, mentre con la guerra preventiva e tecnologica occidentale deve difendere l’uomo del nostro tempo dall’ansia, dall’incertezza, dalla frustrazione e dalla paura. Tutte cose che stanno dentro di noi ma che vengono scatenate da chiunque o qualunque cosa non si capisca. E allora la nostra guerra si rivolge contro tutti gli «estranei» e viene spacciata per manifestazione di civiltà e voglia di vivere.
Ernst Junger1 individuò sulla Somme, nei combattimenti della Prima guerra mondiale, i luoghi dove
per la prima volta vide la luce la guerra che corrisponde al nostro tempo, e in cui l’arte della guerra aveva recuperato quella distanza che attraverso un lungo periodo privo di esperienze l’aveva distaccata dalle altre manifestazioni della nostra volontà di vivere. Vediamo gli uomini migliori di tutti i popoli aggirarsi in un paesaggio indicibilmente triste, esposti nei campi crivellati di crateri tra brandelli di trincee e villaggi distrutti dai bombardamenti all’azione di una guerra che nell’espressione «guerra di produzione» trova la propria migliore definizione2.
La guerra che oggi si combatte tra le idee, le percezioni e i risentimenti, oltre che sui campi di battaglia, continua a prendere le distanze dai suoi stessi fini dichiarati e da ogni altra manifestazione della volontà di vivere. Persino dalla pace, che è l’aspirazione piú alta di tale volontà.
Invece di adottare strategie ed eserciti idonei alle nuove sfide, non si è trovato di meglio che adeguare la guerra ai vecchi strumenti avviando l’ennesima guerra globale contro il Male Assoluto di turno e facendo coincidere il nostro tempo con un altro che si pensava finito: il tempo della Paura. L’arte della guerra ha cercato di «recuperare» la distanza con la realtà ricorrendo alle asimmetrie della guerra preventiva ideologizzata ed estremizzata, delle forme piú subdole di strategia indiretta e del terrorismo. Con il risultato di ottenere un’altra cosa che non era riuscita neppure alle teorie dello scontro nucleare: l’assorbimento da parte della guerra di ogni risorsa umana, intellettuale e materiale.
Ecco perché si è ristabilito il tempo della guerra e si è affermata la sua nuova liturgia di conflitto permanente e asimmetrico. E perché vale oggi piú che mai il monito di Gerhard von Scharnhorst, il riformatore dell’esercito prussiano dopo la disfatta del 1806: «Abbiamo iniziato a valutare l’arte della guerra piú delle virtú militari; ciò ha significato, in ogni tempo, il tramonto dei popoli»3.
Questo tempo della guerra durerà a lungo, perché la guerra continua a staccarsi dal nostro tempo, ma non c’è nessuna voglia di isolarla, limitarla e farla morire d’inedia. Si tende invece a inseguirla, e la rincorsa, favorita dalla strategia della paura, è ormai diventata un condizionamento mentale collettivo. Una nuova droga, una nuova schiavitú. Alla Guerra in Iraq e alla sua «arte» preventiva va il primato di aver riaperto il divario tra la guerra e gli ideali dell’uomo del nostro tempo. Questa guerra, che per molti versi celebra l’apoteosi e il declino della tecnologia e della postmodernità, non corrisponde affatto al nostro tempo che sta maturando il bisogno di pace all’insegna di una sicurezza che salvaguardi la civiltà, l’umanità e la dignità. Eppure essa alimenta tutte le ideologie, gli interessi e i relativi -ismi che oggi muovono l’economia, i rapporti internazionali, lo sviluppo e perfino una certa pax. Per correggere questa tendenza, ci vorrebbe la consapevolezza che invece di produrre forza ci stiamo abituando alla schavitú. Piú che i muscoli contratti dalla paura ci vorrebbero quelli tesi a romperne le catene. Piú delle ideologie che ci sclerotizzano e dividono ci vorrebbero idee nuove che ci aprano la mente e uniscano. Ma, per ora, non ci sono. Però ci sono i soldati.
1. Il paradosso della guerra umanitaria.
Oggi ogni esercito misura la propria capacità operativa nelle missioni all’estero. Non esiste altro, e per nostra fortuna e disgrazia, è vero. Per fortuna perché non c’è la guerra a casa nostra; per disgrazia perché si rischia e si muore per le ragioni o i torti degli «altri», per soddisfare o negare le ambizioni di gente che vive e pensa in altri mondi e altri modi.
Contrariamente a quanto si possa pensare, l’Italia ha una lunga tradizione di missioni militari all’estero. Per decenni ha intrapreso missioni per sostenere una politica estera equilibrata che rispettava gli impegni delle alleanze senza scadere nel servilismo, e che assumeva iniziative a sostegno degli interessi nazionali nonostante i veti degli alleati di turno. Senza partire dalla spedizione di Crimea o da quella contro i Boxer in Cina e senza rivangare quelle coloniali di prima e dopo l’avvento del fascismo, già dall’immediato secondo dopoguerra le nostre forze armate hanno preso parte alla Guerra di Corea e a decine di missioni Onu: da quella in Sinai a quelle in Libano, in Pakistan e in Congo, dove nel 1961 abbiamo perso i tredici aviatori trucidati a Kindu. Abbiamo svolto missioni di cooperazione militare e di addestramento collaborando alla sicurezza di Malta (missione ancora in corso), fornendo armi e «consiglieri militari» al regime di Siad Barre in Somalia, a quello di Gheddafi in Libia e dando supporto di elicotteri al regno del Marocco.
Quando alla fine degli anni Ottanta si cominciò a parlare di missioni militari italiane all’estero come «nuova» prospettiva d’impiego, la novità era ancora piú relativa, perché il ricordo delle due missioni in Libano (1982-84) guidate, la prima, dal tenente colonnello Tosetti e, la seconda, dal generale Angioni era ancora vivo. L’effetto Libano durava sull’opinione pubblica e si rifletteva positivamente sul reclutamento degli ufficiali e perfino di quei pochi volontari che la legge autorizzava. Durava il senso epico di qualcosa che andava fatto non per calcolo o per politica d’interessi nascosti e inconfessabili, ma per un dovere d’intervento politico e umanitario e una nascente vocazione alla solidarietà. Una vocazione che sarebbe aumentata nel decennio successivo e che sarebbe notevolmente scemata nei soldati italiani come in quelli di mezzo mondo man mano che veniva piegata ai fini politici e alla logica della instabilità. Durava il senso, rimasto invariato fino a oggi, di aver compiuto un buon lavoro, nonostante che molte missioni internazionali non abbiano dato i risultati sperati e che in una di esse, in Somalia, alcuni soldati italiani si siano comportati in modo vergognoso.
L’impegno italiano attuale nelle missioni militari all’estero viene giustificato con la partecipazione alla guerra globale al terrorismo iniziata dopo l’11 settembre 2001.
Si pensa che tutto sia cominciato a New York in quel giorno disastroso, ma non è cosí. Se proprio si vuole stabilire un inizio alla trasformazione che ha portato l’Italia a diventare la terza nazione al mondo per numero di militari inviati all’estero, si deve partire almeno dal 1989. Tra quell’anno e il 2001 si sono sviluppati tutti gli eventi che in qualche modo hanno drammaticamente preparato quelli che oggi stiamo vivendo con ansia e affanno. Nel 1989 la nomina di Michail Sergeevič Gorbačëv a presidente dell’Urss fa pensare alla vittoria della sua Perestrojka, ma in realtà accelera il processo di dissoluzione che diventa irreversibile con l’abbattimento del Muro di Berlino. Nel 1989 la protesta di Tiananmen in Cina porta alla brusca revisione delle prospettive di libertà, e il regime comunista si consolida in un insolito mix di capitalismo, avventurismo, paternalismo e autoritarismo. Nel 1989 finisce la Guerra fredda, e nonostante ci sia un solo vincitore, sono molti, troppi, a reclamare una parte del bottino. La Nato ha «vinto» e vuole espandersi; Saddam Hussein, per aver combattuto contro l’Iran in nome e per conto dell’Occidente, ritiene di essere uno dei vincitori e vuole il Kuwait; Slobodan Milošević, per aver ereditato una Iugoslavia che aveva siglato decine di accordi segreti con gli Stati Uniti e per essere stato rappresentante della Banca mondiale, pensa di aver vinto, e da Kosovo Polje vuole imporre il nazionalismo serbo. Tutte le nazioni dell’Est europeo e le stesse repubbliche caucasiche si sentono vincitrici per il solo fatto di essere state oppresse da Mosca e reclamano qualcosa. Dopo quattro guerre (Bosnia, Serbia e due in Iraq) e cinque missioni di peacekeeping, l’Iraq e i Balcani non sono ancora stabilizzati e i paesi caucasici sono in conflitto permanente. Nel 1989 si apre anche l’èra del moderno terrorismo islamico. La fine dell’invasione sovietica in Afghanistan dichiara la vittoria dei mujahiddin e inaugura il ciclo di al-Qaeda. E quando la Guerra del Golfo del 1990-91 porterà un altro esercito straniero ad attaccare un paese islamico e a insediarsi in Arabia Saudita, sullo stesso suolo sacro dell’islam, la lotta dei mujahiddin di al-Qaeda si rivolge contro gli stessi statunitensi che li avevano sostenuti.
Nel 1993 vengono attaccate per la prima volta le Torri gemelle del World Trade Center di New York; nel 1997 i talebani, con il supporto del Pakistan e di al-Qaeda, conquistano Kabul; nel 1998 al-Qaeda fa saltare in aria le ambasciate statunitensi di Dar es Salaam e Nairobi, e nel 2000 è la volta della nave militare Uss Cole. L’11 settembre 2001 è quindi la tappa successiva di un percorso quasi scontato, e le guerre in Afghanistan e Iraq imprimeranno al terrorismo una spinta evolutiva molto piú efficace di quella che l’arte della guerra sarà in grado di dare alla lotta al terrorismo stesso. Se la struttura organizzativa di al-Qaeda viene colpita e dispersa, quella ideologica acquisisce nuovi seguaci e fa propria la stessa teoria dello scontro di civiltà inventata in Occidente per giustificare la guerra globale. La risposta occidentale è soltanto la guerra, ma non quella nuova che la situazione richiederebbe e che nessuno ha ancora saputo individuare nonostante le indicazioni di pochi e onesti studiosi come i colonnelli cinesi Qiao Liang e Wang Xiangsui4, ma quella vecchia, tecnologica e pur sempre tradizionale, nella sua anacronistica e ottusa linearità.
Mentre da un lato si militarizza un conflitto che non risponde a nessuna logica militare, e mentre lo si statalizza pensando di restringerlo entro confini lineari e comprensibili, dall’altro la struttura operativa del terrorismo si frammenta ed espande, ricorre indifferentemente a strumenti e logiche primordiali e alla tecnologia, supera le nazioni e gli Stati e si nutre di ogni possibile motivo di adesione anche temporaneo e distante dagli scopi del nucleo originale. Gli attentati di Madrid e Londra sono i segnali piú crudi di questa svolta nei riguardi dell’Occidente. Ma la massa degli attentati terroristici continua a colpire gli stessi islamici con rinnovata ferocia e forza destabilizzatrice. Si pensa anche che le nostre missioni militari abbiano espresso una qualche unitarietà politica e che siano sempre state ordinate o coordinate dalla Nato con l’avallo delle Nazioni Unite. In realtà, le missioni piú importanti degli ultimi quindici anni hanno accentuato le spaccature interne e internazionali, e sono avvenute al di fuori e talvolta in barba all’alleanza atlantica e persino senza il consenso delle Nazioni Unite. La Guerra del Golfo (1990) era una coalizione extra-Nato, come Airone di Provide Comfort nel Kurdistan iracheno (1991), Pellicano in Albania (1991-93), Ippocampo in Ruanda (1994), Alba in Albania (1997), Interfet a Timor Est (1999), Isaf in Afghanistan (dal 2002 al 2006), Enduring Freedom in Afghanistan (dal 2003), Antica Babilonia in Iraq (2003-6).
Soltanto nei Balcani siamo intervenuti con la Nato, che ormai da anni è soggetta a pressioni degli Stati Uniti al limite degli insulti. Lo abbiamo fatto con la guerra, sempre in ritardo sulle vere catastrofi umanitarie e sempre per prevenirne di presunte se non proprio di improbabili, ma provocandone altre. Con l’Onu, oltre alle missioni di «osservatori», siamo stati (e in alcune parti ancora siamo) soltanto in Libano, Namibia, Afghanistan, Somalia, Mozambico e Sudan. In realtà, le Nazioni Unite non hanno mai unito le nazioni, e gli Stati Uniti rafforzano la propria unità sfasciando qualsiasi alleanza ingombrante e preferendo le coalizioni ad hoc nelle quali esercitano la leadership totale. La stessa emergenza globale del terrorismo, che si tenta di far passare come unificatrice del mondo occidentale, ha prodotto due guerre (Afghanistan e Iraq) alle quali molti alleati non hanno voluto partecipare. La stessa Nato, dopo il beau geste della dichiarazione dell’articolo 5 (difesa collettiva) per l’11 settembre, si è dovuta accontentare di fornire supporti marginali: gli americani volevano l’adesione politica e il comando operativo senza interferenze.
Il controllo della Nato su Isaf, iniziato formalmente nel 2006 e che ha portato all’espansione militare straniera in tutto l’Afghanistan e alla confusione della missione di assistenza internazionale con la guerra americana ai talebani (Enduring Freedom), è stato il risultato di un misto di furbizia e sottovalutazione. Da un lato, la Nato accettava l’imposizione americana di assumere il comando formale dell’operazione (assunto di fatto senza alcuna autorizzazione dell’Onu a partire dal 2003) per dare un senso a uno dei suoi comandi regionali da anni sottoimpiegato; dall’altro, sia la Nato sia gli americani pensavano che la situazione fosse sotto controllo. Sembrava sfuggire che, nel momento dell’espansione della missione della Nato (2005), oltre la metà dell’Afghanistan era tornato sotto il controllo pashtun-talebano, e che gli attacchi contro le forze straniere erano decuplicati. Sembravano sfuggire le inefficienze, le responsabilità e la corruzione dei regimi «amici e democratici» che dall’Afghanistan e dal Pakistan alimentavano l’instabilità regionale e planetaria.
Ai riti consueti della guerra se ne sono perciò aggiunti dei nuovi tendenti a consacrarla e renderla permanente. Ma sotto altri nomi. Per ipocrisia e per aggirare le limitazioni giuridiche nazionali e internazionali al ricorso alla guerra, si sono escogitate le operazioni diverse dalla guerra e le operazioni speciali non per gli strumenti, ma per i fini. Ogni intervento militare ha comportato la funambolica opera di convinzione nei riguardi delle opposizioni e dell’opinione pubblica sugli scopi, la durata e le risorse da assegnare. La «guerra» del Golfo contro l’Iraq è diventata una «operazione di polizia internazionale». L’operazione Provide Comfort, di sostegno umanitario ai curdi iracheni, era in realtà la premessa per la neutralizzazione dei curdi stessi fortemente voluta dalla Turchia: allora come oggi. L’operazione in Somalia, che doveva prevenire un’emergenza umanitaria, è stata sospesa a dispetto del disastro umanitario e di illegalità che si lasciava sul terreno. La guerra contro la Serbia per la questione del Kosovo è stata giustificata con l’intervento doveroso in un’altra catastrofe umanitaria. In Kosovo è stata re-inventata la guerra umanitaria che, dopo quella santa, è il non-senso piú accettato della storia. Si discute ancora sulla verità della catastrofe, su come si sia arrivati alla guerra per ottenere dai serbi le stesse cose che avevano offerto prima, su come si sia permessa una controcatastrofe umanitaria e su come si stia permettendo che la definizione dello status del Kosovo mandi all’aria il sistema giuridico internazionale al quale tutti comunque fanno riferimento.
La guerra in Iraq per noi italiani è stato l’ultimo esercizio di equilibrismo. Abbiamo fatto parte di una coalizione guidata da due nazioni, Stati Uniti e Gran Bretagna, che sono state dichiarate dalle Nazioni Unite, e con la loro stessa condivisione, potenze belligeranti (in guerra) e potenze occupanti nonché d’invasione. L’occupazione militare, che per il diritto internazionale è una situazione de facto, è continuata con la nostra partecipazione. Quando ce ne siamo distaccati senza manifestare il dissenso nei riguardi della guerra, abbiamo ritenuto di aver assolto la missione, facendo imbestialire ancor di piú tutti gli alleati. In questo fiorire di fantasie lessicali, i soldati, guerrieri per natura, addestramento, equipaggiamento, vocazione o necessità, sono stati trasformati in soldati di pace. La parola guerra è stata bandita o riservata soltanto, e non da tutti, alla lotta al terrorismo, ma piú per giustificare l’uso di strumenti e metodi inadatti che per sconfiggerlo. Il nuovo lessico della guerra ha finito per alterarne la semantica e la grammatica. Le operazioni, che nelle intenzioni primitive dovevano essere rapide e risolutive, sono diventate endemiche e inconcludenti. Gli stati maggiori hanno minimizzato sia verso l’alto sia verso il basso (le forze operative) i rischi e gli scopi reali. Invece di essere i garanti della sicurezza per sé e per gli altri, i militari si sono sostituiti alla Croce rossa, alla Caritas e ai Medici senza frontiere. In qualsiasi teatro operativo si è creata una situazione di scontro permanente fra chi dice di condurre una guerra santa e chi vuole accreditare l’immagine virtuale di non-guerra. Mentre ci confrontiamo con vere e proprie ribellioni armate condotte con mezzi arcaici e terroristici, diciamo di non offendere nessuno e di portare soltanto pace, libertà e democrazia all’insegna della bontà d’animo e della nostra civiltà superiore.
La ...