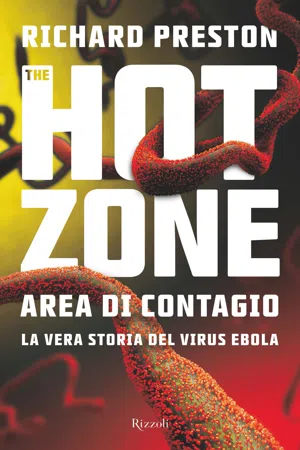![]()
PARTE PRIMA
L’OMBRA DI MOUNT ELGON
![]()
1
QUALCOSA NELLA FORESTA
1980, primo dell’anno
Charles Monet era un solitario. Di nazionalità francese, viveva solo in un piccolo bungalow di legno sul terreno della Nzoia Sugar Factory, una piantagione nel Kenya occidentale che si stende lungo il fiume Nzoia in vista di Mount Elgon, un maestoso vulcano estinto che si erge fino all’altezza di 4270 metri sul limitare della Rift Valley. Non si sa con certezza che cosa avesse portato Monet in Africa. Come per molti altri espatriati che finiscono laggiù, la sua era una storia un po’ oscura. Forse aveva avuto qualche guaio in Francia, o forse era stata la bellezza del paese ad attirarlo laggiù. Era un naturalista dilettante, appassionato di uccelli e di animali ma non dell’umanità. Cinquantaseienne, era di altezza e di corporatura media, con lisci capelli castani; un bell’uomo, nel complesso. Sembrava in rapporti di intima amicizia solo con alcune donne che abitavano nelle città circostanti la montagna, e tuttavia neppure loro seppero ricordare granché sul suo conto quando parlarono con i medici incaricati di indagare sulla sua morte. Allo zuccherificio, Monet era incaricato della manutenzione dei macchinari che dal fiume Nzoia pompavano l’acqua necessaria a irrigare i molti ettari di canna da zucchero. Si dice che passasse buona parte della giornata nella sala pompe sulla riva del fiume, come se gli piacesse guardare e ascoltare il lavoro delle macchine.
Come spesso accade in simili casi, mettere a fuoco i dettagli non è facile. I medici ricordano i sintomi clinici, perché nessuno che abbia visto gli effetti di «un agente caldo» di Quarto Livello su un essere umano potrebbe mai dimenticarli, ma tali effetti finiscono con l’accumularsi l’uno sull’altro, col risultato di cancellare la persona che ne è la vittima. Il caso di Charles Monet appare al nostro esame come un freddo concatenarsi di eventi clinici mescolati a lampi di orrore così vividi e inquietanti da indurci ad arretrare coprendoci gli occhi quasi fossimo di fronte a un offuscato sole alieno.
Monet arrivò nel paese nell’estate del 1979, più o meno all’epoca in cui l’HIV, causa dell’AIDS, lasciò definitivamente le foreste pluviali dell’Africa Centrale per dare inizio alla sua lunga opera di devastazione tra gli uomini. L’AIDS incombeva già come un’ombra minacciosa sulla popolazione del Centrafrica, benché nessuno ne conoscesse ancora l’esistenza. Era andato silenziosamente diffondendosi lungo la Kinshasa Highway, la transcontinentale che percorre il continente da est a ovest e costeggia il lago Vittoria, in vista di Mount Elgon. L’HIV è un agente del Secondo Livello di sicurezza biologica, estremamente letale ma non particolarmente contagioso. Non si trasmette con facilità da individuo a individuo, e non viaggia attraverso l’aria. Non c’è bisogno di indossare una tuta spaziale biologica per manipolare sangue infettato dall’HIV.
Durante la settimana, Monet lavorava sodo in sala pompe, mentre i weekend e i giorni festivi li passava a perlustrare le aree boscose nei pressi dello zuccherificio. Portava sempre un po’ di cibo con sé, e dopo averlo sparpagliato in giro gli piaceva starsene a osservare gli uccelli e gli animali che se ne nutrivano. In presenza di un animale, era capace di restare perfettamente immobile. Quelli che lo conoscevano, ricordarono in seguito che prediligeva le scimmie selvatiche, a cui riservava un trattamento di favore. Amava mettersi seduto con qualche buon boccone in mano, e aspettare che la scimmia si avvicinasse per mangiargli nel palmo.
Le sere, le trascorreva in solitudine nel suo bungalow. Aveva una governante, una donna di nome Johnnie, che gli preparava i pasti e gli puliva la casa. Monet stava imparando a conoscere gli uccelli africani. In un albero vicino al suo bungalow viveva una colonia di tessitori e lui passava parecchio tempo a guardarli costruire o riparare i loro nidi simili a cesti intrecciati. Si dice che poco prima di Natale si portò a casa un uccello malato che poi morì, forse proprio nelle sue mani. L’uccello potrebbe essere stato un tessitore – nessuno lo sa – e forse morì a causa di un virus di Quarto Livello – nessuno lo sa. Monet era inoltre amico di una cornacchia screziata, una cornacchia bianca e nera di quelle che a volte gli africani si divertono ad addomesticare. Era un uccello intelligente e socievole, a cui piaceva appollaiarsi sul tetto del bungalow di Monet e da lì osservare i suoi andirivieni. Quando aveva fame, la cornacchia planava sulla veranda ed entrava in casa, dove lui la nutriva con pezzetti di cibo presi dalla sua tavola.
Per arrivare sul posto di lavoro, percorreva ogni giorno cinque chilometri attraverso le coltivazioni di canna da zucchero. Nella stagione natalizia, i braccianti avevano dato fuoco ai campi che ora apparivano neri e spogli. Quaranta chilometri più a nord, oltre quel desolato paesaggio, erano visibili le vette gemelle di Mount Elgon. Sulla montagna il clima era perennemente mutevole, e sole e pioggia si alternavano con giochi di luce e ombra tipicamente africani. All’alba, Mount Elgon era una cascata di crinali grigi seminascosti dalla foschia mattutina e culminava in due cime, i due bordi contrapposti del cono eroso dal tempo. Col levarsi del sole, la montagna assumeva una tonalità verde argentea, il colore della foresta pluviale di Mount Elgon, e a mano a mano che il giorno avanzava, comparivano le nubi che la celavano alla vista. Nel tardo pomeriggio, più o meno all’ora del tramonto, le nubi si addensavano e ribollivano in un cumulonembo a forma di incudine solcato da lampi silenziosi. La parte inferiore delle nuvole era color carbone, mentre la parte superiore, illuminata dal sole calante, riluceva di un arancio smorto. Sopra di esse, il cielo era di un azzurro intenso, baluginante di rade stelle tropicali.
Monet contava parecchie amiche nella cittadina di Eldoret, a sudest della montagna. Qui la gente è povera e vive in baracche di assi di legno e lamiera, e le sue amiche erano ben felici di amarlo in cambio del denaro che ricevevano. All’arrivo delle vacanze natalizie, Monet progettò di andare ad accamparsi su Mount Elgon e invitò una di loro ad accompagnarlo. Pare che nessuno ora ne ricordi il nome.
A bordo di una Land Rover, Monet e la sua amica risalirono la strada lunga e diritta che conduce a Endebess Bluff, una rupe che si staglia sul lato orientale del vulcano. La strada, di terra vulcanica, aveva il colore del sangue secco. Si inerpicarono sulle falde più basse del vulcano e attraversarono campi di granturco e piantagioni di caffè a cui andarono gradatamente sostituendosi terreni da pascolo, quindi la strada prese a snodarsi davanti alle rovine di fattorie coloniali inglesi nascoste da filari di eucalipti. A mano a mano che salivano, l’aria si faceva più fredda, e nel cielo si libravano le aquile reali. Non sono molti i turisti che visitano Mount Elgon, e probabilmente quello di Monet e della sua amica era l’unico veicolo a motore che procedesse sulla strada brulicante di viandanti, in gran parte abitanti di villaggi vicini che coltivavano piccoli appezzamenti di terra sui pendii più bassi. Raggiunsero il bordo esterno della foresta pluviale di Mount Elgon, passando accanto a folte macchie e isole d’alberi, poi oltrepassarono il Mount Elgon Lodge, un albergo costruito dagli inglesi nei primi anni del secolo e ora in rovina, con le mura piene di crepe e la vernice scrostata dal sole e dalla pioggia.
Mount Elgon sta a cavalcioni del confine tra Uganda e Kenya, e non è molto lontano dal Sudan. Presa come entità a se stante, la montagna è un’isola biologica di foresta pluviale nel cuore del continente africano, un mondo isolato che svetta oltre aride piane, largo ottanta chilometri e ricoperto di alberi, bambù e vegetazione alpina. È una delle vertebre della spina dorsale del Centrafrica. Il vulcano si formò dai sette ai dieci milioni di anni fa, e le violente eruzioni ed esplosioni di cenere che ripetutamente spazzarono via le foreste di cui i pendii erano coperti, lo portarono a raggiungere un’altezza smisurata, forse superiore a quella odierna del Kilimanjaro. Prima che avesse inizio il processo di erosione, Mount Elgon era forse la cima più alta di tutta l’Africa, ed è ancora la più imponente. Sorgendo, il sole proietta a ovest fino in Uganda la sua ombra, mentre al tramonto l’ombra si allunga a est, attraverso il Kenya. Attorno al Mount Elgon si stendono i villaggi abitati dagli Elgon Masai, una popolazione dedita alla pastorizia discesa dal nord parecchi secoli addietro. I pendii più bassi sono bagnati da piogge leggere, l’aria è sempre fresca e limpida, e il terreno vulcanico garantisce ricchi raccolti di granturco e di erba da pascolo, assicurando la sopravvivenza a una densa popolazione umana. I villaggi sono disposti ad anello intorno al vulcano, un anello che soffoca la foresta e si è ormai tramutato in un cappio che sta strangolando l’ecosistema della montagna. Nella foresta si aprono chiazze di desolazione, gli alberi giganteschi vengono tagliati per ricavarne legna da ardere e fare spazio al bestiame, mentre gli elefanti lentamente scompaiono.
Una piccola parte di Mount Elgon è stata trasformata in parco nazionale. Monet e la sua amica si fermarono ai cancelli per pagare l’ingresso. Una scimmia, forse un babbuino – nessuno lo ricordava con precisione – era solita gironzolare lì intorno nella speranza di ricevere qualche boccone, e Monet convinse l’animale ad appollaiarsi sulla sua spalla offrendogli una banana. La sua accompagnatrice rise, ma entrambi rimasero perfettamente immobili mentre l’animale mangiava. Percorsero quindi un breve tratto in salita e piantarono la tenda in una radura di erba verde e umida che digradava verso un corso d’acqua. Il torrente, che sbucava gorgogliando dalla foresta, era di uno strano colore lattiginoso, dovuto alla presenza di terra vulcanica. La crescita dell’erba era tenuta sotto controllo dai bufali cafri, di cui si vedevano qua e là mucchi di escrementi.
Intorno a loro si stendeva la foresta pluviale di Elgon, una ragnatela di corrosi olivi africani, ricoperti di muschio e rampicanti, e carichi di olive velenose per gli esseri umani. Udirono fruscii di scimmie e ronzii di insetti. Frotte di piccioni delle olive erompevano dagli alberi saettando verso terra a velocità spaventosa, secondo la strategia adottata per sfuggire ai rapaci che scendono su di loro in picchiata e lacerano loro le ali. C’erano alberi della canfora e del teak, cedri africani e ocotee rosse, e più in là nubi di foglie verdescuro si allargavano a fungo al di sopra della volta frondosa. Erano le chiome degli alberi godo, i più grandi di tutta l’Africa, grandi quasi quanto le sequoie californiane. Allora, vivevano sulla montagna migliaia di elefanti, ed era frequente sentirli che si aggiravano nella foresta, strappando la corteccia e i rami dagli alberi con rumori schioccanti. I colobi saettavano sul prato nei pressi della tenda, osservando i due umani con occhi vivi, sagaci.
Nel pomeriggio avrebbe piovuto, come sempre accadeva su Mount Elgon, e loro sarebbero rimasti sotto la tenda, e forse avrebbero fatto l’amore mentre il temporale infuriava tutt’intorno. Si fece buio; cominciò a cadere la pioggia. Monet e la sua amica accesero il fuoco e prepararono da mangiare. Era la vigilia di Capodanno, e forse festeggiarono bevendo champagne. Le nubi si sarebbero diradate di lì a poche ore, come sempre accadeva, e infine il vulcano sarebbe emerso come un’ombra nera sotto la Via Lattea. Forse, allo scoccare della mezzanotte Monet era sul prato, e contemplava le stelle… la testa piegata all’indietro e un po’ incerto sulle gambe per via dello champagne.
La mattina di Capodanno, una mattinata fredda – non c’erano più di cinque gradi e l’erba era gelata – subito dopo colazione Monet e la sua amica risalirono la pista fangosa e si fermarono in una piccola vallata sottostante la Kitum Cave.
Dopo quella gita, la donna scomparve per parecchi anni, per ricomparire inaspettatamente in un bar di Mombasa, dove faceva la prostituta. Un medico keniota che si era occupato del caso Monet, capitò nel locale a bere una birra e chiacchierando del più e del meno con lei, gli capitò di fare il nome di Monet. Rimase stupefatto quando la donna rispose: «Sì, so chi era. Vengo dal Kenya occidentale; sono io la donna che era con Charles Monet». Poiché il dottore appariva scettico, gli raccontò l’intera storia in modo così dettagliato da convincerlo che stava dicendo la verità. Dopo quell’incontro, la donna svanì di nuovo nei ghetti di Mombasa, e a quest’ora è probabilmente morta da tempo di AIDS.
Monet e la sua amica si aprirono la strada a colpi di machete su per la vallata che conduceva a Kitum Cave, seguendo le piste tracciate dagli elefanti nei pressi di un piccolo corso d’acqua che correva tra folti di olivi e prati erbosi. Procedevano stando allerta, sempre timorosi di vedersi comparire davanti un bufalo cafro, animale pericoloso da incontrare nella foresta. La bocca della grotta si trovava in cima alla vallata, e proprio davanti a essa precipitava a cascata il corso d’acqua. La pista degli elefanti continuava all’interno, e anche Monet e la sua amica entrarono, per trascorrere nella grotta l’intera giornata di Capodanno. Probabilmente piovve, ed è probabile che siano stati costretti a restare per ore seduti all’imboccatura, avviluppati nella nebbiolina leggera sprigionata dall’acqua del torrentello. Spiarono il passaggio di bufali cafri, al di là della vallata, e videro le procavie – animaletti pelosi delle dimensioni di una marmotta americana – saettare fra i macigni nei pressi dell’imboccatura della caverna.
C’erano anche gli elefanti. Sono molti i pachidermi che entrano di notte a Kitum Cave per procurarsi minerali e sali. Infatti, nelle pianure non hanno difficoltà a trovare il sale necessario nelle pozze prosciugate e nei terreni duri non dissodati, ma nella foresta pluviale il sale è raro quanto prezioso. La grotta è abbastanza grande da ospitare almeno settanta elefanti, che di solito vi trascorrono la notte, sonnecchiando in piedi o scavando la roccia con le zanne. Ne staccano grossi pezzi dalle pareti e con i denti li riducono in frammenti che poi ingoiano. Gli escrementi di elefante visibili intorno a Kitum Cave sono pieni di roccia sbriciolata.
Monet e la sua amica avevano una torcia elettrica, e con quella si inoltrarono nella grotta per saggiarne la profondità. La sua imboccatura è enorme, larga almeno cinquanta metri, e al di là di essa la grotta si amplia ulteriormente. Attraversarono un tratto coperto di escrementi secchi d’elefante, che loro calpestarono sollevando nuvolette polverose. La luce impallidì e il suolo si sollevò in una serie di sporgenze coperte di limo verde. Era guano di pipistrello, per la precisione sostanze vegetali digerite ed espulse da una colonia di megachirotteri che popolava la volta.
I piccoli mammiferi sbucavano dalle cavità dei muri per svolazzare attorno al fascio luminoso della torcia e alle loro teste, emettendo grida stridule. La luce li disturbava e il loro frenetico volteggiare destava i compagni ancora addormentati. Centinaia di occhietti rossi come rubini scrutavano i due intrusi dal soffitto della grotta. Onde di strida si riverberavano attraverso il soffitto strappando innumerevoli echi, squittii simili al cigolio di innumerevoli piccole porte. Poi videro il prodigio racchiuso in Kitum Cave, che è, infatti, una foresta pluviale pietrificata. Tronchi fossilizzati sporgono dalle pareti e dal soffitto; alberi della foresta pluviale tramutati in pietra… alberi di teak, podo, sempreverdi. Circa sette milioni di anni addietro, un’eruzione ridusse in cenere l’intera foresta, e trasformò i tronchi in pietra silicea e opale. Li circondavano cristalli, candidi aghi di minerali scaturiti dalla roccia. Erano aguzzi come aghi ipodermici e splendevano nella luce della torcia.
Monet e la sua amica vagabondarono per la grotta, rischiarando particolari della foresta pietrificata. Lui forse passò le mani sugli alberi di pietra o sfiorò con le dita un cristallo? Videro ossa pietrificate sporgere dal soffitto e dalle pareti. Ossa di antichi ippopotami, di coccodrilli e di antenati di elefanti. Fra i tronchi fluttuavano ragnatele, e i ragni divoravano falene e insetti.
Arrivarono a un leggero rialzo, nel punto in cui la sala principale si allargava fino a misurare un centinaio di metri – diventando, cioè, più larga di quanto un campo di calcio sia lungo. Trovarono un crepaccio e proiettarono al suo interno la luce della torcia. C’era qualcosa di strano laggiù… una massa grigia e brunastra. Erano i cadaveri mummificati di piccoli di elefante. I pachidermi si inoltravano nella grotta di notte, orientandosi con il tatto, sondando il terreno con la punta della proboscide, e a volte capitava che i piccoli precipitassero nell’ampia fenditura.
Monet e la sua amica si spinsero ancora più oltre, discesero un pendio e giunsero infine a un pilastro su cui sembrava poggiare l’intero soffitto. Era coperto di graffi e intaccature lasciati dalle zanne degli elefanti che ne avevano scavato la roccia tutt’intorno e l’avevano masticata per estrarne i sali. Se avessero continuato nella loro opera di scavo, il pilastro avrebbe finito per crollare, trascinando nella caduta il soffitto di Kitum Cave. Sul fondo della grotta, ne trovarono un altro, ma spezzato e coperto da una massa vellutata di pipistrelli. L’avevano imbrattato di guano nero, non verde, perché questi erano mangiatori di insetti, e i loro escrementi erano una melma di insetti digeriti. Monet forse li toccò? I ricercatori che studiarono il caso presero in considerazione la possibilità che lui e la sua amica si fossero spogliati e avessero fatto l’amore lì, in piedi o sdraiati. Non fu mai possibile, tuttavia, appurarlo con certezza. È certo però che, se Monet si denudò all’interno della caverna, espose al rischio di infezione una larghissima parte di epidermide.
Charles Monet tornò al suo lavoro nella sala pompe allo zuccherificio e continuò ad attraversare quotidianamente i campi bruciati, senza dubbio ammirando l’imponente spettacolo offerto da Mount Elgon e forse, quando le nuvole lo nascondevano, ne avvertì ancora l’attrazione, simile alla forza di gravità di un pianeta invisibile. Nel frattempo, qualcosa si andava riproducendo dentro di lui. Una forma di vita aveva fatto di Charles Monet il suo ospite, e si moltiplicava nel suo organismo.
Le emicranie cominciarono il settimo giorno successivo all’esposizione all’agente. Sette giorni dopo la gita a Kitum Cave, ossia l’8 gennaio 1980, Monet avvertì un pulsare doloroso dietro i bulbi oculari. Decise di non andare al lavoro e se ne tornò a letto. Il mal di testa peggiorò. Gli dolevano gli occhi e quando il dolore raggiunse le tempie, fu come se un cerchio gli serrasse la testa dall’interno. L’aspirina non bastò a debellarlo, e anzi, col passare delle ore, si aggiunse anche un forte mal di schiena. La sua governante, Johnnie, era ancora in vacanza, e Monet aveva da poco assunto una sostituta che lo assistette come poté, ma senza risultato. Poi, tre giorni dopo l’insorgere del mal di testa, Monet fu aggredito dalla febbre e da una forte nausea. I conati continuarono a squassarlo anche quando non ebbe più nulla da rigettare, e contemporaneamente subentrò in lui una strana passività. Il suo viso perse ogni vitalità e si tramutò in una maschera priva di espressione in cui gli occhi brillavano fissi e vitrei. Le palpebre, ora leggermente cascanti, gli davano un aspetto singolare, quasi che gli occhi fossero semichiusi e al tempo stesso sul punto di strabuzzare. Gli stessi bulbi oculari sembravano come congelati nelle orbite ed erano diventati rosso vivo. Il volto assunse una tonalità giallastra che lo rendeva straordinariamente simile al formaggio Limburger, e si riempì di macchioline rosse a forma di st...