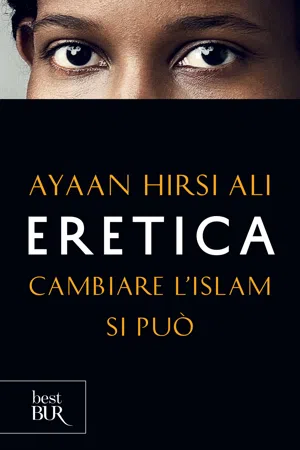![]()
1
La storia di un’eretica
Il mio viaggio lontano dall’Islam
Sono stata una musulmana praticante fin dall’infanzia, e per quasi tutta la vita. Ho frequentato la madrasa e imparato a memoria gran parte del Corano. Da bambina ho vissuto per un certo periodo alla Mecca e visitato spesso Al-Masjid al-Haram, la moschea sacra; da ragazza sono entrata nella Fratellanza Musulmana: insomma, ho vissuto abbastanza da assistere alla biforcazione dell’Islam, nella seconda metà del Ventesimo secolo, tra la fede quotidiana dei miei genitori e il jihadismo intollerante, militante, predicato dalle persone che oggi definisco musulmani di Medina. Permettetemi di cominciare dall’Islam con cui sono cresciuta.
Avevo circa tre anni quando, all’ombra di un frondoso talal, in Somalia, mia nonna iniziò a insegnarmi quel poco che aveva memorizzato del Corano. Non sapeva leggere né scrivere – nel Paese l’alfabetizzazione è stata promossa solo dal 1969, l’anno in cui sono nata – e non aveva la minima infarinatura di arabo, ma letteralmente venerava quel libro, che prendeva con estrema deferenza, baciandolo e accostandolo alla fronte, per poi riporlo con delicatezza al suo posto. Noi non potevamo toccarlo, se non con le mani appena lavate. Mia madre era come la nonna, con la sola differenza che conosceva a memoria un po’ di più e masticava qualche parola di arabo. Aveva imparato le preghiere e talvolta recitava formule spaventose, ammonendomi che sarei bruciata all’Inferno per questa o quella mancanza.
Lei era nata sotto un albero, cresciuta nel deserto, e in gioventù aveva viaggiato da sola, riuscendo ad arrivare fino a Aden, nello Yemen, dall’altra parte del Mar Rosso. Era stata costretta a un matrimonio combinato, e spedita in Kuwait con il marito, dal quale aveva divorziato non appena suo padre era morto. Più tardi, tramite la sorella maggiore, aveva conosciuto il mio, nel periodo in cui lui teneva corsi di alfabetizzazione nella capitale somala, insegnando a leggere e a scrivere alla gente comune. Lei era stata una dei suoi migliori studenti, svelta di lingua e di mente; lui aveva già una moglie e mamma era diventata la seconda. Papà era anche un uomo politico, un leader dell’opposizione che tentava di cambiare la Somalia, allora governata dal dittatore Siad Barre. Quando avevo due anni, le autorità vennero a prenderlo e lo portarono alla vecchia prigione italiana, che tutti chiamavano «il buco». Per gran parte della prima infanzia, dunque, il mio mondo fu composto solo da mia madre, mio fratello, mia sorella, mia nonna e me.
La mia prima vera scuola fu un dugsi religioso, costituito da una semplice tettoia, che offriva riparo dal sole cocente. Trenta o quaranta bambini sedevano sotto quel tetto di fortuna, tenuto su da quattro pali e circondato da un boschetto. Occupavamo l’unica zona d’ombra. Sul davanti e nel mezzo dello spazio disponibile c’era un tavolino di legno alto una trentina di centimetri, su cui poggiava una copia del Corano. Il maestro indossava un sarong e una camicia, la tenuta tradizionale dell’uomo somalo, e ci faceva ripetere cantilenando i versetti, un po’ come quando i bambini europei e americani, all’asilo, imparano poesiole e filastrocche. Se non ricordavamo qualcosa o non declamavamo a voce abbastanza alta, o se le nostre voci calavano troppo, prendeva una bacchetta e ci dava dei colpetti o ci pungolava.
Cantilenavamo anche le volte in cui uno scolaro si comportava male. Se disubbidivi o non riuscivi a imparare le parti assegnate, venivi spedito al centro della tettoia. I peggiori venivano issati su un’amaca e fatti dondolare per aria. Tutti gli altri ricevevano dei legnetti, li alzavano sopra la testa, piazzati sotto l’amaca, colpendo il disobbediente attraverso i buchi del tessuto, declamando versetti coranici ed evocando il Giorno del Giudizio, in cui il sole diventerà nero e divamperà il fuoco dell’Inferno.
Ogni punizione, a casa come a scuola, sembrava accompagnarsi a minacce di fiamme eterne e invocazioni di morte e distruzione: «Che ti venga questo o quel malanno», «Che tu possa bruciare all’Inferno»… Ma la sera, quando il sole era calato all’orizzonte e l’aria fresca della notte ci avvolgeva, mia madre si rivolgeva alla Mecca e intonava la preghiera serale. Recitava più e più volte, tre, forse quattro, l’inizio del Corano e altri versetti, cominciando in posizione eretta, con le mani sul grembo, per poi chinarsi, prostrarsi, sedersi, prostrarsi e risedersi ancora. C’era tutto un rituale di parole e gesti che si ripeteva ogni giorno a quell’ora.
Dopo le preghiere sedevamo con le mani a coppa sotto il talal, implorando Allah di liberare papà dalla prigione. Erano suppliche volte ad alleviarci un po’ la vita, chiedevamo ad Allah di essere paziente con noi, di darci la forza di sopportare, di riversare su di noi misericordia e pace. «Cerco rifugio in Allah» cantilenava mia madre. «Allah, il più misericordioso, il più compassionevole… Mio Signore, perdonami, abbi pietà di me, guidami, dammi la salute e assicurami il sostentamento, esaltami, benedici i miei affari.» Quelle parole erano diventate familiari e confortanti come una ninna nanna: la cosa più lontana che potessi concepire dal frastuono dei bastoni e dalle spietate prese in giro dei ragazzini del dugsi.
La supplica sembrò funzionare: con l’aiuto di un parente, mio padre riuscì a scappare di prigione e a riparare in Etiopia. La cosa più ovvia sarebbe stata che mia madre portasse in Etiopia anche noi, ma lei non ne voleva sapere. Perché era un Paese a maggioranza cristiana: ai suoi occhi, nient’altro che un mare d’infedeli in un territorio impuro. Preferì trasferirsi armi e bagagli in Arabia Saudita, la culla dell’Islam, sede dei suoi luoghi santi, la Mecca e Medina. Ottenne un passaporto falso e biglietti aerei per tutti noi; una mattina – io avevo otto anni – la nonna ci svegliò prima dell’alba, ci infilò i vestiti buoni e, prima che il sole tramontasse, eravamo in terra saudita.
Ci stabilimmo alla Mecca, il cuore spirituale della nostra religione, il luogo in cui ogni musulmano sogna di recarsi almeno una volta nella vita. Noi potevamo farlo tutte le settimane, prendendo il bus sotto casa fino alla moschea sacra. A otto anni avevo già fatto la ‘umra, la versione ridotta del pellegrinaggio completo alla Mecca, lo ḥajj, il quinto pilastro della fede musulmana, che monda i peccati del fedele. Lì, inoltre, potevamo studiare religione nelle scuole saudite, anziché in una baracca somala. Io e mia sorella Haweya fummo iscritte alla scuola coranica per ragazze, mio fratello Mahad alla madrasa per maschi. Mi era stato insegnato che tutti i musulmani sono uniti in una fratellanza, ma a quel tempo scoprii che questa non escludeva il pregiudizio razziale e culturale. Quel che avevamo appreso del Corano in Somalia non era sufficiente per i sauditi. Non ne sapevamo abbastanza, farfugliavamo invece di recitare. Non imparammo a scrivere alcun passaggio, ci limitammo a memorizzare i versetti, ripetendoli lentamente più e più volte. Le ragazze avevano la pelle chiara e ci chiamavano abid, schiave. Di fatto, i sauditi avevano abolito la schiavitù solo cinque anni prima della mia nascita. A casa, mia madre ci faceva ormai pregare cinque volte al giorno, eseguendo ogni volta le abluzioni e indossando le vesti rituali.
Fu lì che conobbi per la prima volta la rigorosa applicazione della sharī‘a. Ogni venerdì, sulla pubblica piazza, dopo le preghiere, si decapitavano o si fustigavano uomini, si lapidavano donne, si mozzavano mani ai ladri, tra zampilli di sangue. Il ritmo delle preghiere cantilenate lasciava il posto al suono metallico della lama che fendeva la carne o al cozzo delle pietre. Non mettemmo mai in discussione la ferocia di quelle punizioni. Per noi era solo e ancora il fuoco dell’Inferno.
Al-Masjid al-Haram, però, con le sue colonne svettanti, le sue piastrelle dai decori elaborati, i suoi pavimenti lucidi era un luogo affascinante. Lì, nella fresca penombra, mia madre poteva camminare sette volte intorno alla Ka‘ba, la costruzione che sorge nel mezzo. Quella tranquillità veniva interrotta soltanto nel mese dello ḥajj, riservato ai pellegrinaggi, quando non potevamo lasciare l’appartamento per paura di essere travolti dal fiume di fedeli che inondava le strade, e anche la più semplice conversazione andava urlata sopra il vocio continuo delle preghiere.
Fu alla Mecca che, per la prima volta, mi accorsi della differenza tra la visione dell’Islam di mio padre e quella di mia madre. Dopo che anche lui ci ebbe raggiunto dall’Etiopia, volle che pregassimo tutti insieme, come una famiglia, non separati, maschi e femmine in camere diverse. Non ci agitava di continuo in faccia lo spauracchio dell’Inferno e, una volta la settimana, ci spiegava il Corano, leggendo brani e tentando di tradurceli, infondendo ai versetti la sua interpretazione. Diceva che Dio non ci ha messo in questo mondo per punirci: ci ha posti sulla Terra per glorificarlo. Io alzavo lo sguardo annuendo, ma il giorno dopo, se disubbidivo a mia madre, lei evocava di nuovo lo spettro del fuoco e dell’eterna dannazione.
In seguito ci trasferimmo a Riyad, dove mio padre lavorava come traduttore in codice morse per un ministero governativo. Avevamo una casa con una zona per le donne e una per gli uomini, anche se, a differenza dei nostri vicini, passavamo tutti con disinvoltura dall’una all’altra. Papà non si comportava come i maschi sauditi: non faceva la spesa, né gestiva tutte le transazioni che avvenivano all’esterno delle pareti domestiche. Continuò, inoltre, ad assentarsi per tornare in Etiopia, dove l’opposizione somala aveva il suo quartier generale, e le nostre vicine compativano mia madre, costretta a uscire di casa da sola. Lei, dal canto suo, disprezzava le loro figlie, che avevano insegnato a me e a Haweya i rudimenti della danza del ventre. Voleva che vivessimo secondo il «puro Islam», che per lei significava niente balli e canti, niente risate né gioia.
Poco più di un anno dopo, quando ne avevo nove, ce ne andammo con la stessa rapidità con cui eravamo venuti. Mio padre era stato espulso dal governo saudita. I motivi non erano molto chiari per me, ma di certo avevano a che fare con la sua attività politica di opposizione. Avevamo ventiquattro ore per fare le valige e scappare: in Etiopia, questa volta. Ma, dopo circa diciotto mesi laggiù, l’avversione di mia madre per quel Paese impose un altro trasloco: in Kenya.
A Nairobi, io e Haweya cominciammo la scuola, e l’inglese non fu la sola cosa che vi imparammo. Scoprii ben presto che non conoscevo le cose più elementari, come la data e l’ora. L’Etiopia aveva un calendario astrale, l’Arabia Saudita usava quello lunare islamico; in Somalia mia nonna aveva sempre indicato il momento della giornata solo guardando il sole e il suo calendario constava di dieci mesi. Soltanto in Kenya, all’età di dieci anni, seppi che era il 1980. Per i sauditi era l’anno islamico 1400; per gli etiopi, con il loro sistema di calcolo, il 1978.
In tutto ciò, mia madre restava saldamente aggrappata alla sua fede: rifiutava di credere che quanto imparavamo a scuola – gli atterraggi sulla luna, le teorie evolutive… – fosse vero. I kenioti sì, forse, discendevano dalle scimmie, ma noi no e, a dimostrazione, ci faceva recitare a memoria la nostra genealogia familiare. Non appena compii quattordici anni, mi iscrisse alla Muslim Girls’ Secondary School di Park Road, dove io e mia sorella avremmo almeno avuto una divisa più dimessa: potevamo indossare pantaloni sotto la gonna per nascondere le gambe e coprirci la testa con un foulard bianco. O meglio, quella tenuta era ammessa, ma ben poche ragazze, all’epoca, la utilizzavano.
Come ho abbracciato l’Islam di Medina
A sedici anni, scoprii un modo migliore di essere musulmani. A scuola, arrivò infatti una nuova insegnante di educazione religiosa, Sorella Aziza. Era una sunnita originaria della zona costiera, convertitasi all’Islam sciita dopo il matrimonio. Portava lo ḥijāb e indossava persino guanti e calze per tenere nascoste le dita di mani e piedi. Quasi nulla era visibile di lei, se non il volto.
Fino a quel momento l’Islam ci era stato impartito come una materia storica, una sequenza di califfati e date. Aziza non insegnava: predicava. O meglio, sembrava ragionare con noi, ponendoci domande, guidandoci. «Che cosa vi rende diverse dagli infedeli?» La risposta corretta era: la shahāda, la professione di fede del musulmano. «Quante volte al giorno dobbiamo pregare?» E sapevamo che la risposta era: cinque. «Ieri quante volte avete pregato?» Ci guardavamo l’un l’altra, nervose.
Era un metodo assai più affascinante delle bacchettate, e a Sorella Aziza poco importava di quanto tempo impiegassimo a introiettare l’insegnamento. Come soleva dire, riferendosi al suo modo di vestire: «Allah e il Profeta vi vorrebbero vestite così, ma dovrete farlo solo quanto vi sentirete pronte». Poi aggiungeva: «Quando sarete pronte, lo sceglierete e non lo toglierete più».
Altra novità: Aziza non leggeva il Corano in arabo, ma nella traduzione inglese, e, a differenza di tutti i miei insegnanti precedenti – compresa mia madre –, diceva di non volerci forzare. Stava semplicemente condividendo con noi la Parola di Allah, i Suoi auspici, i Suoi desideri. Certo, se avessimo deciso di non compiacere Allah, saremmo bruciate all’Inferno, ma per chi lo compiaceva c’era il Paradiso.
L’elemento del libero arbitrio contenuto nelle sue parole era irresistibile. I nostri genitori – di sicuro mia madre – non potevano mai dirsi abbastanza soddisfatti, qualunque cosa facessero. La vita terrena non si poteva cambiare: nel giro di pochi anni, o forse meno, saremmo state prelevate dalla scuola per essere destinate a un matrimonio combinato. Non pareva proprio che esistesse alternativa. Ma la nostra vita spirituale era un’altra cosa: quella poteva essere plasmata e Sorella Aziza ci avrebbe indicato la via. Noi potevamo, a nostra volta, mostrarla ad altri: difficile ingigantire il senso di potere che ci derivava da quel messaggio.
Ci volle un po’, ma quando abbracciai il cammino di Sorella Aziza, lo feci con convinzione. Pregavo cinque volte al giorno. Andai da un sarto e comprai un’ampia cappa che si stringeva ai polsi e si allargava ai piedi. La portavo sopra la divisa scolastica e mi avvolgevo testa e spalle in un velo nero che indossavo la mattina, durante il tragitto per arrivare a scuola, e rimettevo ai cancelli dell’istituto prima di rientrare. Camminando per strada, dovevo muovermi con cautela, perché era facile inciampare nella stoffa rigonfia, che era voluminosa e soffocante. In quei momenti, mentre la mia gigantesca figura incedeva lenta, mia madre era finalmente felice per me. Ma non lo stavo facendo per lei. Lo facevo per Allah.
Sorella Aziza non fu l’unico esempio di un Islam «diverso» che conobbi all’epoca. C’erano nuovi predicatori che andavano porta a porta, come l’autonominato imam Boqol Sawm. Il suo nome significava «Colui che digiuna cento giorni», e il suo aspetto fisico lo rispecchiava in pieno. Era così magro che la sua pelle pareva adagiata direttamente sullo scheletro. Se Sorella Aziza portava lo ḥijāb, Boqol Sawm aveva una veste di tipo saudita, appena un po’ più corta, in modo da lasciar intravedere le caviglie ossute. Non sembrava far altro che camminare su e giù per Old Racecourse Road, il nostro quartiere a Nairobi, bussando alle porte, catechizzando le donne che gli aprivano e lasciando loro registrazioni su cassetta. Niente rappresentanti della Electrolux in Old Racecourse Road: solo Boqol Sawm con i suoi sermoni! A volte entrava in casa, purché ci fosse una tenda a separarlo dalle donne. Loro ascoltavano le cassette che lasciava e se le scambiavano, tenendo in sottofondo i sermoni mentre lavavano e cucinavano. Pian piano, smettevano gli abiti colorati e si avvolgevano nello jilbāb, una lunga tunica ampia, coprendosi la testa e il collo.
Se i metodi d’indottrinamento di Aziza erano sottili, Boqol Sawm prediligeva l’aggressività verbale che avevo già conosciuto in Somalia. Urlava versetti in arabo e in somalo, sottolineando cosa fosse proibito e cosa no, in modo così sgradevole che si era fatto cacciare dalla moschea locale. Le donne, affermava, dovevano essere disponibili per i mariti in qualunque momento: «Anche in sella a un cammello», salvo nei giorni del mese in cui erano impure. Non pareva un messaggio particolarmente attraente per un pubblico femminile, eppure molte erano ammaliate da quell’uomo. E per i loro figli fu un vero e proprio strumento di trasformazione.
Sempre più adolescenti somali, nella nostra comunità di espatriati, avevano cominciato a bazzicare le strade in bande, marinando la scuola, masticando qāt, commettendo piccoli reati, molestando o persino violentando le donne, sfuggendo completamente al controllo delle madri. Boqol Sawm, invece, ci invitava a unirci alla Fratellanza Musulmana. All’inizio era difficile capire come un solitario predicatore itinerante potesse rappresentare una fratellanza, ma, non molto tempo dopo, altri si unirono a lui nelle strade. Allora, con sorprendente rapidità, ecco sorgere una nuova moschea e Boqol Sawm installato come imam. Era passato dalla predicazione porta a porta alla leadership locale di un movimento.
I Fratelli Musulmani sembravano una sorta di «Islam in azione»: prendevano i ragazzi scapestrati dalla strada, li piazzavano nella madrasa, insegnavano loro a pregare cinque volte al giorno, cambiavano il loro modo di vestire. Cambiavano quasi tutto di loro, in effetti. Io constatai quella trasformazione nel figlio di un nostro parente. A ripensarci ora, mi rendo conto che molti abbracciarono la ...