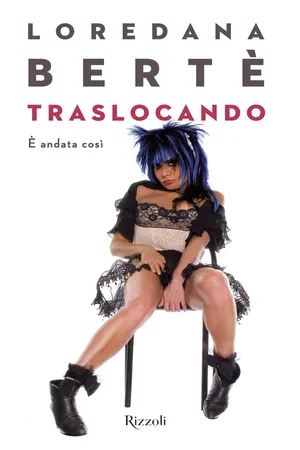![]()
L’arte della fuga
La Calabria era piena di parenti, di nonne e di zie con nomi strani. Durante le vacanze estive, quando tornavamo dalle Marche per ritrovare le radici che non avevamo, ne vedevo soprattutto due. Una, vagamente strabica e completamente pazza, si chiamava Melina e l’altra Sarina, che era la sorella della madre. Poi c’era mia nonna Maria Domenica, detta nonna Menica. Aveva messo al mondo quattordici figli e alla selezione naturale ne erano sopravvissuti solo quattro. Era una donna di un altro secolo. Era veramente brutta. Con il velo e la gonna nera. Si metteva sempre fuori dalla porta della catapecchia in cui abitava a Bagnara, appoggiata a una sediolina, a pettinarsi i lunghi capelli per ore.
Alla noia profonda di quelle visite reagivo a modo mio. Come un Pinocchio, costretto a mentire e a rompere le regole con l’esagerazione. Una volta, con una scatola di fiammiferi in mano, provai a dar fuoco alla casa padronale e mi misero in castigo. Avevo acceso un cerino dopo l’altro, esaltandomi all’arrivo delle fiamme. Il padre e la madre, costretti a chiedere momentanea ospitalità alla nonna, erano incazzati neri. Così, quando lei propose di portarmi in Sicilia per aiutarla a vendere le uova, non solo non si opposero, ma ne furono felici.
La Sicilia era la terra più grande che avessi visto in vita mia. Enorme. Antica. Trasandata. Nei nostri occhi di bambini, ci era sembrata grande anche Porto Recanati. Con i cavalloni altissimi che vedevamo abbattersi sulle coste dalla casa di via Giacomo Leopardi. Con la sabbia portata dal vento che raggiungeva i giardini di piazza Carradori. Con le reti della Marina militare da scavalcare e la sorella maggiore da medicare perché, nella foga di superare il recinto, aveva trascurato il filo spinato. Ma, nel mio sguardo, la Sicilia era l’America. Una terra di confine. Un sacrario più inviolato dei porti marchigiani. Con le coste frastagliate, le montagne, le nuvole, i colori più accecanti che avessi mai visto.
Io e mia nonna la raggiungemmo a fatica. Incamminandoci nel nulla. Viaggiando a piedi lungo la costa. Alzando la polvere. Chiedendo passaggi ai pochissimi mezzi incontrati per la strada. Tra Bagnara e Reggio c’erano soltanto trenta chilometri. Li percorremmo in un tempo dilatato, senza dirci una parola, facendo brevi pause per bere e per difenderci dal sole. Nelle giornate terse, lo Stretto di Messina univa i lembi della terra. Ci avvicinavamo, ma non potevamo ancora toccare l’altra sponda. L’ultimo tratto lo facemmo nel fieno, caricate da un agricoltore che sul cruscotto teneva la foto della madre, la croce di Gesù e non so quale altro monito. Al porto trovammo il caos che dev’esserci davanti alla porta dell’inferno. C’erano voci, suoni e volti non tutti raccomandabili. Io e mia nonna sembravamo invisibili. Sulla passerella lei si fece aiutare da un ragazzo e con passi lenti – la veste nera diventata ormai marrone a causa della terra e della paglia – raggiunse una panca di acciaio. Salimmo avventurosamente a bordo e tornammo indietro dopo un solo giorno, così come eravamo venute.
I siciliani non appartenevano a nessuno e, per capirlo, non c’era posto migliore di un mercato. I dialetti, le voci, i lineamenti. I popoli che si erano confusi e grazie a dio avevano imbastardito le razze. Non c’era stirpe, imbarcazione o promessa di sventura che non avesse soffiato sull’isola e, a forza di soffiare, non si fosse illusa di averla conquistata. Invece era sempre accaduto esattamente il contrario. Gli invasori erano arrivati, avevano lasciato le loro eredità e poi erano stati spinti altrove, mentre gli indigeni, con i lasciti degli arabi o degli spagnoli, avevano steso il loro negozio di profumi. Incensi, sigarette, pesce spada, panelle e baratti. Io non potevo saperlo, ma mia nonna giocava allo stesso tavolo di quella gente. Si era fatta capire. Conosceva le regole. Aveva concluso il suo affare e ora tornava indietro con il denaro stretto nella saccoccia.
L’Italia della mia infanzia era soprattutto contadina. Erano gli anni Cinquanta: il frigorifero era un lusso, la carne si metteva nel pozzo e la televisione si guardava al bar del paese. Mia nonna aveva un sacco di galline e sapeva come difendersi da zio Rodolfo, un poco di buono che entrava e usciva di galera e le fregava sempre i soldi. Sotto la gonna aveva cucito delle tasche interne. Piangeva miseria, ma a sera, quando si spogliava, dal nascondiglio uscivano i risparmi, rotoli di denaro che rivelavano ricchezze insospettate. Guadagnava, ma non spendeva niente. Risparmiava su tutto. Non dava niente a nessuno. Viveva tra il pollaio e l’uscio di una stamberga, circondata dal grano e dai bagnaroti. Gente che faceva finta di nulla e all’occorrenza, discreta, abbassava il capo in segno di rispetto. Era una società essenzialmente matriarcale. Il peso del commercio, più o meno metaforico, gravava sulle donne. Quelle di Bagnara erano leggendarie. Le vedevi inerpicarsi sulle alture con le ceste in testa, piene di mozzarelle giganti e pomodori, così dritte da sembrare modelle in una sfilata a tema campagnolo, o salire sui treni dirette a Sant’Eufemia d’Aspromonte, a Cosoleto o a Delianuova e tornare la sera con le tasche piene, un pesce sulle spalle e il volto soddisfatto di chi aveva saputo commerciare. C’era anche il proverbio: «Vino di Scilla, zafferano di Cosenza e donne di Bagnara». E il cibo, in un’epoca in cui non sembrava esistere niente di più importante, era una loro prerogativa.
Tutti gli anni, finita l’estate, con le valigie da emigranti stipate di salami e con l’odore di ’nduja che riempiva lo scompartimento, tornavamo nelle Marche. Erano tempi di bisogni primari, paure ereditate dalla guerra e calvari spaventosi per fare poche centinaia di chilometri. Ogni tanto i parenti ci venivano a trovare. Arrivavano trasfigurati a bordo di mezzi di fortuna. Sudati. Stravolti. L’aria eroica dei pionieri. Un giorno sentimmo suonare un concerto di pentole di fronte alla casa di Porto Recanati. Ci affacciammo e vedemmo zia Melina e suo marito a cavallo di una Vespa circondata dai tegami. Se li erano portati dalla Calabria: «Così cuciniamo come dio comanda» ci disse la zia, mentre scioglieva i nodi e scaricava sul marciapiedi i pacchi, le padelle e i barattoli di conserva, come se fosse il gesto più normale del mondo. Mai un regalo vero comunque. Mai una bambola, un pupazzo, una palla di pezza. Neanche per sbaglio. Eravamo quelli che eravamo e a casa nostra sembrava di essere in quella famosa scena di Miseria e nobiltà quando Enzo Turco, il fotografo ambulante, si lamenta ad alta voce: «Qui non si vive più, in questa casa si mangia pane e veleno», Totò lo corregge subito: «Pasqua’, te l’ho detto tante volte: qui si mangia solo veleno». Succedeva anche da noi e allora, in mancanza di meglio, trasformavamo quegli arrivi in una festa e giocavamo con le marmellate, correndo in cucina a scartare, a friggere, a tagliare.
Si mangiava tutti insieme, nella sala grande all’ombra dell’orologio, con il centrino sul pianoforte e la voce pesante del padre a battere sui soliti tasti. L’epopea dell’emigrazione, del Sud che caccia «i suoi figli migliori» e dei sacrifici necessari a integrarsi. Erano tutte cazzate. Violenza a parte, a lui interessava solo comandare. Agitare il bastone. Sottomettere. Il padre era un ottimo picchiatore e un pessimo retore.
In anni di fideismi, di crociate e di chiese contrapposte, si era iscritto al Partito comunista ed era stato scomunicato. Il padre era zelante, maniacale, ossessivo. Finito l’orario scolastico, teneva comizietti per pochi intimi nella provincia marchigiana. Lui, il suo sgabello, la piazza semivuota, gli strilloni con «l’Unità» in mano, gli stendardi con falce e martello e una di noi, a turno, mollata su una panchina in attesa che il padre finisse di onorare il compagno Togliatti. Una volta, in preda all’enfasi oratoria, dopo aver parlato di collettivizzazione e salario garantito, si infilò in macchina e partì, dimenticando Mimì su una panchina a decine di chilometri da casa. Con le urla della moglie ancora nell’orecchio, tornò a prenderla che si era fatto buio. Il profilo dolce dei colli marchigiani era stato inghiottito dalle ombre della notte, ma Mimì non piangeva. Dopo sei ore era ancora lì seduta ad aspettarlo, persa nei suoi pensieri.
A fine mese, regolarmente, mio padre riceveva la visita di Pietro Nenni. Che uomo. Dell’Italia del dopoguerra e anche di quella che nella guerra cadde per responsabilità di Mussolini, Nenni aveva fatto la storia. Da antifascista era stato in esilio a preparare la riscossa del proprio Paese. Poi era rientrato in patria e si era messo al servizio di un’idea collettiva. Sarebbe stato uno splendido presidente della Repubblica, disse Oriana Fallaci, e nel nostro ordinamento casalingo, almeno, aveva tutti gli onori che spettano di diritto al capo di Stato. L’ultimo politico occidentale che – come non dimenticava mai di dire il padre – avesse incontrato Stalin ancora vivo. Per il padre averlo tra le mura di casa equivaleva a essere nei pressi di dio. Vicino al socialismo e ai suoi dirigenti, al centro di un sentimento che – pensava – si sarebbe presto trasformato in potere, guida della nazione e vantaggio personale. Bisognava essere pronti. E offrire a Nenni la migliore ospitalità possibile. In quanto a servilismo e a opportunismo i Bertè non erano secondi a nessuno, ma almeno l’occasione giustificava lo zelo. La madre tirava fuori la coperta di ciniglia rossa, preparava la stanza con cura e stendeva i centrini fatti a mano sulla poltrona. Il vecchio Pietro apprezzava. Era magnifico. Arrivava portando in dote vino e cioccolatini. Si insediava sul trono. Aveva gli occhi azzurri. Occhi che sembravano fari. Iniziava a parlare con il padre di massimi sistemi, socialismo e Unione Sovietica e poi, passata qualche ora, andava a dormire. Un sonno pomeridiano, leggero, rapido. Uno di quei sonni brevi e clandestini imparati ai tempi in cui l’arresto era un’eventualità quotidiana. Al risveglio lo trovavo riposato e gli portavo il caffè. Mi invitava a sedergli sulle ginocchia e io non me lo facevo dire due volte. Gli unici gesti dolci ricevuti in quella casa furono i suoi. Mimì impazziva per Bandiera rossa, è stato il suo primo cavallo di battaglia, e quando veniva Nenni, per accoglierlo a dovere, la intonava con partecipazione dalla cima delle scale: «Vedi, Pietro» gli diceva il padre mieloso, «non è già una brava compagna coscienziosa, la mia piccola Domenica?».
Nenni era una parentesi di serenità familiare. Un’oasi momentanea per ripararsi dalle urla. Un palco per inscenare un’inesistente normalità. Appena se ne andava, ricominciava lo schifo di prima. «Zitta, scema» ordinava il padre a Mimì, che a pantomima conclusa continuava a cantare Bandiera rossa con troppa convinzione: «T’ho detto di stare zitta e di piantarla, altrimenti finisce che i vicini ci denunciano». Poi gliele dava e bestemmiava, perché picchiare, punire e bestemmiare senza ragione erano tra i suoi massimi piaceri. Quando Nenni era a poche ore dalla partenza, iniziavo a sognare a occhi aperti. Speravo che accadesse un miracolo e quell’uomo rimanesse lì per sempre. Volevo che sostituisse il padre. Al risveglio, messa a fuoco la realtà, Pietro non c’era più e al suo posto era rimasto Giuseppe, che non era un eroe generoso, ma solo un tirchio del cazzo. Per risparmiare spegneva ossessivamente tutte le luci della casa. Quando scopriva un chiarore non previsto, ci inseguiva con i suoi rimproveri e con il bastone. Si viveva nell’oscurità e l’oscurità era il suo regno.
Alla madre invece, l’avremmo capito con il tempo, le luci piacevano parecchio. Ma era un’avara del cazzo e una grande egoista pure lei. Per non spendere in acqua e non avere sorprese in bolletta – «La pago, lo sapete?» – la madre ci faceva il bagno solo una volta alla settimana. Nella vasca. La domenica mattina. Giorno di festa e di ipocrisie santificate. Gli altri giorni ci lavava a pezzi. Un piede, un’ascella, un bidet, se proprio era il caso. Gli abiti, mutande comprese, erano gli stessi dal lunedì al sabato. Fino alla quinta elementare siamo andate a scuola vestite come piccole disgraziate. La cosa faceva imbestialire me e Mimì, che a un certo punto ci ribellammo e iniziammo lo sciopero dell’igiene: «Dobbiamo lavarci solo la domenica? Allora non ci laviamo proprio». Urla, minacce, interventi del padre. Resistemmo e così, credo soprattutto per la vergogna sociale, la madre capì che avrebbe dovuto far installare una doccia e cambiarci più spesso. Fatti due conti, divenne ancora più stretta di tasca.
Insieme ai regali negati, alla mancanza d’affetto e alle feste di Natale ignorate, questi due stronzi lesinavano quindi anche sulla pulizia. L’ennesima stella mancante di una storia sporca. Nessuno che ci augurasse buon compleanno o ci desse un cioccolatino. La mia infanzia mi sembrava così lugubre, così triste, così deprimente e così amara che non appena si poteva scappavamo via. Sia a Porto Recanati sia ad Ancona c’era il luna park. Io e Mimì ci andavamo spessissimo. Il luna park era la nostra coperta di Linus. La nostra pallida botta di culo a parziale riparazione della sfortuna di essere nate in quella famiglia. Così al luna park trascorrevamo intere giornate. A forza di vederci sempre lì, il proprietario offrì a Mimì di mettere i dischi e improvvisarsi deejay dei giostrai. Ma i nostri giostrai dell’infelicità, il padre e la madre, il biglietto di ingresso nella vita ce lo hanno fatto pagare molto caro.
Per questo sono una persona che ha capito in fretta cosa significhi sfiducia. Per questo sono un’insicura. Una donna che ancora oggi sale sul palco aggredita dal panico e ogni santa volta si chiede: «Ma chi cazzo me l’ha fatto fare di affrontare un mestiere così?». Per dubbi e paure devo ringraziare soltanto due persone: quella senzapalle della madre e quel delinquente del padre. Un professorino che del suo ruolo di maestro del sopruso aveva fatto un’arte.
Molti anni dopo, quando con quel ceffo del padre non parlavo più da decenni, mi fermò per strada Ferdinando Scarfiotti, lo scenografo premio Oscar per L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci. Era Natale, cadeva qualche fiocco di neve e la gente con i pacchi e le signore intabarrate nelle sciarpe, un piede sul marciapiedi e l’altro sulla strada nel tentativo di fermare un taxi, ci passavano accanto indifferenti e frenetiche. Scarfiotti se ne stava lì felice, insensibile alle folate polari di New York, a raccontarmi i particolari della sua infanzia. Era di Potenza Picena, a pochi chilometri da Porto Recanati, mi aveva detto come per riannodare un filo, un legame, una lontana parentela geografica. «Non ti ricordi di me? Venivo ogni pomeriggio a casa tua per prendere lezioni di greco da tuo padre. A ripetere a memoria le declinazioni c’era con me anche il giovane Farfisa, l’erede dell’impero delle fisarmoniche. Tuo padre era severissimo. Certe bacchettate mi dava, ho ancora i segni sulle mani.» Lui sorrideva. Io tremavo. E non dubitavo. Tra le nostre quattro mura del cazzo, il terrore era la regola e saper leggere e scrivere era una maniera per allontanare l’ira del padre. A quattro anni sapevo già leggere e scrivere benissimo, talmente bene che saltai la prima elementare e mi ritrovai direttamente in seconda. A scegliere di farmi avanzare di una classe, come a decidere fino ad allora tutto il resto, era stato il padre. Mi aveva rapinato di ogni gioia infantile esattamente come ai suoi tempi – da figlio rimasto orfano a dieci anni, abusato in collegio dai gesuiti, picchiato e messo al muro – era capitato anche a lui.
Non lo giustificavo. Non lo capivo. Lo detestavo. Mi sentivo estranea. Volevo essere altrove. A cinque anni, lavando i piatti in piedi su uno sgabello per arrivare all’altezza del lavello, mi ferii volontariamente al polso. Buttavo sangue come una fontana, ma il padre e la madre, continuando a odiarsi senza pause, non se ne accorsero. A salvarmi e a medicarmi fu Mimì. Uscimmo di casa di nascosto. Pioveva. Mimì mi abbracciò, mi coprì, fermò la ferita e mi portò alla guardia medica. Con i dottori inventammo una storiella. Eravamo sole, io mi ero ferita con il coccio di vetro di un bicchiere e per evitare guai peggiori, con grande senso di responsabilità, Mimì si era comportata come la migliore delle sorelle possibili. Ci guardammo negli occhi. Ce l’avevamo fatta. Eravamo state una cosa sola. Quelli, gli infermieri, restarono ammirati, si complimentarono, mi curarono e io e lei tornammo a casa di soppiatto.
A volte dicevamo: «Andiamo al parco» e ci perdevamo per ore a pedalare nelle stradine di Porto Recanati. Mimì aveva una biciclettina. Mi metteva in piedi dietro il sellino e andavamo in giro per giardini, con la speranza di non dover tornare a casa troppo presto. A otto anni Mimì sembrava Pocahontas, i capelli lunghi, neri, bellissimi, fino alla vita. Passavamo nei parchi e i ragazzini le tiravano addosso bigliettini d’amore: «Sei fantastica», «Sei la più bella stella della città». Io ero uno scricciolo, ma di Mimì ero gelosissima. Quando mi trascurava e deviava dal percorso concordato per raccogliere baci innocenti e messaggi ingenui dai suoi primissimi spasimanti, mi incazzavo e facevo la pazza. Prendevo a calci negli stinchi i ragazzini, lanciavo sassi e pezzi di frutta, li insultavo fino a farli scappare. E lei, delusa: «Che palle che sei, Loredana, ma che ti prende? Non potresti essere più civile?». Tra una fantasia e un sogno di fuga, la nostra solitudine era fottutamente reale.
Osservavamo le altre famiglie che passeggiavano tranquillamente e pensavamo a voce alta: «Non sarebbe bello essere orfane? Se fossimo senza genitori forse potremmo finalmente sceglierci le persone giuste». Il senso di abbandono mi ha accompagnato per anni. Anche se il padre aveva cambiato dimora e si era ritirato nell’Italia del Nord, con il malessere e con la sua eredità del cazzo continuavo a fare i conti. Uscire di casa mi faceva bene. Ad Ancona mi fermavo spesso nella zona del porto. C’erano le navi ancorate, il mare sullo sfondo e i massi a pochi metri dal bagnasciuga per frenare l’irruenza delle onde. Passavo le ore a osservare l’Adriatico. Mi rasserenava. I temporali all’orizzonte, i fulmini, i cacciatori di tonni che in certe giornate senza luce partivano per la Jugoslavia e tornavano trionfanti con un carico più grande della loro stessa barca. Li guardavo e imparavo che anche nella tempesta perfetta è tutta una questione di misura. Dalla tempesta eravamo state travolte. La misura non l’avevamo mai conosciuta.
Dopo la nascita di Olivia, la madre trovò la via per dimenticare il tifone casalingo, andando incontro ad altri uragani. Si era ritrovata a trent’anni con quattro figlie. Era rimasta per troppo tempo in un matrimonio infelice e senza vento, con troppi se e pochi ma. All’epoca non c’erano i telefoni azzurri o le associazioni contro le violenze domestiche e il femminicidio. Quello la gonfiava ogni cazzo di giorno e lei aveva pensato di liberarsi dal suo carceriere tentando il suicidio, poco dopo aver dato alla luce la sua quarta figlia. Si era salvata, ma si salvò davvero soltanto quando rase definitivamente al suolo il rapporto con il marito. La madre si liberò, si scatenò e ristabilì in fretta le priorità.
Era una statua bruna. Una donna bellissima con i capelli sempre in ordine, i tacchi e le gonne strette con lo spacco. Una strafiga. I professori della sua scuola con me erano molto gentili e io non capivo il perché. Finché un giorno intuii che usare le buone maniere con la figlia, per un maschio dell’epoca, rappresentava la più facile delle scorciatoie per scoparsi la madre. Lei comunque non si faceva pregare. Quando usciva a tarda sera, potevi esser sicura che sarebbe rientrata la mattina dopo. Non si lasciava scappare un cazzo che fosse uno. Gli uomini erano prede che abbrancava senza reale desiderio, conquiste effimere, momenti di noia da collezionare. I suoi fidanzati in media duravano due mesi. Vedevamo facce diverse e avevamo volti nuovi da imparare.
Quando da Porto Recanati ci trasferimmo ad Ancona, magicamente gli orizzonti si allargarono. Lei portava a cena le conquiste di una sera presentandoli tutti come parenti acquisiti. Ce li imponeva. Li chiamava tatini: «Questo è vostro zio tatino». Tutti tatino si chiamavano. Erano morti di fame. Teste di cazzo senza coraggio. Impiegatucci in disperata fuga dal tetto coniugale. A casa telefonavano in continuazione e lei sceglieva: «Per questo ci sono, per questo non ci sono». La storia è durata per anni. L’apparecchio a squillare, noi a rispondere, lei a concedersi o a negarsi. A ritoccare la carta d’identità scolorendo la data di nascita. A finire fuori strada perché, sosteneva, «gli occhiali mi invecchiano». A farsi togliere le multe civettando con il vigile urbano per poi vantarsene con noi: «Non è una bella giornata, agente?».
Era una bambina pure lei, che non avendo avuto modo di plasmare i sogni a suo tempo non avrebbe mai potuto fare bene neanche la madre. Non l’ho mai stimata. La commiseravo. È sempre stata una stronza. E da quando suo marito se n’era andato, faceva tutte le cazzate che si possono fare nell’adolescenza.
Quando usciva alle dieci di sera e tornava alle dieci del mattino dopo, noi passavamo la notte a chiamare gli ospedali. La immaginavamo nel fosso con la macchina. La maledivo. Pensavo: «Se devi fare la troia, almeno mettiti con uno ricco». Il peggio venne quando con il fidanzato occasionale giunse il tempo dei weekend amorosi. Ci caricava tutte in macchina e partivamo per le vacanze obbligate. Vacanze mortali. Rotture di coglioni. Finirono quando un giorno io e Mimì ci ribellammo e decidemmo di lasciarla partire da sola: «Madre, noi non veniamo, viaggiamo per i fatti nostri». Non mi dimenticherò mai la sua faccia.
E così, al campeggio, per un intero mese andammo noi. Una delle poche vacanze estive della mia vita con Mimì. Eravamo adolescenti. Gli occupanti delle tende erano quasi tutti tedeschi. Gente simpatica. Parlavo con tutti senza sapere una parola di tedesco e Mimì non riusciva a darsi spiegazioni: «Ma come cazzo fai a farti capire?». Ci riuscivo come ero riuscita a farmi affittare dal campeggiatore per l’intero periodo di vacanza una casetta, una palafitta, una specie di bungalow che mi permetteva di non poggiare la testa sulla terra, consentendomi di dormire in un letto normale. Per gli insetti e per l’eccessivo contatto con la natura ho sempre provato schifo. Pensavamo di spassarcela, ma a Mimì venne un attacco di tonsillite e fu operata d’urgenza. La fuga finì in anticipo ma, nonostante ciò, nelle cure Mimì vide qualcosa di positivo e inatteso: «Non è bello che per guarire debba mangiare solo gelati?». Quasi quasi la invidiavo, perché a casa nostra il gelato era poco meno di un lusso e di consolazioni anch...