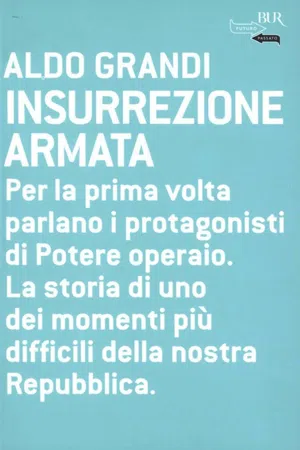![]()
Francesco “Cecco” Bellosi
Sono nato e cresciuto in un paese sul lago di Como, Colonno.
Negli anni Sessanta era la piccola capitale di un faticoso lavoro di contrabbando di sigarette con la Svizzera. Molta gente viveva di quello. Quando andavo in giro e mi chiedevano di dove ero, e io rispondevo che ero di Colonno, il commento scontato diventava: «Ah, il paese dei contrabbandieri». Trent’anni dopo sarebbe diventato il titolo di un racconto che ho dedicato a quella gente. Quando ero piccolo, e nelle sere d’estate giocavamo sulla riva del lago, a una certa ora, e non faceva ancora buio, venivamo richiamati in casa. Noi, in quel momento, eravamo sempre bambini ubbidienti. Iniziava il rito del carico delle barche piene di bricolle verso l’altra parte del lago. Tutto il paese stava all’erta, per segnalare la presenza di qualche burlanda, il nemico che vestiva la divisa della finanza. Quasi vent’anni dopo, due sbirri vestiti da pescatori ebbero la ventura di tampinare due ragazze del paese. In realtà, cercavano notizie su di me, che ero ricercato e latitante. Chiesero alle due ragazze se conoscevano il figlio del sindaco. E quelle: «Perché, il sindaco ha un figlio?». In realtà i figli erano due, in un paese che non ha mai superato i mille abitanti.
Di Colonno mio padre è stato sindaco per oltre vent’anni, e ha abbandonato solo perché stanco e malato: era stato il padre nobile di quel paese un po’ malandrino. Del resto, a ogni mia disavventura giudiziaria, i voti nei suoi confronti, invece di diminuire, aumentavano. Della sinistra socialista lombardiana, aveva la passione politica nel sangue. Mia madre era la segretaria della cooperativa, la Casa del Popolo, che ogni anno distribuiva i dividendi in vino e salamelle di maiale appena ucciso.
Quasi tutte le sere venivano in casa il prete, don Biagio, un uomo di spessore e cultura, irrimediabilmente di destra, e il presidente della cooperativa, il Domenico, un falegname comunista di quelli che non ne nascono più. Io stavo ad ascoltarli appassionato. A sedici anni, per prendere un po’ le distanze, mi iscrissi alla Fgci, ma non facevo vita di partito. Anche se ogni tanto mi esibivano come il ragazzo studioso e per bene.
A diciotto anni giocavo in una squadra di amici di scuola e di paese. Ma eravamo un gruppo, prima che una squadra, che aveva battuto la nazionale degli abatini azzurri.
Il luogo di ritrovo aveva riconosciuto la sua sede naturale nella piazza di Bolvedro, una frazione di Tremezzo. Una piazza vivace con presenze interessanti: i comunisti della sezione che stava in un buco d’angolo; i tifosi del Toro, che avevano proprio lì un nucleo duro; i figli dell’architetto Lingeri, uno dei padri del razionalismo; vecchi partigiani come Michele Moretti, il commissario Pietro della 52° Brigata Garibaldi che aveva partecipato alla fucilazione di Benito Mussolini; artisti decoratori come il Titti o il Barba, che sarebbe andato anche a Cuba a restaurare chiese.
Dopo l’invasione sovietica in Cecoslovacchia, entrai nella sezione del Pci strapiena, per vedere come buttava il dibattito. I dirigenti provinciali volevano imporre la linea del partito. Ma loro, i tremezzini, non mollavano. Volevano costruire un muro attorno a tutta la Cecoslovacchia. Quella era la vera base del partito: assolutamente passionale e intollerante.
A scuola facevo il liceo scientifico Paolo Giovio, in quegli anni la scuola in, frequentata da molti ragazzi e poche ragazze della Como bene. In buona parte iscritti alla Giovane Italia, l’organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano. Ero quindi una mosca bianca. Ma non esistevano problemi: anche a quelli di destra piaceva Fabrizio De André.
La storia cominciò a cambiare a novembre del 1966, dopo l’alluvione di Firenze. A Firenze, nelle caldaie della stazione, pulimmo per un mese i volumi a stampa del ’500 e del ’600. A scuola ci diedero per dispersi, accelerando di brutto il programma. Al ritorno i professori ci trattarono come degli irresponsabili. E questo provocò la nostra ribellione. Nell’inverno del ’67 mi iscrissi all’università Statale di Milano. A febbraio del ’68 ci fu la prima occupazione. Votammo in mille, ma di notte rimanemmo in cinquanta.
Nei mesi successivi, mi avvicinai a un gruppo emme-elle che spopolava in Statale: il Pcdi (Ml)-linea rossa. Ohibò. Entrai nell’Unione della gioventù e fui assegnato al glorioso nucleo vietcong, zona San Siro. Eravamo un bel gruppo di matti. A una manifestazione al consolato americano per protestare contro la guerra in Vietnam, dopo le prime cariche della polizia, cominciammo a tirare sassi, rimediati in un cantiere, contro i celerini. E furono scontri.
Nei giorni successivi, il partito ci mise sotto inchiesta per deviazione avventurista e militarista. Di lì a qualche mese, alla fine di una manifestazione sindacale, su decisione del partito, andammo all’Assolombarda. Ci venne dietro un sacco di gente. E, davanti all’Assolombarda, partirono delle cariche violentissime da parte della polizia. La mia ragazza venne arrestata, io presi un bel po’ di botte e altri compagni si ritrovarono decisamente malconci.
Eravamo neri di rabbia.
Nell’estate del 1969, con alcuni compagni reduci da quella poco esemplare esperienza, andai in Calabria. Eravamo mossi dalla curiosità e dalla voglia di capire. Ci avevano detto che l’Unione dei comunisti (marxisti-leninisti), fondata da Aldo Brandirali, stava radicandosi con un lavoro efficace tra i contadini. Brandirali era un personaggio interessante, a fronte dei grigi burocrati che animavano i cadaveri degli altri gruppi emme-elle. Di rude origine operaia, era stato il vicesegretario nazionale della Fgci, ai tempi di Achille Occhetto. Ma aveva molto più fascino. Tanto da sconfinare nel culto della personalità.
A Vibo Valentia non trovammo i quadri dell’Unione nelle campagne con i contadini, ma rinchiusi in alcuni tuguri ammuffiti di sedi di partito. Ci fecero le solite prediche sulla linea giusta, salutammo con cortesia e ce ne andammo. Prima di congedarci, però, il giovane burocrate di cento anni ci aveva detto: «Noi siamo dei militanti comunisti, non dei banditi come quelli del movimento studentesco romano, Scalzone, Piperno...». Quel termine, banditi, mi suonò decisamente attraente. E così, quando un compagno di Como, trovato da quelle parti, mi disse che in spiaggia si stavano tenendo dei seminari interessanti sulle lotte autonome di primavera alla Fiat, trovai un buon motivo di curiosità da soddisfare.
Conobbi Oreste, e la mia vita cambiò. Tra noi fu simpatia immediata, frequentazione intensa, arrivederci a settembre a Milano.
Avevano infatti deciso di fondare Potere operaio e di aprire l’intervento nella città della nebbia e dei panettoni, dove la presenza degli operaisti era decisamente scarsa, ridotta a una piccola aristocratica cerchia di intellettuali.
A Milano dominava il movimento studentesco di Capanna e Cafiero, una paccottiglia di stalinismo reale e di maoismo di maniera, mentre i loro antagonisti, quelli di Avanguardia operaia, affondavano le radici nella tradizione trotzkista.
Cominciai una dura e affascinante educazione sentimentale davanti alle fabbriche. Autobianchi, Alfa Romeo, Pirelli Bicocca, Farmitalia, Face Standard, nomi in parte ancora vivi, in parte scomparsi con l’avvento del postfordismo. Si cominciava prima delle sei del mattino, per finire alle dieci di sera. Discussioni con gli operai in entrata e in uscita, volantini, capannelli. D’inverno, spesso accanto a dei fuochi accesi con le cassette della frutta.
Neanche fossimo delle puttane.
Si parlava di ritmi e di tempi di lavoro, di organizzazione delle lotte, di salario, di aumenti uguali per tutti. E, anche, di violenza operaia. I miei compagni valorizzavano le lotte autonome, insistevano sul concetto di operaio massa, affermavano il senso politico delle lotte. Mentre buona parte degli altri gruppi rimaneva ferma ai contadini cinesi.
Capivo che Toni Negri e gli altri avevano ragione, erano gli unici capaci di leggere quanto stava succedendo. Ma parlavano difficile e scrivevano come filosofi tedeschi. Feci non poca fatica per tradurre dentro di me quei linguaggi. A Como meditava un gruppo di intellettuali, anche operai intellettuali: più grandi di me, avevano seguito e partecipato a tutta l’evoluzione dell’operaismo, dai «Quaderni Rossi» a «Classe Operaia». Mi rifornirono di tutto quel materiale teorico, su cui passavo intere giornate. E, finalmente, la nebbia si diradò.
Quasi tutti, fino ad allora, avevano visto il comunismo come invidia di classe, i ricchi che dovevano diventare poveri; e i poveri che dovevano produrre trattori per altri poveri. Ad ascoltarli, gli emme-elle, il movimento studentesco, ma, poi, anche le Brigate rosse, avrebbero riempito l’Italia di trattori. Per coltivare il Cervino. Invece quelli di Potere operaio e, in modo meno sfrontato, quelli di Lotta continua, raccontavano che gli operai dovevano avere salari alti, sempre più alti, la macchina per poter inquinare impunemente, la casa con l’affitto autoridotto. Tutta un’altra storia.
La mia vita in quel periodo si divideva nella militanza tra la sede di Milano e quella di Como, l’università solo per dare gli esami, qualche ritorno a casa a trovare i miei, a rivedere i vecchi amici, a uscire con qualche ragazza. Chissà cosa pensavano di quella mia vita. Sempre di corsa, sempre con lo stesso eskimo poco innocente, qualche veloce panino. Perché la vita viveva ormai nelle lotte. E nelle manifestazioni, sempre più violente. Nel corso dell’autunno del 1969 presi tre denunce, tutte per gli stessi reati: violazione di domicilio, danneggiamento, oltraggio e resistenza. Era la dura legge dei picchetti, degli scontri di piazza e della caccia ai crumiri. Poi sarebbe arrivata l’amnistia.
No, i nostri eskimo non erano innocenti prima di Piazza Fontana. Troppo facile e autoassolutorio attribuire alla strage la nostra torsione verso la violenza e le armi. La ricerca conosceva già l’atto. Piazza Fontana fu però il corto circuito che accelerò la corsa in maniera vorticosa.
Dandoci maledettamente ragione.
Il 12 dicembre 1969 non fu tutto subito chiaro. Alla prima manifestazione per Pino Pinelli ci trovammo neanche in mille, nulla rispetto alle manifestazioni di solo qualche settimana prima. Uno choc tremendo, per tutti. Nell’ombra agiva un drago. La verità cominciò ad affiorare, poco a poco, grazie alle controinchieste, anche quella di Lotta continua: la sua campagna non fu solo maniacalità contro il commissario Calabresi, ma rivelò capacità e tenacia nella ricerca delle cause e delle origini della strage.
Quelle trame, più che nere, sembravano bianche, quindi più pericolose. «Agli italiani non far sapere quanto sono bianche le trame nere», urlava uno slogan coniato dagli stessi fascisti. Non troppo infondato.
O volevano fare un colpo di stato o volevano cacciarci in clandestinità; il che, per molti aspetti, era la stessa cosa.
Nei giorni successivi a Piazza Fontana venni convocato dai vertici di Potere operaio. Dicevano della possibilità di spostare in Svizzera redazione e stampa del giornale: sapendo delle mie conoscenze nel mondo dei contrabbandieri, non volevano trovarsi impreparati di fronte alla necessità dell’espatrio. Questo era il clima, per nulla paranoico. Un’unica marea nera lambiva le coste di Portogallo, Spagna e Grecia; in Francia la svolta gollista si presentava come autoritaria; in Turchia agiva un regime militare. Nello scacchiere mediterraneo, solo l’Italia non risultava ancora allineata a quell’aria pesante. Ma sembrava solo questione di tempo.
Le indagini su Piazza Fontana puntarono dritte verso gli anarchici, cercando però di coinvolgere altri ambienti della sinistra rivoluzionaria. In particolare, una persona che con la produzione di libri e pamphlet antimperialisti e filoguerriglieri, dava particolarmente fastidio: Giangiacomo Feltrinelli. Lo volevano prendere a tutti i costi, anche se non esisteva alcun indizio contro di lui. La sua foto campeggiava maliziosamente allusiva sui giornali.
Il 30 dicembre mi chiamarono: un compagno doveva essere portato in Svizzera, ma non immaginavo minimamente chi potesse essere. La cosa si fece il primo dell’anno, di pomeriggio. Arrivarono al cimitero di Muronico, il primo paesino della Val d’Intelvi, alcuni dirigenti di Potere operaio con un personaggio bardato come uno sciatore d’epoca e il passamontagna calato sulla fronte. Mi sembravano tutti nervosi. Noi eravamo in tre: io, il Cinto, un capo contrabbandiere mio amico che conosceva bene tutti i passaggi in Svizzera, e un altro compagno. Nei giorni precedenti avevamo deciso per un tragitto piuttosto facile, ma la neve caduta proprio in quelle ore ci costrinse a cambiare percorso. Saremmo passati da Lanzo, aggirando la dogana e scendendo in Val Mara. Lì avremmo trovato gli altri, entrati senza problemi da Chiasso. In Val Mara, oltre alla dogana svizzera, c’erano soltanto un benzinaio e un’osteria. Dentro il locale, ormai al sicuro, davanti a una buona grappa ticinese la persona che avevamo accompagnato si tolse il passamontagna.
Ci salutammo alla stazione di Mendrisio, dove prese un treno per Zurigo. Sorridendomi, mi disse: «Ci rivedremo presto».
Era Giangiacomo Feltrinelli.
In realtà, il primo appuntamento con lui clandestino, militante dei Gap, fu dopo l’estate del 1970. Da allora, la frequentazione divenne intensa. Quando, dopo la sua morte, venne ritrovata la sua agenda, magistrati e poliziotti furono incuriositi da un nome che tornava spesso negli appuntamenti: Cocco Bill. Me lo aveva attribuito lui, con l’ironia di cui era capace: suonava come un anagramma del mio nome e cognome. Cocco Bill. Cecco Bellosi.
Ma non arrivarono a me.
Per tutta la prima parte del 1970 continuò la mia educazione politica ai cancelli delle fabbriche, ai coinvolgenti seminari su Marx tenuti alla Casa dello Studente da Ferruccio Gambino e Giairo Daghini, persino con gli esami alla facoltà di Filosofia, dove il programma un po’ fuori dalle righe andava dai Manoscritti del 1844 fino ai Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica. Lungo tutta la traccia di sviluppo dell’eresia operaista. Cominciai però anche a occuparmi in maniera stabile del servizio d’ordine alle manifestazioni, il cui nucleo più consistente e affidabile era costituito dai compagni di Como. Nell’estate venne a Milano Valerio Morucci, per tenerci un breve corso intensivo sulla confezione delle bottiglie molotov a innesco chimico. Diventai un bravo allievo. Valerio si muoveva già allora, di fatto, da capo militare di Potere operaio, anche se non era stata ancora formalizzata la costituzione di Lavoro Illegale.
Nel 1970 ci fu anche un tentativo di unificazione con il Manifesto, nel corso di un convegno tenuto, non a caso, in un circo. Non ho mai capito che cosa centrassimo noi con quei puristi comunisti snob, che non solo non si sarebbero mai sporcati le mani, ma non si sarebbero nemmeno mai macchiati l’abito bianco. Quel matrimonio innaturale durò lo spazio di un mattino, forse anche meno.
Durante l’inverno si intensificarono i rapporti con i Gap e la corsa verso l’armamento: Giangiacomo veniva spesso nella casa in cui abitavo, in Via Buschi. Lo stesso stabile dove, anni dopo, venne trovata la tipografia milanese delle Br. L’appartamento era di un compagno ritenuto da tutti affidabile, intellettualmente preparato, anche se piuttosto pasticcione sul piano pratico: Carlo Fioroni. Alcune sue stranezze, come andare al lavoro con una vecchia Glisenti scarica nella borsa, ci sembravano soltanto una forma esasperata di militanza. In realtà, gli anni successivi ci dissero che si trattava di una persona mentalmente disturbata. E infame. Per la sua responsabilità nel sequestro e nella morte di un amico, Carlo Saronio, prima ancora che per il suo “pentimento”, che ha portato in carcere decine di persone. Spesso innocenti, anche se non è il mio caso.
Carlo Saronio era un ragazzo di una dolcezza e di una timidezza inaudite. Alto e magro, lo chiamavamo con affetto “il salice piangente”, per la sua tendenza a incurvarsi e la tristezza che attraversava il suo sorriso. Ingegnere, apprezzato ricercatore dell’Istituto Mario Negri, apparteneva a una delle famiglie più ricche di Milano. Arrivato a Potere operaio attraverso un suo vecchio compagno, aveva subito costruito un rapporto di amicizia con alcuni di noi. La sua ingenuità appariva disarmante e strepitosa. L’unico vezzo alto borghese, in una semplicità spartana, erano le automobili. Aveva una Porsche e un Giulia 1600 super. Una volta dovevo andare di fretta a Torino con la Cinquecento per portare dei volantini a una manifestazione, ma rimasi a piedi. Lo chiamai, per chiedergli in prestito la macchina. Mi disse: «Se hai fretta, ti conviene prendere la Porsche, va più forte». Gli chiesi se avesse idea di che cosa voleva dire presentarmi a una manifestazione di comunisti incazzati con un’auto del genere: una brutta fine per la macchina e per chi ci stava dentro. Andai così con il Giulia, che non rappresentava comunque il massimo per l’occasione, provando l’ebbrezza di una velocità folle con la scusa di arrivare in tempo. Al ritorno, feci una strada provinciale: provando una ripresa, sbandai sulla ghiaia ai lati, andando a finire in mezzo ai tavoli di una trattoria imbandita per un matrimonio.
Per fortuna, senza danni per nessuno.
Una sera d’inverno, con Oreste, vedemmo prima Giangiacomo e poi Carlo Saronio. Terminate le due riunioni, dovevamo prendere l’ultimo tram. Il biglietto costava settantacinque lire. Frugando nelle tasche, riuscimmo a mettere insieme centoventi lire: non avevamo nemmeno i soldi per salire. Oreste mi guardò e disse: «Ti rendi conto? Siamo stati finora con due delle persone più ricche di Milano, forse d’Italia, e dobbiamo fare la colletta per il biglietto del tram. Ma non mi cambierei con nessuno dei due: sono troppo tristi». Già, l’infelicità di una ricchezza vissuta come un macigno da portare sulle spalle. E un prezzo pesantissimo da pagare, con una morte drammatica. Così diversi, così uguali.
Con i Gap il rapporto stava diventando sempre più intenso, forse troppo. Portammo dalla Svizzera gli apparecchi tedeschi che avrebbero permesso le trasmissioni di Radio Gap, una nuova, grande intuizione di Feltrinelli. Sei anni prima delle radio libere. Dieci anni prima di Silvio Berlusconi. Per la rivoluzione, non per le proprie tasche. Diffondevamo i volantini degli attacchi ai cantieri del lavoro nero. Poi Giangiacomo mi chiese di portar fuori due fucili mitragliatori. A questi livelli non potevo più ragionare con il Cinto. Sicuramente un amico, ma non volevo coinvolgerlo in queste storie.
In quel periodo avevo conosciuto un personaggio interessante, Silvano: frequentava lo Psiup di Como, ma non perdeva occasione per chiedermi di rendersi attivo. In quel periodo il silenzio parlava.
Nella sua vita aveva fatto, in modo molto personale e riservato, il contrabbandiere. Poi aveva aperto uno studio di disegni per tessuti. Silvano, che da allora sarebbe diventato Siro, conosceva una precisione maniacale. Acquistò, e fece acquistare ad altri compagni, la NSU Prinz (con me non ci riuscì, era troppo brutta), funzionale ai nostri scopi. Smontando i fanali posteriori, ci stava un fucile.
Ma non un M16. Erano i fucili mitragliatori usati dagli americani in Vietnam: troppo lunghi, e non riuscivamo a smontarli. Alla fine, facemmo l’unica cosa che non andava fatta. Uscire con i due M16 sotto il sedile. Ci andò bene. Non potevamo deludere Giangiacomo, che ci aspettava in Viale Sarca, a Milano. Arrivammo disinvolti: il sudore del passaggio ce lo eravamo tolto lungo la strada.
Nell’estate del 1971 andammo a Saint Vincent: prima un gruppo di romani, poi noi di Milano. Giangiacomo ci aveva affidato un’inchiesta per studiare la possibilità di una rapina al Casinò. Ai romani toccò ovviamente la ricognizione interna, con divertimento annesso; a noi quella esterna, con levatacce prima dell’alba e ore e ore passate con i binocoli su una collina per cogliere i momenti di passaggio del denaro. Capimmo tempi e modi dei movimenti, preparai una relazione dettagliata. Al ritorno a Milano dopo l’estate, incontrai di nuovo Giangiacomo. Venne all’appuntamento con due libri sui Tupamaros, il gruppo guerrigliero ...