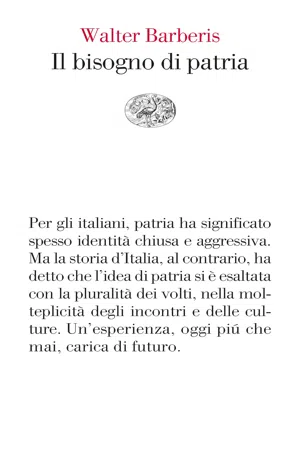1. Ragioni individuali e «reductio ad unum».
Cosa sia la nazione italiana, chi sia l’italiano, se vi sia un carattere italiano sono interrogativi che forse è bene lasciare alla molta letteratura che si è esercitata sul tema. Ai fini nostri, tutt’al piú, vale la pena di ricordare che quando si trattò di disegnarne un profilo unitario, quando tra la fine del Settecento e il corso dell’Ottocento si avviò il gran movimento che doveva portare gli italiani all’unità politica e istituzionale, molti uomini di pensiero e d’azione dissero la loro. Ovviamente, ciascuno a suo modo, per gettare le fondamenta di un uomo nuovo su quel tanto di antico che ciascuno degli italiani chiamati in causa portava con sé. Chi li voleva «arditi», chi «virili», o «frementi», senza dubbio di piú alto sentire, meno inoperosi, pusillanimi, ambigui. Carlo Cattaneo, con grande realismo, li sapeva differenti fra loro, gli italiani, e diversi da altri popoli; e non si faceva scrupolo di dire che non sarebbe stato facile modellare una nazione nuova come se fosse stata di cera. Non a caso si devono proprio a lui le uniche riflessioni non peregrine sul tema di un eventuale federalismo italiano. Con altri accenti Vincenzo Gioberti dichiarava l’inesistenza dell’italiano e segnalava la pluralità come un tornante assai duro da superare per imbastire il discorso unitario: un conto era il «presupposto», il «desiderio», il «nome»: altro erano la «cosa», la «realtà». Come fare a ricomporre l’Italia che fin lí era stata sí «congiunta di sangue, di religione, di lingua scritta ed illustre; ma divisa di governi, di leggi, d’istituti, di favella popolare, di costumi, di affetti, di consuetudini»?
In effetti, sembrava meno facile che altrove costruire per gli italiani un edificio unitario che oltre ad una cornice giuridica sapesse dare una comune coscienza di sé e una condivisa volontà di azione. Non era come per gli inglesi che per primi si erano dati un inno nazionale nel 1742, tenuti insieme dall’insularità e da consuetudini millenarie; né come per i francesi, che la Marsigliese e il tricolore se li erano conquistati rovesciando per sé e per gli altri un’intera epoca; e neppure come per quei popoli sui bordi della grande storia che si contentavano di un modesto profilo autonomo, fatto magari di piccole cose inventate, come il kilt e la cornamusa per gli scozzesi. La situazione degli italiani era assai piú complicata. Erano diversi, lo dicevano pressoché tutti. La qual cosa era preoccupante, naturalmente, perché dichiarava difficoltà, impotenza persino: comunque qualcosa di storto, o sfortunato, difficile da rimettere in sesto. Manzoni se ne lamentava moltissimo di questa opinione diffusa: scriveva al Lamartine che all’Italia «il n’y avait de mots plus dur à lui jeter que celui de diversité», poiché era chiaro che con quel termine si voleva richiamare «un long passé de malheur et d’abaissement».
Le voci erano molte e di tonalità differente in quel giro d’anni; sembravano tuttavia accordarsi quando dicevano delle prime soluzioni da adottare per educare gli italiani. Mazzini sopra tutti parlava di rinuncia all’egoismo individuale. Gioberti di superamento della «patria municipale», dove da sempre «casa, famiglia, parenti, amici, poderi, traffico, industria, clientele, cariche, reputazione» erano un tutt’uno in cui si confondeva ampiamente il bene comune con la piú viscerale difesa del bene proprio. E a cose fatte, dopo l’Unità, l’indice puntato di Massimo d’Azeglio non cambiava direzione: erano lo spirito settario, la ricerca di un tornaconto personale – le «dappocaggini e miserie morali» che erano state ab antico la rovina degli italiani – il vero nemico del «dovere», cioè la risposta necessaria a un bisogno generale.
Riflettendo sul carattere degli italiani, Benedetto Croce avrebbe detto mezzo secolo dopo: «Qual è il carattere di un popolo? La sua storia, tutta la sua storia, nient’altro che la sua storia». Aderendo a questa affermazione, vale forse la pena di approfondire se non il carattere degli italiani, almeno quella sorta di inclinazione all’interesse privato che spesso ha fatto dubitare della loro morale. Lasciamo dunque i padri della patria a mezzo dell’Ottocento e risaliamo a quei momenti che modellarono definitivamente e senza grandi differenze di latitudine questo tratto fisiognomico degli italiani.
La data è una debolezza dello storico. Anche in questo caso, per dire di uno spirito patriottico mai attecchito, defunto ancor prima di nascere; o se si vuole, per sottolineare il momento di fondazione di ciò che via via è stato definito particolarismo, opportunismo, dissimulazione, trasformismo, mancanza di senso dello Stato, di date se ne possono proporre alcune. Ad esempio il 29 agosto 1494, quando Carlo VIII re di Francia lasciò Grenoble per dare inizio all’invasione dell’Italia; o il 9 novembre successivo, quando Piero de’ Medici, grazie alla facile avanzata delle armate francesi, fu costretto ad abbandonare Firenze alla sua esaltante stagione repubblicana. Oppure il 16 settembre 1512, allorché i Medici rientrarono signori a Firenze uccidendo la repubblica. O ancora l’anno dopo, durante il quale Niccolò Machiavelli, sconfitto ed esule, esemplarmente scrisse il Principe e abbozzò i Discorsi, infiggendo il palo principale di tutta la riflessione storico-politica italiana. O altrimenti quei due giorni tremendi, il 5 e 6 maggio 1527, in cui i lanzichenecchi di Carlo V misero a sacco Roma e costrinsero papa Clemente VII in Castel Sant’Angelo. Aleatorie, come lo sono in fondo tutte le storie di un giorno o di un anno, queste date segnalano tuttavia quel particolare momento in cui l’Italia perse l’occasione di darsi un sovrano e uno Stato, di mantenersi autonoma dall’influenza straniera, cioè di camminare su un percorso analogo a quello di altre piú solide società europee. Quelli, come scrivono gli storici, furono gli anni che segnarono la fine della libertà italiana, che avrebbero lasciato la Spagna padrona del campo italiano.
Fu in quel torno di tempo che la straordinaria esperienza delle città italiane esalò il suo ultimo respiro; in quei frangenti convulsi di storia europea, sulla scena dello scontro epocale tra le strategie di dominio di Francia e Spagna, il grande vantaggio accumulato sul piano economico e culturale dalle tante realtà cittadine italiane, già fiorenti di ricchezza e maestre di bel vivere, si trasformò nella debolezza di altrettanti frammenti incapaci di una risposta comune alla forza dei grandi potentati stranieri. Prigioniere dell’antica e proficua rivalità dei bei tempi andati, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, con il ricco corredo di Urbino, Mantova e Ferrara, Pisa e Siena, Palermo e Messina e ancora cento altre magnifiche realtà cittadine consumarono le loro gelosie nell’incapacità di trovare una dimensione di alleanza e di governo. Sospesi fra vecchie prospettive di autonomia locale e nuove sudditanze alla signoria di una famiglia, gli italiani non seppero andare oltre il riconoscimento della piccola patria nella quale erano nati e cresciuti; e per quella e dentro quella, combattere le loro lotte di fazione e di campanile.
Su ogni fronte e in ogni luogo di quell’Italia divisa e dominata, i piú grandi intellettuali, coloro che provarono personalmente a calcare le scene della politica internazionale, tutti sconfitti, lasciarono alla riflessione dei contemporanei, e alla nostra, il piú importante corpo di scritture postume, cioè di riflessioni su una realtà già irrimediabilmente compromessa. In quei filmati d’epoca, cioè nei testi di Machiavelli e Guicciardini, Castiglione, Bandello, Aretino e Della Casa, per dire soltanto di alcuni fra i piú noti, vennero fissate in nitidi fotogrammi le fisionomie dei gruppi dirigenti italiani.
Parlando di Firenze, già posta come semplice sfondo scenografico di una novella, Bandello non poteva fare a meno di alludere a quella felice stagione in cui la città stava «in grandissima pace e tranquillità» poiché immune dalle lotte di fazione che dilaniavano il resto della penisola: «essendo quasi tutta Italia piena di sètte e di parzialità». Prima che le «parti e divisioni» segnassero anche la sua condanna. Non era storia, erano parole di maniera, senza dubbio: ma il tema non era d’invenzione. D’altra parte, la figura del funzionario politico di alto rango, l’uomo di corte auspicato da Baldesar Castiglione nel Cortegiano, colui che avrebbe dovuto affiancare e consigliare il principe, non aveva trovato interpreti in quell’Italia senza principi di prima grandezza, in cui naufragava anche il momentaneo splendore delle corti di provincia che avevano illustrato il costume italiano fra Quattro e Cinquecento. L’uomo colto di lettere, ammaestrato nella conduzione degli affari diplomatici, esercitato alle armi, di tratto gentile, informato a un ideale di equilibrio e di misura, se mai c’era stato, ora sicuramente non c’era piú. In quegli anni Trenta del Cinquecento, secondo la descrizione dell’Aretino, le corti italiane erano «spedale delle speranze, sepoltura delle vite, baila degli odii, razza de l’invidie, mantice de le ambizioni, mercato de le menzogne, serraglio dei sospetti, carcere delle concordie, scola de le fraudi, patria de l’adulazione, paradiso de i vizi, inferno de le virtú, purgatorio de le bontà e limbo de le allegrezze». E pochi anni dopo, Sabba da Castiglione, nei suoi Ricordi, dipingeva gli uomini di corte come «vili, ignoranti, adulatori, assentatori, parasiti, lenoni, per non dire ruffiani, malcreati, buggiardi». In somma, non girava piú una opinione molto alta delle aristocrazie italiane. Machiavelli, d’altronde, aveva avvertito nei Discorsi che non c’era da illudersi: l’Italia era piena di gentiluomini che «oziosi» vivevano «delle rendite delle loro possessioni abbondantemente, senza avere cura alcuna di coltivazione o di altra necessaria fatica a vivere», tipi «perniziosi in ogni repubblica e in ogni provincia», che affollavano «il regno di Napoli, Terra di Roma, la Romagna e la Lombardia», signori che comandavano «a castella», isolati fra i loro servi e incuranti d’altro che non fosse la sfera del loro interesse. Certo non erano quelli a cui si poteva chiedere l’immaginazione e lo sforzo di una impresa comune, a loro che erano con tutta evidenza «inimici di ogni civiltà» e ostacolo, appunto, «ad alcuno vivere politico».
Se quella era la società italiana, in effetti, anche coloro che avevano coltivato le piú ardite illusioni dovevano arrendersi. Anche uno come Guicciardini, che aveva difeso a oltranza le ragioni e le prospettive delle migliori aristocrazie cittadine contro le ipotesi di una monarchia, sempre in odore di sconfinare in tirannia, o di una repubblica, troppo soggetta agli appetiti del popolo, doveva ritrarsi dalle ipotesi di un tempo. La situazione, nel volgere di una trentina d’anni, era totalmente e definitivamente cambiata: l’ideale equilibrio, il giusto mezzo, il canone a cui attenersi con buon senso e un’attenta educazione, la «regula universalissima», cioè la «sprezzatura» tanto cara al Castiglione, erano tutti arnesi inattuali. Era proprio lui, Guicciardini, a farne cenno nei Ricordi: «È grande errore parlare delle cose del mondo indistintamente e assolutamente e, per dire cosí, per regola; perché quasi tutte hanno distinzione e eccezione per la varietà delle circunstanze, le quali non si possono fermare con una medesima misura: e questa distinzione e eccezione non si truovano scritte in su’ libri, ma bisogna le insegni la discrezione». In sostanza, in un contesto senza riferimenti fissi, senza una guida politica, senza uno Stato, senza una morale generale a cui attenersi, senza un corpo giuridico a cui guardare con occhio comune, valeva la norma di comportarsi secondo le opportunità del luogo e del momento. Valutando, appunto, con discrezione. In fondo, sosteneva ancora Guicciardini, non vi era «nessuna cosa cosí trista che non abbia del buono, nessuna sí buona che non abbia del tristo»; sicché era d’uopo «pesati gli inconvenienti di ciascuna parte, risolversi a quelli che pesano manco; ricordandosi non potere pigliare partito che sia netto e perfetto da ogni parte».
In altri termini, in quel giro d’anni non soltanto l’Italia perdeva l’occasione di darsi uno Stato e di ricondurre le molte realtà particolari a una strategia nazionale; ma anche gli intellettuali che piú avevano discussa la questione, inoltrandosi nel secolo che sanciva la prevalenza delle moltissime aristocrazie locali, che vedeva la rincorsa a un qualche titolo nobiliare da parte di molti ricchi mercanti, che in somma riproponeva la rendita fondiaria e la vita sulla terra come ideali supremi dopo che l’Italia aveva insegnato a mezzo mondo come emanciparsi da questi ceppi feudali, ebbene proprio gli intellettuali abbandonavano ideali e utopie e decretavano che farsi gli affari propri con adeguata accortezza era la via maestra.
Giovanni Della Casa, con il suo Galateo, si proponeva come massimo esponente di questa ideologia. Altro che belle maniere. Il suo dettato avrebbe fatto furore ben al di là di quel contributo all’incivilimento della società europea che Norbert Elias e molti suoi epigoni gli hanno generosamente riconosciuto. Il perno dell’argomentazione del Casa era tutto in un avverbio: «mezzanamente». Anche la discrezione non era piú sufficiente; l’obiettivo dichiarato era mimetizzarsi fra gli altri, «temperare e ordinare i tuoi modi non secondo il tuo arbitrio, ma secondo il piacer di coloro co’ quali tu usi». L’Italia a cui guardava era questa, fatta di paesi diversi, da rispettare senz’altra intenzione che quella di piacere e compiacere: «perciocché ogni usanza non è buona in ogni paese; e forse quello che s’usa per li Napolitani … non si confarebbe per avventura né a’ Lucchesi né a’ Fiorentini». Non un problema morale si affacciava ormai dalle pagine di monsignor Della Casa: «non dee esser mia presente cura il trattar della natura de’ vizii e delle virtú»; ma soltanto convenienze, mimesi, opportunismo, adesione all’«usanza comune», la conquista di un rango onorevole, la messa al sicuro della propria privatissima esistenza.
Non erano ancora consigliati sotterfugi; ma in questa Italia ormai cortigiana di principi stranieri, polverizzata nei mille volti dell’interesse particolare, sarebbero presto arrivate anche le teorie in materia. Un altro manuale di abilità politica, splendido ed eloquente fin dal titolo, Della dissimulazione onesta, ad opera di Torquato Accetto, avrebbe cifrato la cultura italiana del secolo XVII.
Se vi aggiungiamo la restaurazione della Chiesa romana, ripresasi in forze dopo gli scossoni riformatori dei primi del secolo, certamente non incline a favorire la comparsa di una monarchia nazionale, cioè di una autorità laica concorrente al governo della penisola, abbiamo raccolto prove sufficienti per capire come si sia fatta congenita in Italia una certa cultura privatistica e antistatuale.
Peraltro, quando questa partita era già chiusa, post res perditas, non erano neppure comparsi sull’orizzonte italiano coloro a cui la storia avrebbe affidato il ruolo di salvatori, o piuttosto di fondatori, della patria. Emanuele Filiberto di Savoia metteva piede in Piemonte soltanto nei primi anni Sessanta del secolo XVI, non senza recalcitrare e recriminare per quelle Fiandre che avrebbe di gran lunga preferito alle spogliatissime terre avite. Volendo giocare con le date, anche quello del trattato di Cateau Cambrésis, in effetti, fu un anno buono. Da lí, il 1559, prendeva le mosse la storia italiana della dinastia dei Savoia; per meglio dire, una storia che sarebbe corsa parallela con quella italiana, di fatto senza mai incontrarla davvero sino ai fatidici frangenti ottocenteschi che avrebbero portato alla tarda istituzione di una monarchia nazionale.
Questa prospettiva divaricata ha una qualche importanza e sarà conveniente tenerla in debito conto.
Da un lato, infatti, alla estrema periferia italiana, nasceva uno Stato dinastico nel quale confluivano le piú diffuse idee di monarchia e di bene pubblico; in cui erano chiare la centralità del sovrano, la sua autorità e supremazia, la sua doppia dimensione privata e pubblica. Non che Emanuele Filiberto e i suoi successori avessero il fascino dolente del Riccardo II di Shakespeare; ma sapevano bene che in loro convivevano la natura umana del monarca e la natura divina della corona, ovvero erano ben fermi nella convinzione che la mortalità del sovrano non metteva in forse la tendenziale immortalità della regalità. E ben presto lo fecero credere anche ai loro sudditi, che da quell’idea trassero piú di un beneficio. In effetti, quei principi cosí lontani dagli stilemi gentili modellati nelle corti italiane, anzi dal tratto rude e militaresco, imbrigliarono circa settemila feudatari in una politica centralistica, che tuttavia seppe contemperare interessi particolari e strategie di Stato. Patti e privilegi punteggiarono il rapporto fra sovrano e sudditi: la terra, il feudo, le insegne nobiliari con i punti giurisdizionali inerenti non scomparirono; semplicemente, vennero scambiati con il denaro necessario a sussidiare politiche pubbliche. Cosí si irrobustí una burocrazia centrale, puntualmente fatta di apparati fiscali, giudiziari e militari; cosí crebbero carriere nei ranghi dell’amministrazione, che contribuirono a consolidare l’idea di una doppia convenienza, privata e pubblica, nel sottostare a logiche statuali; cosí, in un clima tutto sommato avaro di beni materiali e di esteriorità, crebbe quell’elemento fiduciario che fu sempre alla base di ogni strategia economica e politica. La certezza delle istituzioni, la loro continuità, la prospettiva di durata della dinastia, il suo radicamento territoriale, fecero ciò che non conobbe il resto d’Italia: assicurarono i sudditi che le loro iniziative erano possibili, che avevano i requisiti minimi di riuscita, primo fra tutti il tempo, garante eccellente di ogni contratto.
Ma non solo. Il Piemonte, selvatico e periferico, non aveva conosciuto gli splendori della civiltà comunale e signorile; o almeno, non nelle forme della piú celebrata tradizione italiana. Quel sintomo di una passata arretratezza ora si trasformava in un punto di vantaggio. Non vi erano sostanzialmente città dominanti, patriziati urbani in contrasto con gli uomini delle terre. Non vi erano territori sottomessi, luoghi minori mortificati; la relazione fra il centro del potere e le periferie dello Stato era semplice e diretta, senza mediazioni che non fossero previste e definite dentro una piú generale ragione pubblica. Considerate tutte le imperfezioni del sistema, gli accidenti del caso, gli errori di strategia, gli antagonismi di ceto e i conflitti interpersonali, questo dice qualcosa della tenuta delle istituzioni sabaude; che cedettero per una quindicina d’anni soltanto alla straripante potenza di Napoleone. E infatti non furono simpatia, garbo e cultura; ma senso dello Stato, tecnica amministrativa e militare, e anche un certo patriottismo, il bagaglio eccentrico con cui poi i piemontesi si disposero all’incontro con gli altri italiani.
I Savoia, la reductio ad unum seppero concepirla e in buona misura realizzarla. Non si trattò certo di consenso fra governo e governati, né di qualche altra illusoria armonia socio-istituzionale. Semplicemente lo Stato piemontese sembrò rappresentare con sufficiente credibilità quella persona ficta, quell’astrazione giuridica, nella quale pareva possibile contemperare il «particolare» di molti interessi privati con il «generale» di un accettato interesse pubblico.
Altrove, in forme apprezzabilmente diverse, ma sostanzialmente nel segno della dominazione straniera o della difesa di ogni piccolo privilegio e autonomia, la storia italiana prese una direzione differente. E proprio la fiducia, ovvero la mancanza di fiducia, fu l’elemento decisivo. Anche principi di prima grandezza non riuscirono a superare la loro vecchia condizione di signori d’una città o di feudatari di una terra; spesso estranei ai loro domini, raramente riuscirono nel compito di mediare fra interessi diversi dal proprio. Spesso, per non dire quasi sempre, le burocrazie si dimostrarono ostili e lontane. In quegli uomini e in quelle istituzioni gli italiani non ebbero fiducia. Anzi, a quella rappresentazione dell’interesse pubblico, a quelle mille malcerte idee di norma, opposero un affinato esercizio dell’abuso e della deroga. La mappa di questi rapporti farebbe giustizia di ogni pregiudizio geopolitico. Ma chiaramente, dove la dominazione straniera fu piú costante nel tempo e i gruppi dirigenti locali piú deboli, come nel Mezzogiorno, la distanza fra potere e sudditi si avvertí con maggiore crudezza. I colti, gli osservatori piú attenti, ne erano pienamente consapevoli. Paolo Mattia Doria, attorno al 1710, scriveva nel suo Della vita civile che la fiducia era il cardine degli Stati e il nutrimento della loro stabilità; in un’opera piú circostanziata, le Massime del governo spagnolo a Napoli, lamentava che l’arte di governo della corona castigliana si fosse riso...